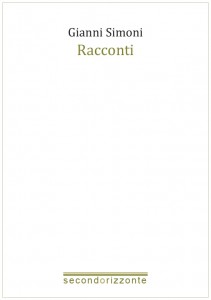Sentì battere alla porta i due colpi convenuti.
Doveva rimettersi il cappuccio. Lo fece con fatica perché ogni movimento con la mano destra le procurava una fitta di dolore. La manetta collegata con la catena infissa al muro le aveva provocato una profonda escoriazione al polso, che non riusciva a rimarginarsi.
Sentì i passi dell’uomo che entrava e si avvicinava al letto.
Trattenne il respiro e si tranquillizzò solo sentendo i rumori consueti: il vassoio che veniva posato sul tavolo e il secchio vuoto sul pavimento.
L’uomo indugiò un momento e lei trattenne di nuovo il respiro. Poi i passi si allontanarono e sentì lo scatto della serratura.
Erano trascorsi nove giorni dal suo rapimento.
“Ti ho portato il pranzo” disse l’uomo: “devi mangiare”.
Parlava un discreto italiano, con una leggera inflessione dialettale che non riusciva a riconoscere, pur non sembrandole del tutto nuova.
Era la seconda volta che le veniva rivolta la parola.
La sera del rapimento aveva udito più voci, secche, concitate, cattive.
Le davano ordini: “stai giù, non parlare, non muoverti, se gridi ti rompiamo il collo”.
Poi più nulla, se non le istruzioni di infilarsi il cappuccio ogni volta che sentisse battere due colpi alla porta.
Incominciò a tremare e quando si sentì sfiorare il capo da una mano ebbe un sussulto e si rannicchiò contro la parete, le gambe raccolte sotto il mento, gli occhi serrati sotto la stoffa nera che sapeva di rancido e le dava conati di vomito.
L’uomo sbuffò e si udì il rumore della porta che veniva richiusa.
Non l’aveva sentito uscire.
“I tuoi non si decidono a pagare, spero che non facciano i furbi, mi dispiacerebbe per te,” disse l’uomo.
Luciana Lucchi rabbrividì sotto il cappuccio e non rispose.
“Perché non hai mangiato oggi?” chiese ancora l’uomo.
“Non vogliamo trovarci un cadavere tra i piedi, non sappiamo che farcene e poi”, fece una piccola pausa, “ io non voglio farti del male”.
Aveva pronunciato le ultime parole a voce bassa, tanto che lei non era certa di avere capito bene.
“Che tempo c’è fuori?” domandò improvvisamente e mentre lo diceva si rese conto che questo l’uomo non se lo aspettava, ma in quel momento le sembrava che la cosa più importante fosse sapere com’era il tempo fuori.
“Piove”, rispose l’uomo.
La ragazza immaginò la pioggia che cadeva, una pioggia leggera perché non l’aveva sentita. Poi si rese conto che non aveva mai sentito alcun rumore dall’esterno e per la prima volta provò a pensare alla sua prigione, a cosa vi fosse al di là delle pareti della stanza.
Si chiese se si trovava nel sotterraneo di un edificio o in un casolare isolato. Se il casolare si trovasse in pianura o in montagna, o vicino al lago dove si trovava la villa.
Si era quasi dimenticata dell’uomo, che non si era mosso.
“Piove ormai da tre giorni” aggiunse dopo un lungo silenzio. “Ciao”.
Dopo che l’uomo se n’era andato, ripensò alla sua voce: era stato gentile e l’aveva salutata.
Per la prima volta si addormentò tranquillamente.
Per il sequestro di Luciana Lucchi era stato arrestato Mario Bianchini, custode della villa, un ex operaio dell’azienda che in un incidente a una pressa aveva perduto un braccio e si era ritrovato invalido a meno di quarant’anni. Ma Antonio Lucchi, ultimo di una stirpe di industriali, non era uomo da lasciare un suo dipendente in mezzo alla strada.
Assolto per l’infortunio, aveva mandato a chiamare Bianchini e gli aveva offerto la guardiania della sua villa di campagna, una sinecura praticamente, compensata con alloggio e con uno stipendio che sarebbe parso giusto anche per un uomo sano.
Bianchini aveva accettato e si era trasferito con moglie e figli nella casetta del custode, vicino alla casa padronale che si trovava in un’ampia proprietà a una ventina di chilometri, non lontana dal lago. L’impegno che gli veniva richiesto era davvero minimo e si riduceva ai due mesi estivi, quando la villa veniva usata. Per il resto dell’anno badava un po’ al giardino, anche se vi erano un paio d’uomini per i lavori pesanti, e si limitava a tenere gli occhi aperti, perché i furti, nella zona, erano abbastanza frequenti e venivano particolarmente prese di mira le case ricche non abitate.
In tre anni non era però mai successo niente e se non fosse stato per quel braccio, alla cui mancanza non si era ancora abituato, il Bianchini poteva quasi considerarsi un uomo fortunato.
Quello che aveva insospettito era stato il fatto che la giovane Lucchi, che si era recata alla villa con un amico, in stagione morta, aveva preannunciato al custode la sua intenzione qualche giorno prima, telefonandogli e chiedendogli di accendere il riscaldamento, senza dir nulla a suo padre naturalmente.
Il Bianchini aveva dovuto ammetterlo, e non avrebbe potuto negarlo dal momento che per riscaldare completamente la grande casa occorrevano un paio di giornate, così come aveva finito con l’ammettere che anche l’anno prima, più o meno alla stessa epoca, la signorina aveva già fatto un’altra scappatella in villa e lui le aveva tenuto bordone.
Quella sera l’aveva sentita arrivare e aprire il cancello: poi delle grida e il rumore di due macchine che partivano sgommando.
Il ragazzo, uno studente fuori corso di architettura, di un paio d’anni più giovane di lei, non aveva visto invece nulla. Una botta in testa e si era trovato per terra e quando aveva riaperto gli occhi, la moglie del custode, china su di lui, che lo chiamava.
Adesso sembrava più preoccupato delle rimostranze del Lucchi che della sorte della ragazza e, semmai, mortificato per non aver saputo difenderla.
I rapitori comunque dovevano essere perfettamente informati, perché in quella stagione nessuno della famiglia frequentava la villa e la signorina, aveva confermato il Bianchini, era solo la seconda volta che ci veniva. Qualcuno aveva dovuto per forza aver fatto la soffiata e, volendo essere realistici, non poteva trattarsi che dell’amico della ragazza o del custode.
Naturalmente era stato arrestato il custode, ma neppure Petri, rileggendo il rapporto della squadra mobile, si sentiva di condannare la scelta.
Bianchini aveva cocciutamente negato una sua complicità e se non fosse accaduto qualcosa, non si vedeva come la sua incriminazione potesse reggere. Su questo conveniva anche il collega che seguiva l’indagine per la procura e che Petri riteneva, qualche volta, piuttosto disinvolto.
Il fatto nuovo avvenne nel tardo pomeriggio di un mercoledì, quando Petri si recò al carcere per interrogare una seconda volta il custode, quasi un adempimento burocratico gli pareva.
Le indagini della polizia sembravano a un punto morto.
C’era stata una prima richiesta telefonica dei rapitori e poi il silenzio, che ormai durava da quasi due mesi. Non restava che attendere, confidando nelle intercettazioni sui telefoni di casa Lucchi e della ditta, sperando, si diceva Petri, che nel frattempo la ragazza non fosse già stata eliminata.
Chi non poteva più attendere era invece Bianchini, in carcere da oltre quaranta giorni e in una posizione che sostanzialmente, Petri continuava a pensarlo, non si differenziava da quella dell’aspirante architetto.
Continua la lettura nel pdf: