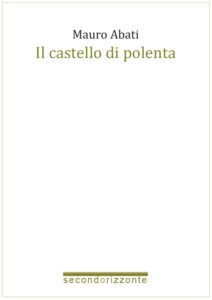
Era ferito, gettato nella neve; un fuciliere nascosto dietro le rupi colpì la sua discesa. La bianca uniforme degli alpini sciatori, sporca del sangue, puzzava di sudore e di febbre. Riverso e privo di sensi, col tempo l’alito bollente e l’ipertermia avevano scavato la buca nella neve fresca, sciogliendo l’arrossato candore, e pian piano il corpo vi s’era infilato per semplice gravità; alla fine sporgevano solo le gambe, come due monconi sui quali sferzava il vento.
Dopo la battaglia, in ricognizione per ritirare i cadaveri, la pattuglia sulle prime lo diede per morto. Ma risvegliato dal vociare e dal trafficare dei barellieri, sentendoli dire (non senza l’ironia dei sopravvissuti) “Guarda questo come s’è messo”, in qualche modo riuscì a lanciare segnali, un urlo, un rantolo, muovendosi un poco nel gran dolore, e finalmente lo conobbero per vivo, quel giovane alpino dell’Adamello infossato nella neve. Era il 1917. Il soldato riuscì a guarire e ad aver figli e nipoti. Io sono uno di questi ed il fatto me lo raccontò lui stesso, ormai vecchio e incavalierato dell’ordine di Vittorio Veneto.
Era dunque il 1917 e nella Russia preda della crisi economica e dell’avanzata del nemico (lo stesso nemico degli alpini dell’Adamello) avevano già sloggiato lo zar e si rincorreva una rivolta dietro l’altra; mio nonno aveva 22 anni. Dopo il ferimento fu congedato. A guerra finita, non avendo lavoro, emigrò in Svizzera e lì lavorò sotto un mezzo parente; presto, però, ebbe da ridire per via che quello, che, dopo un matrimonio con una facoltosa del posto, aveva messo in piedi una fabbrica, obbligava i dipendenti a rifornirsi di cibo nello spaccio da lui stesso condotto e a vivere in alloggi di sua proprietà, detraendone i non modici costi dalla paga mensile. Così mio nonno non stette molto in quelle contrade; si trasferì in Francia ma poi tornò in valle a lavorare da capomastro nei cantieri.
Da qualche anno qui tirava aria di socialismo e anche il sindaco di Gardone era stato ridotto al confino essendosi opposto, nel ’15, all’entrata in guerra. “Imola lombarda” era chiamato Gardone sui giornali del tempo, in riferimento alla cittadina emiliana, patria di un forte movimento socialista e pure del primo eletto di quel partito nel Parlamento del Regno, Andrea Costa, per un po’ d’anni compagno di Anna Kuliscioff.
Insomma, mio nonno, dopo i patimenti di una guerra combattuta a tremila metri di quota, in grotte di ghiaccio e con la minaccia della fucilazione per i disertori, s’avvicinò al socialismo e si prese la tessera del partito. D’indole insofferente e schiettamente anticlericale, nel ‘19 si schierò con i massimalisti contro i riformisti di Filippo Turati (l’altro uomo della Kuliscioff). Insieme ad altri costituì una cellula rivoluzionaria a Bovegno (un paese di duemila abitanti, la metà minatori), cellula che aderì alla mozione comunista già dal congresso di Livorno del ’21. Fausto, mio nonno, e i suoi tre fratelli erano una buona parte del piccolo gruppo sovversivo, in tutto undici uomini e una certa frangia giovanile di nuova leva. Dopo il biennio rosso, gli scioperi agrari e l’occupazione delle fabbriche tra ‘19 e ‘20 all’insegna del “Faremo come in Russia”, però, facendo sponda sulla crisi economica, la reazione capitalista ormai riconquistava terreno. Le elezioni di quell’anno diedero un brutto colpo agli inconcludenti socialisti. Per parte loro, i comunisti di Bovegno dovettero decidere quale posizione sostenere: la linea gramsciana del centralismo democratico, che voleva la partecipazione alle elezioni, o la linea bordighiana del centralismo organicista, invocante invece l’astensione rivoluzionaria, ma che si era meritata un’invettiva direttamente da Lenin col pamphlet “L’estremismo malattia infantile del comunismo”? La questione era se in Italia esistesse o meno, nei fatti, un terreno pronto alla rivoluzione proletaria. A Bovegno i comunisti scelsero Gramsci, parteciparono alle elezioni e presero 52 voti sui 100 di tutta la valle: nel loro piccolo si difesero bene, ma nell’insieme furono uno sputo nel Mella.
Quando il fascismo s’impose, i quattro fratelli non mancarono d’essere al centro d’una certa persecuzione a base di botte, perquisizioni domiciliari, olio di ricino e qualche giorno di galera qua e là, tanto che Giovanni decise di andarsene a Marsiglia e di lui non si seppe più niente per molti anni; poi giunsero notizie d’un suo matrimonio con una ballerina spagnola, ma infine la sua vicenda si perse nell’abisso.
Maffeo, durante la prima guerra era stato fatto prigioniero dagli austriaci e quando tornò era malato e ostile verso un po’ tutto, ancora più schivo e riottoso di quanto non lo fosse di carattere. Restò celibe e non ne so niente di più.
Natale, a lungo ricordato anche nei paesi vicini come gran bevitore e amante di baldorie, era il più giovane di tutti e il più assiduo nella militanza. Durante la Resistenza fu parte del Cln della valle, poi trascurò la politica attiva e si trasferì al Carmine di Brescia con tutta la famiglia. Mio padre mantenne a lungo contatti con loro e io stesso ricordo l’affollata, vociante e fumosa osteria in via Capriolo gestita da un cugino.
Il 25 aprile del ’45, Fausto, mio nonno, uscito a vedere come si mettevano le cose tornò a casa con un moschetto recuperato chissà dove, come fosse stato un partigiano della prima ora. In realtà non sembra avesse rivestito un ruolo particolare nella Resistenza e giudicherei ammissibile solo qualche coinvolgimento nella propaganda clandestina, probabilmente nel retrobottega di qualche osteria. Passò qualche anno prima che venisse rinvenuta una pistola nel cassetto del tavolino che oggi io uso come scrivania e può darsi che quell’arma costituisse il suo modesto contributo ai preparativi rivoluzionari conseguenti all’attentato a Togliatti.
Di fisico gagliardo, come certo si è già intuito, anche lui non disdegnava le bettole e quand’esse chiudevano, non di rado la sua compagnia si spostava a casa obbligando mia nonna a lasciare il letto e servire da mangiare a tutti, sobri o ubriachi.
La pistola fu perduta o gettata, il cappello d’alpino collocato in una vetrinetta del gruppo sezionale dell’Ana. Il ritratto del nonno, compiuto secondo uno stile vagamente concettuale anni Settanta, con l’immancabile pipa e la nuvola di fumo, opera giovanile di un mio cugino acclamato pittore, riposa in qualche angolo di chissà quale cantina.
Io lo ricordo passeggiare in paese o nella camera d’ospizio salutarmi con enfasi come stesse iniziando un discorso pubblico, orgoglioso che, nella mia piena adolescenza, mi lanciassi in qualche tentativo poetico, degno nipote d’un uomo che si vantava dell’eleganza della propria calligrafia.
Lui stesso aveva in ammirazione i poeti, in particolare lo scapigliato Lorenzo Stecchetti, nei componimenti del quale rinveniva una sorta d’imprimatur alla propria verve anticlericale. A quel tempo l’ospizio era ancora condotto da suore e lui non si esimeva dal declamare i testi più pungenti alla madre superiora, accompagnandosi con i tozzi gesti di un braccio semi anchilosato in seguito ad una caduta sulle scale in stato di ebrezza.
In particolare ricordo lo stile laconico, ma in fondo autoreferenziale, con cui recitava a memoria alla suora “Il castello di polenta”, ombrosa gouache nella quale si compara il feudatario che sfrutta la plebe e il prete che s’approfitta delle contadine.
Mio nonno era mio nonno, ma negli anni più recenti ho visto mio padre assomigliargli sempre più man mano invecchiava: gli zigomi e la fronte tondeggianti, il mento piccolo, gli occhi ormai acquosi ma chissà come attenti, piccoli nel cranio sempre più simile a un teschio. Ma ormai mio padre ha già superato di qualche anno la già rispettabile età alla quale il nonno morì.
A parte l’episodio del ferimento al tempo della guerra, con me Fausto si astenne dal raccontare delle sue vicende giovanili, delle rincorse rivoluzionarie in un men che periferico tassello della grande geografia del mondo, delle polemiche, dei rimedi per campare un po’ meglio, delle miserie ordinarie, dei giochi di specchi e degli specchi per le allodole, e d’altra parte ero forse troppo giovane per capirle o per ricordarle. Le notizie le ho raccolte invece da mio padre e da qualche libro di storia locale, nel quale i nomi dei parenti punteggiano qua e là una schiuma umana che sa di terra e fogliame in decomposizione.
La raccolta “Postuma” di Stecchetti, significativamente sottotitolata “Il canto dell’odio e altri versi proibiti” mi capitò tra le mani ad una bancarella di libri usati; la comprai e così potetti meglio conoscere, a distanza di anni, ciò che mio nonno leggeva. Forse lui non venne mai a sapere che anche dietro il nome di quel poeta tanto amato si nascondeva un altro gioco di specchi, giacché Stecchetti non era che uno dei tanti personaggi di fantasia di cui si nutriva l’opera bizzarra di Olindo Guerrini, il quale invece passava per solo curatore del florilegio. È invece molto probabile che il gancio, se così si può dire, che decisamente lo prese al cuore, fosse stato l’ultimo capoverso, di sapore socialisteggiante, del “Saluto” dal Guerrini aggiunto all’edizione del libello del 1903: “Giovani, a voi! Non sdegnate di raccogliere questa bandiera ch’io credetti di verità nello scrivere, di libertà e di giustizia nel vivere. Raccoglietela da queste povere mani, stanche ma fedeli, deboli ma non vili, e portatela voi, migliore e più bella, in alto in alto, nella radiosa gloria dell’avvenire! Addio!”
Ironia degli addii, il funerale di mio nonno non fu celebrato con rito civile, come lui avrebbe voluto, per via di un’intesa, più di sguardi che di parole, tra la suora dell’ospizio e due mie zie, sue figlie, sfacciatamente perbeniste.
novembre 2017
Non sapevo di questa storia di nostro nonno.. Ma in realtà non sapevo niente, di lui, della sua vita, nemmeno della vita dei nostri genitori so molto. E in fondo neanche della nostra vita di fratelli.. Nonno Fausto se n’e andato che ero una ragazzina e non ha lasciato un particolare vuoto in me. È bello ora rileggere queste storie, non tanto perche parlano di lui ma perché mi parlano di te. Grazie, Fiorella