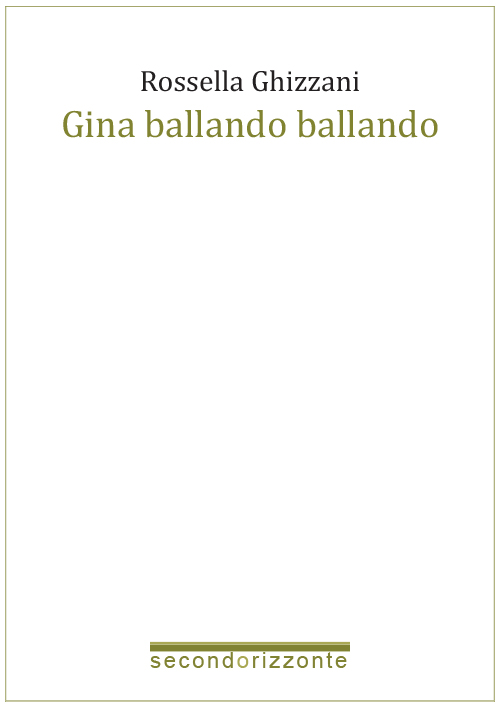
Per Gina, perché forse è andata così.
Precipito.
Una forza incontrastabile mi spinge all’indietro: sono investita dal getto potente di una sistola che sputa aria, non acqua. Aria. Mi attraversa la mente questo particolare da niente, mentre mi sento portare via.
Arretro scomposta, le braccia e le gambe spalancate, la schiena inarcata in avanti. Cerco di proteggermi, tengo gli occhi serrati, ma quel soffio non mi lascia scampo. Arretro.
Che troverò dietro di me? Volteggiassi almeno, mi desse spinta quest’aria feroce per sollevarmi un po’ e guardare cosa mi passa accanto. Ma no, non c’è niente da fare, volo all’indietro, terrorizzata dal vuoto che avverto alle mie spalle.
Intuisco sporgenze intorno a me, radici, arbusti, ma niente possono le mie mani.
Il pensiero di afferrarmi scivola insieme a me, scompare prima che uno solo dei miei muscoli riesca a farmi stringere le dita intorno al vecchio tronco che pure ondeggia e si piega, strapazzato dal vento che mi porta. I polsi infiammati. Ramoscelli frondosi li frustano al passaggio.
Spalanco gli occhi. Gina, dove sei? No, niente, un sogno, solo un sogno. Così reale che nelle orecchie ho ancora il frastuono di quella massa d’aria, gli arti indolenziti e le dita delle mani contratte.
Le guardo, mi ricordano le zampe della gallina con queste unghie ritorte e piegate in avanti.
Come mai non me le sono tagliate?
Adesso mi alzo, devo aver sudato, mi sento umida e anche le lenzuola sono bagnate.
Adesso mi alzo.
Perché non riesco a muovermi?
La paura mi gela, sento un vuoto che mi spalanca la pancia. Ricomincio a sudare, terrorizzata dalla mia immobilità. Nella testa prende forma la voragine in cui precipitava il mio sogno. Posso girare la testa, ci vedo, intorno a me riconosco gli oggetti di sempre. L’armadio bianco a quattro ante, la sedia di legno, il cuscino ocra, e sul ripiano del comodino, qui vicino a me, un cartoncino plastificato, riconosco la mia scrittura. Ascolta Gina, lo abbiamo scritto, ti ricordi? Foglietto giallo a righe, inchiostro rosso. Dov’è? Non me lo ricordo dov’è, ma sono sicura che avevamo appuntato con precisione tutte le operazioni da fare per scendere dal letto. Aspetta, è la mano destra quella che si muove. Ecco, mi è tornato in mente. Con la destra afferro il foglietto giallo. Ora leggo, eseguo i movimenti e poi via, a vedere che ci aspetta, a rinnovare questo giorno appena cominciato.
Ma che dico? ma come parlo? Il giorno appena cominciato… come una signorina… Niente chiacchiere invece, devo sbrigarmi, se torna a casa e non è tutto pronto, me lo fa vedere lui, il giorno appena cominciato. Quando lui rientra tutto deve essere a posto.
Caspita, devo ancora cucinare.
Lui, che vuoi che ti dica, è fatto così, lui.
Mi ha sposata perché a casa sua avevano bisogno di una che tenesse in ordine la casa e gli uomini che la abitavano: lui, suo fratello, suo padre, che gli aveva affidato il compito di trovare una brava ragazza.
Non fece storie quando venne a prendermi. Allora lavoravo a servizio presso una delle famiglie benestanti del paese. Aveva chiesto ai miei padroni il permesso di portarmi fuori, si faceva così da noi alla fine degli anni cinquanta.
Un bel giovane, uno del paese… praticamente neanche lo conoscevo. E’ diventato mio marito perché una sera mi ha spinto contro un muro.
Avevamo fatto due passi, neanche parlato; lui, ah lui, fra una sigaretta e l’altra aveva borbottato qualcosa.
Ma che fa? Sbottonati il cappotto, dice. Poco meno di un ordine. Ma che vuole?
Con quel freddo, me lo sono trovato addosso, sulla schiena la parete ruvida su cui mi aveva spinta. Si sgancia un solo bottone. Una mano appoggiata al muro dietro di me, per sostenersi. L’altra ad afferrarmi i fianchi, per spingermi il bacino contro.
Una sensazione di freddo e poi dolore, un’esplosione dentro di me. Credevo che mi avesse uccisa.
Mi aveva solo messa incinta. Ecco, sono diventata donna in mia assenza.
Quando era venuto a chiedere il permesso di uscire mi brillavano gli occhi. A ballare, sì! Mi avrebbe portata a ballare! Ho sempre adorato ballare, era come se la musica mi passasse dentro i muscoli, non potevo stare ferma.
Ma lui a ballare non mi ci ha portata mai. E’ fatto così, che ci vuoi fare.
Ehi! Oh! Cosa!
Mio marito non mi ha mai chiamata per nome. Mai.
Non ero nessuno, e quindi il mio nome non contava.
Ehi! Oh! Cosa.
Questo ero. Una cosa. Lavavo, stiravo, pulivo, cucinavo, partorivo i figli e li crescevo.
Tre ne ho messi al mondo. La mia gioia, la forza che mi davano quei tre pupi.
Gli insegnavo a chiamarmi mamma. Mammammamma. Uno alla volta imparavano, e io ero la loro mamma, non una cosa.
Lui usciva presto, tornava a casa per pranzare e per cenare. E per salirmi addosso ogni tanto, di sera.
Mi ammazzavo di fatica, ma quei tre tesori, nati a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro, mi davano speranza. Appena avevo un po’ di tempo, via a giocare con loro, si faceva il teatro dei ballerini…
Lui non se ne curava. Solo, non voleva sentire rumore.
Quando tornava, la sera, facevo in modo che dormissero già.
Ma a volte non bastava. Se anche uno solo si svegliava, se uno solo piagnucolava o si lamentava nel sonno, lui spalancava la porta della loro cameretta e li minacciava.
Ho da andare a lavorare io! sbraitava in dialetto, facendoli piangere forte.
Non ci volle molto perché cominciasse a usare le mani.
Mi mettevo in mezzo, tanto per lui era uguale: uno valeva l’altro. Quel che aveva da fare era prendere a botte le sue cose quando lo irritavano. Quando non si comportavano esattamente come lui aveva disposto. Quando non stavano ferme nel posto che lui gli aveva assegnato. Quando dicevano parole che non gli erano gradite.
Che potevo fare io?
Ballavo, giravo intorno al tavolo finché lui non riusciva a prendermi.
Ballavo.
Caspita, non me lo ricordo mai.
E’ così ogni nuovo giorno, non riesco mai a rammentarlo subito.
Sono libera, ah Gina? Lui non c’è più, e io ballo per tutto il tempo che desidero.
Neanche il sogno che mi instrada al risveglio, neanche quel volo pauroso riesce a evitarmi la ricerca della verità con cui, ogni mattina, devo fare i conti.
Ma ci pensi? Prima mi era sufficiente un solo movimento di busto spalle e bacino, et voilà, ero seduta sul bordo del letto, i piedi già poggiati per terra. Incredibile. Mi sembrava un fatto scontato, normale, non certo un prodigio di cui meravigliarsi. Una volta alzata stavo in piedi, e senza sforzo sapevo mettere un piede davanti all’altro e camminare. Ci pensi? Camminavo ogni volta che volevo.
Adesso? Adesso ballo.
Sì, lo so, ho perso tempo, mi sono decisa tardi a farmi vedere da un medico.
Tempo. Ah! Me lo ricordo bene. Lui era morto e io finalmente possedevo tutto il mio tempo.
Caspita, non ci avrei rinunciato per niente al mondo.
E poi, lo hai sentito anche tu, è stato chiaro il dottore: una volta comparsa, la malattia non si ferma…
E allora? Tardi per cosa?
Te le ricordi le prime avvisaglie? Avevo cominciato a dimenticarmi piccoli dettagli, cose da nulla, di tutti i giorni. Ma sì… Perdevo il cordless, non riconoscevo qualcuno, mi scordavo dove tenevo le tazze per il caffè. Ma finché potevo camminare cercavo, e alla fine riuscivo sempre a recuperare tutto. Ricordo che mi sentivo un po’ impacciata nei movimenti, e non capivo come mai le dita delle mani e dei piedi sussultassero. Piccoli scatti, come per caso, ma molte volte al giorno.
Non volevo arrendermi.
Mi vergogno un po’ a dirlo: per la prima volta da quando ero al mondo, vivevo una vita che mi soddisfaceva pienamente.
Così facevo finta di nulla.
Lui non ci risparmiava. Bastava un errore. Ci afferrava le spalle e ci sbatteva contro il muro, tante volte, tante, fino a quando non ci vedeva diventare lividi in volto, il fiato mozzato.
Posso dirlo? Una bestia
Poi si ammalò. Te lo ricordi? La malattia lo rese ancora più cattivo perché dipendeva da me.
Stupido bastardo, pensavo.
Me ne occupai. Provvedevo a tutto, efficiente e gelida, e gli ridevo in faccia.
Aveva mille motivi per prendersela con me, ma a picchiarmi non ce la faceva più; mi fermavo davanti a lui, lo fissavo mentre cresceva la sua rabbia. Mulinava le braccia, ringhiava e sputava, ma prendermi non poteva più. Gina, eh, te lo ricordi? Seria in volto ballavo e facevo tutto quello che lui mi aveva sempre proibito.
Ogni mattina, andavo al bar a bere il caffè. Piano piano mi feci qualche amica con cui uscivo ogni tanto per andare a ballare sul serio. Ma ci pensi! Dancing, milonghe, sale da ballo…
A quasi sessant’anni scoprii la città, il cinema, le librerie, i palazzi del centro, l’arte delle chiese.
Cominciai ad essere me. E le scarpe, te le ricordi Gina? Raso di seta rosa con sette centimetri di tacco… Ah Gina, quasi mi vergogno… figurati, a quell’età.
E poi lui è morto, e io non ho più smesso di ballare.
Da quando non riesco più a muovermi e nemmeno a parlare, vivo in una realtà che appartiene solo a me. Certo, so ancora dove sono. Questa è la mia casa, vedo quella giovane donna cui i miei figli mi hanno affidata che si muove in queste stanze, le riordina, mi lava, mi sposta, mi nutre. Ma il mio silenzio la zittisce, non mi parla mai. D’altronde io sono chiusa dentro di me, più spesso ferma in un ieri lontano che nel giorno che c’è.
Non è esatto dire che penso. Sono visioni che ho, così reali da sembrarmi presenti, vere.
Alla fine è meglio così.
E’ stato più difficile da affrontare il periodo della motilità lentissima, come dicono i dottori, per non parlare di quei gesti a scatti. Non ci si può credere, non controllavo più né braccia né gambe. Il mio corpo mi faceva la guerra, si scatenava contro di me, mi puniva per quel desiderio tardo di musica e di libertà. A volte mi bloccavo, te lo ricordi, le braccia tese in avanti, i polsi e le mani che giravano, mentre – ferma sul posto – le ginocchia si piegavano e tornavano dritte un sacco di volte, il busto oscillava avanti e indietro e i fianchi si dimenavano scomposti di qui e di là.
Còrea, si chiama così la mia malattia. Deriva dal greco, mi han detto, significa danza.
Ah sì, pensavo, è questo che vuoi? E allora tieni, tanto non mi avrai. Imparavo ad esistere dentro di me, e ballavo.
Gina ballando, ballando… come quella canzone…
Lo so, lo so che ti preoccupi. Ma io sto bene, stai tranquilla.
Lo so, mi è rimasto solo un filo di voce.
Ma credimi, dentro di me parlo come non ho mai fatto. Se mi sentisse lui… Ah! Non lo sopporterebbe.
Fuori non mi si intende. Ballo, ma non riesco più a dire una parola. Solo io posso sentirla, la mia voce.
Invece mangiare non posso più. Hai visto come sono diventata magra, anche i liquidi qualche volta non riesco a mandar giù.
Ma quale problema, Gina! Sono leggera come una nuvola e volo in mille giravolte…
Certo, hai ragione, per i vestiti è un problema. Vorrà dire che li faremo stringere un po’.
Te la ricordi la gonna verde con gli spacchi laterali? E i babucha neri, aperti sui lati… Gina, ma ci pensi, chi lo avrebbe mai detto che sarei riuscita a vestirmi così, ad entrare in una sala da ballo, a sentire le braccia di un uomo leggere e senza inganno che mi sostengono, mi guidano, accompagnano i movimenti del mio corpo.
Ogni volta ringrazio il cielo, no, non per averlo fatto morire, ma per avermi liberata dal macigno di esistere appesa a un altro, al tiranno dei miei giorni.
Non mi guardare più, adesso basta parlare.
Ora si balla, Gina. Non ho neanche vent’anni e i miei padroni mi hanno concesso una serata di libertà. Le strade sono ghiacciate e anch’io sono gelata, ma le luci blu di questa milonga mi scaldano la pelle e il cuore. Lui mi vede subito e mi chiede di ballare. E’ un bel giovane, uno del paese, lo conosco appena ma balla benissimo, mi lascio guidare ad occhi chiusi, avvolta dal silenzio delle nostre voci, sospesa nel lamento melodioso della fisarmonica.
Mi sento bene, esile e veloce, una libellula libera, in pace. Davvero, mi sembra di avere le ali, meravigliose ali colorate che mi sostengono mentre volteggio, roteo, salto… Vieni, vieni con me Gina ballando, ballando.
Chiamata d’urgenza, la dottoressa che constatò la morte della signora Gina S., per lungo tempo non dimenticò il movimento scomposto di quel corpo, illuminato da un sorriso radioso soffuso sul volto straziato.