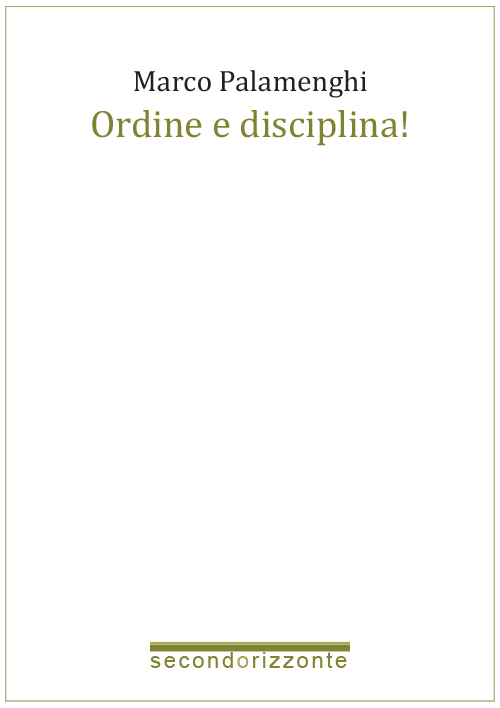
“Sono le tre! Forza! In piedi che dobbiamo andare!”
“Accidenti che freddo, non si direbbe che è giugno.”
Alla luce della lampada frontale controlliamo meticolosamente l’attrezzatura: piccozza, moschettoni, cordini, martello, chiodi, corda, ramponi, ghette, giacca a vento, guanti, berretta, maglione…
“Ok, tutto a posto. Dimenticato niente.”
Verifichiamo ancora una volta mentalmente l’itinerario e i tempi di avvicinamento.
Dobbiamo arrivare alla crepaccia terminale ben prima dell’alba, altrimenti riuscire a passare diventa più complicato.
E in cima dobbiamo arrivare al massimo in un due o tre ore, altrimenti il canalino, con l’escursione termica, potrebbe scaricare. Per il ritorno, nessun problema. Scendiamo dalla “normale”, che è più semplice, e ripassiamo sulla crepaccia terminale dove, se servirà, avremo lasciato un passaggio attrezzato per aiutarci a superarla in discesa. Tutto è pronto. Andiamo.
Crick… crock… crick… crock… Mi piace il rumore dei ramponi che appena appena scalfiscono la superficie ghiacciata della neve.
E poi la luna, quasi piena, ormai avviata al tramonto. Illumina il cammino, riempiendolo delle migliaia di minuscoli scintillii dei cristalli di neve ghiacciata. Non serve nemmeno tenere accesa la torcia frontale.
E il silenzio…. Nessuno ha voglia di parlare a quell’ora del mattino. Sembrerebbe un sacrilegio.
E, passo dopo passo, si va verso la meta.
Non avevo ancora 17 anni, terza liceo scientifico.
Sin da bambino mi avevano definito un “birichino”, accompagnata magari da un bonario “el piö bu dei róss él ga copàt sò pàder en del fòs”.
Da adolescente poi, parafrasando Rousseau, mi definirono un “buon selvaggio”. Sostanzialmente incapace di far male consapevolmente a qualcuno, ma del tutto allergico alla disciplina.
Non ero uno che disobbediva, ma ad ogni ordine un “perché?”. L’obbedienza cieca non mi apparteneva.
Naturalmente per gli insegnanti era mancanza di disciplina, nel comportamento (ma non ero un teppista), nello studio (“se si applicasse con metodo potrebbe fare di più”), nella gestione dei miei spazi (sempre disordinato), scavezzacollo (le ginocchia e i gomiti sempre pieni di croste e graffi).
Ed era proprio vero, non sopportavo la disciplina. Perché non la capivo.
E non capivo l’insegnante di educazione fisica che voleva fare di noi un disciplinato plotone di alunni che marciavano coordinati e atletici.
Noi “di sinistra” lo consideravamo un “fascio”. Chissà se lo era. Sicuramente aveva le idee chiare su cosa riteneva fosse ordine e disciplina e su come fare per piegare i riottosi.
Una cosa ci era evidente: non sopportava quelli di sinistra (ma nella mia classe eravamo veramente in pochi), soprattutto di quella extra-parlamentare (ero l’unico, ma neanche inserito in un gruppo preciso, perché non sopportavo la disciplina di partito), i giocatori di calcio e chi portava la barba.
La prima pecca ce l’avevo, con l’aggravante. La seconda no, ma mi aveva casualmente visto al campo dell’oratorio giocare una delle cinque, disastrose partite della mia vita. Me l’aveva rinfacciato, con tono quasi minaccioso.
E quell’anno mi feci crescere la barba (prima non ci sarei riuscito neanche volendo!).
Avevo anche il difetto che odiavo il “Passooo! (boom) Passooo! (boom)”, che organizzava in alcune lezioni. Ero sempre fuori tempo, rovinando immancabilmente la coreografia.
Iniziò così una guerra silenziosa tra noi.
“Tagliati la barba!”. “No!”. “Bastone di ferro da un chilo!”. E via, un’ora di educazione fisica con il bastone sulle spalle.
“Tagliati la barba!”. “No!”. “Due bastoni di ferro da un chilo!”.
Andò avanti così per diversi mesi. Naturalmente a casa non dicevo nulla, altrimenti mi avrebbero detto “Tagliati la barba!”, visto che anche ai miei non piaceva.
All’inizio della lezione la consueta ingiunzione, esito scontato di una constatazione: la barba non l’avevo tagliata, anzi, cresceva sempre più lunga, folta e incolta.
A lui non l’avevo detto che non mi piaceva giocare a calcio. Andavo in montagna, io. Quell’anno avevo anche iniziato a frequentare il corso della Scuola di Alpinismo del CAI. Ma non erano in molti a saperlo. Era una cosa mia, e dei due o tre amici con cui ci andavo.
Avrei ridotto la mia pena se gliel’avessi detto, scontandone la quota derivante dal fatto che mi credeva giocatore di calcio. Invece non ne ho mai fatto parola. Questione di orgoglio
Avevo imparato da bambino ad amare la montagna.
Mia madre – sempre apprensiva quand’eravamo in città, timorosa che frequentassimo cattive compagnie, tanto da mandarci malvolentieri anche all’oratorio – in montagna, dove trascorrevamo tre o quattro mesi all’anno, si trasformava e lasciava me e mio fratello liberi di scorrazzare, convinta, illusa, che non potessimo correre pericoli.
E’ così che, passo dopo passo, ho conosciuto la montagna, il senso di libertà che mi dava l’andare dove volevo, senza limiti e costrizioni se non quella di tornare a casa in tempo per i pasti, a volte solo per cena, e dai 15 anni poter star via anche due o tre giorni, ma solo se andavo in montagna.
E andarci voleva dire incontrare cacciatori, guardie forestali, bracconieri, bere il latte appena munto dai malghesi o aiutarli a fare il burro con la zangola, scambiare due parole con i contrabbandieri o con qualche escursionista o, ancora più raro a quei tempi, alpinista. Dormire nei bivacchi e nei rifugi insieme a estranei, accomunati dalla stessa passione.
Molti di questi incontri, spesso senza volerlo, mi hanno insegnato qualcosa: sulla natura e la sua bellezza, sulla potenza della montagna, su dove e come andare, sulle disgrazie avvenute tra quei monti, affascinanti ma di cui diffidare, sulla gioia della conquista e il coraggio della rinuncia.
Non so come, ma credo grazie ad uno studente di quinta, ottimo alpinista, che incontravo spesso alla palestra di roccia o nei bivacchi, il professore venne a sapere che non giocavo a calcio ma andavo in montagna, anzi, ad “arrampicare”.
Ma ero comunque di sinistra, e avevo la barba. E non la tagliavo.
E non facevo “Passooo! (boom)”.
Un giorno, a primavera inoltrata, mi presentai in palestra, con la mia barba e una bella sgrobbiatura su un braccio e una gamba.
“Cosa ti sei fatto?”.
“Sono caduto”.
“Dove? per farti una graffiatura così”.
“In montagna, su una lastra di ghiaccio”.
“Ah…” Avevo già la mano sul bastone che stavo, come di consueto, per prendere, quando l’ho sentito dire quello che non mi aspettavo: Vai con gli altri…”.
Mi sono girato. Lui mi guardava, duro: “Cos’hai? Spicciati a raggiungere gli altri”.
Da allora la guerra tra noi è finita. Ho continuato a non fare “Passooo! (boom)” e a non tagliarmi la barba. E lui niente.
Ho sempre pensato che fosse un bastardo, e forse lo era davvero, ma alla fine mi aveva dato il suo rispetto. Gli avevo tenuto testa, e forse lui lo aveva riconosciuto come un merito.
Nei restanti anni scolastici non ci furono più problemi né per me, né per la mia barba.
Ma poi, un po’ alla volta, credo di aver capito che forse la ragione per cui aveva smesso di tormentarmi con la disciplina era un’altra.
Alla fine, forse, aveva vinto un po’ anche lui.
Anche se la disciplina è la montagna che me l’ha insegnata, lui lo sapeva che l’avrebbe fatto.
Non la disciplina fine a sé stessa, ma quella che serve nei momenti importanti della vita.
Io, il disordinato numero uno, quando preparo lo zaino ho una precisione maniacale.
Perché è vero che, passo dopo passo, vado dove voglio, ma è la montagna che dice fino a dove posso permettermi di arrivare, entro quando devo arrivare, qual è il limite che non posso superare.
E il mio corpo e la mia mente, passo dopo passo, si mettono d’accordo con lei e mi pongono limiti, ordine e disciplina. Ogni sgarro sarebbe ben peggio del bastone di ferro che quel professore mi faceva portare. E’ così che il “buon selvaggio” è stato messo in riga.

Mi è piaciuto molto, ti ci riconosco!
Notevole anche la costruzione della struttura del racconto.