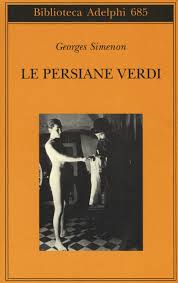
Georges Simenon, Le persiane verdi, Adelphi 2018 (pp. 208, euro 19)
Alto, grosso, a suo modo carismatico: venuto dal nulla, Émile Maugin è diventato un grande attore, popolare al punto da essere riconosciuto per strada, nei ristoranti, nei caffè. La sera a recitare in palcoscenico, la mattina sul set cinematografico.
Simenon ce lo fa seguire in tutti i suoi movimenti, ma anche nei suoi pensieri, nelle sue idiosincrasie, nelle manifestazioni del suo caratteraccio: prepotente, insofferente, violento, quasi compiaciuto della propria protervia egocentrica. E al fondo di tutto: un’insoddisfazione corrosiva, che vino e cognac non riescono a sopire.
Non suscitano empatia il piacere della cattiveria, la brutalità dei comportamenti sessuali, l’instabilità esasperante di questo personaggio. Fino a che, ritiratosi da un giorno all’altro dalle scene, abbandonata Parigi e trasferitosi con la giovane moglie e la figlia (non sua) nel sud della Francia, cominciano ad affiorare in lui i segni di una debolezza che sempre più si rivela essere sempre stata il contraltare della sua mancanza di scrupoli: ha paura di morire, Maugin. Il medico gli ha detto che il suo cuore è quello di un settantacinquenne, non del sessantenne che è. Ma più che la morte in sé è una morte in solitudine che lo terrorizza. La moglie, la villa affittata dalle parti di Nizza, la bambina rappresentano una garanzia in questo senso, ma lui non sa realizzare il sogno di una casa in cui vivere in pace, una casa serena come quelle che si vedono, con le persiane verdi… Il suo destino è segnato: una banale ferita, superficiale ma non curata a dovere, sarà la causa della sua fine.

L’intero racconto appare allora una preparazione della scena finale: l’infezione si è diffusa, la morte è vicina, e tutto è filtrato dal punto di vista del protagonista, ormai perso nelle nebbie di uno stato quasi comatoso e ciononostante attraversato da un ossessivo arrovellarsi attorno alla propria vita, ai torti fatti, alle donne lasciate. Tutti, i genitori, i compagni d’infanzia, il maestro di scuola, le mogli e le amanti, i colleghi e gli amici, il prete e il dottore, tutti sono lì, al suo capezzale: se li vede intorno e sente di dovere a tutti loro, e a se stesso, una riposta, una giustificazione delle sue colpe, ma il bandolo di tutta l’ingarbugliata, confusa faccenda che è stata la sua vita non si lascia trovare. Finché un tratto capace di spiegare le sue scelte, il suo modo di stare al mondo, gli appare chiaro, inequivocabile: “Aveva passato tutta la vita a scappare. Scappare da cosa?” “Aveva fame e scappava dalla fame, Viveva in mezzo al tanfo degli alberghi malfamati e scappava dal senso di nausea. Era scappato dal letto delle donne che aveva posseduto, perché erano solo donne e niente di più, e quando si ritrovava di nuovo solo beveva per scappare da se stesso.”
La ripetizione è la colpa di Maugin, la ripetizione di un gesto di fuga che nell’imminenza della morte non può essere più rimesso in campo.
Le ultime pagine di questo romanzo risignificano le precedenti, e non possono non richiamare quelle, insuperate, dedicate da Tolstoj alla morte di Ivan Il’ic.
