
Björn Larsson, Nel nome del figlio, Iperborea 2021 (pp. 211, euro 16,50)
“Ogni vita umana ha il diritto di essere ricordata e raccontata, ma non tutte si prestano a essere trasformate in letteratura, non tutte meritano di diventare modelli a cui attenersi o da cui scostarsi, a meno che l’autore non aggiunga o sottragga, non si serva della fantasia per raccontare una storia personale capace di convincere e coinvolgere il lettore. In fondo è raro che una vita reale abbia le caratteristiche estetiche ed esistenziali per diventare un buon libro”. Abbiamo di recente letto qualcosa di molto simile: “Non c’è letteratura nei racconti della gente”, diceva Paola Baratto (Malgrado il vento. Racconti, Manni 2021, ne abbiamo parlato qui): sta a chi raccoglie quei racconti, quei ricordi, leggerci ciò che contengono ma non dicono, ciò che solo la sensibilità dello scrittore può intravedervi.
È quello che fa Larsson, nonostante sia ben consapevole di due ostacoli: da un lato il fatto che anche la storia di suo padre è una delle innumerevoli che non ci sarebbe ragione di evocare, dall’altro l’assenza di ricordi, di testimonianze, di documenti: “di lui esistono sei ricordi – pochi momenti che l’autore stesso non è sempre in grado di capire perché gli siano rimasti impressi –, una decina di foto e qualche informazione frammentaria”. Eppure ci si mette: “dovrà reinventarlo nel personaggio di un romanzo per farlo esistere?” Non proprio: il padre resta fino alla fine una figura indistinta, se non nei tratti caratterizzanti (la genialità, e insieme la frustrazione per una vita non vissuta nelle sue potenzialità). Quella che Larsson scrive è piuttosto una lunga interrogazione sul rapporto del “figlio” – così si definisce, scrivendo in terza persona – e il padre, annegato a 29 anni, in circostanze mai del tutto chiarite, durante una gita in barca quando lui, il figlio, era ancora un bambino. Un evento tragico, che tuttavia non l’ha fatto soffrire. Qualcosa gli impediva di rimpiangere il padre, il suo autodistruttivo attaccamento all’alcol innanzitutto, la sua distanza affettiva più in generale.
Senonché, “giunto all’autunno della vita”, alla fine di una brillante carriera universitaria, scrittore affermato, velista appassionato, padre e marito felice, il dolore per quella vita non vissuta non l’ha abbandonato e lo induce a porsi domande ineludibili su quello che dal padre – nonostante ne trovi nella propria infanzia solo tracce labili – ha ricevuto, per via genetica, per via culturale. Il non esser capace di farsi bastare il proprio lavoro, e cercare sempre altro, sempre più in là, forse, lo accomuna al padre, e – ad avvalorare l’ipotesi dell’ereditarietà di un’inquietudine curiosa e produttiva – alla propria figlia. Ma si tratta solo di ipotesi: “che ne sa lui, in fondo? Cosa si può sapere dei genitori e dei nonni oltre a quello che si proietta su di loro?” I dubbi sulla riuscita e, a monte, sul significato del suo proposito di ricostruire, di capire il padre, e per quella via sé stesso, non scoraggiano tuttavia lo scrittore: l’“imperativo genealogico” – per usare un’espressione di Elisabetta Abignente (Rami nel tempo. Memorie di famiglia e romanzo contemporaneo, Donzelli 2021, ne abbiamo parlato qui) – tiene testa con determinazione a un riflessione sull’oblio e la memoria che non arretra neanche davanti alla consapevolezza che anche il racconto che sta scrivendo “finirà nel dimenticatoio, o al massimo nella bibliografia dell’autore”, e del resto “che importanza (avrà) per il padre essere stato immortalato in un racconto frammentario, basato sui ricordi che il figlio ha di lui? Nessuna”. Tutto si riduce al fatto che “A differenza di molti altri che se ne sono andati, quel padre morto annegato aveva procreato uno scrittore. E perciò continuerà a vivere ancora un po’ su questa terra, anche se nemmeno questa è una certezza”: è forse solo un’illusione che la scrittura possa in qualche modo contrastare la transitorietà. Persino aver fatto pace con la morte, come l’autore ritiene di essere riuscito a fare, non gli impedisce di pensare che “La cosa più tragica (…) è che si possa morire senza che nessuno se ne accorga lasciare dietro di sé uno spazio vuoto senza che nessuno sappia a chi apparteneva”.
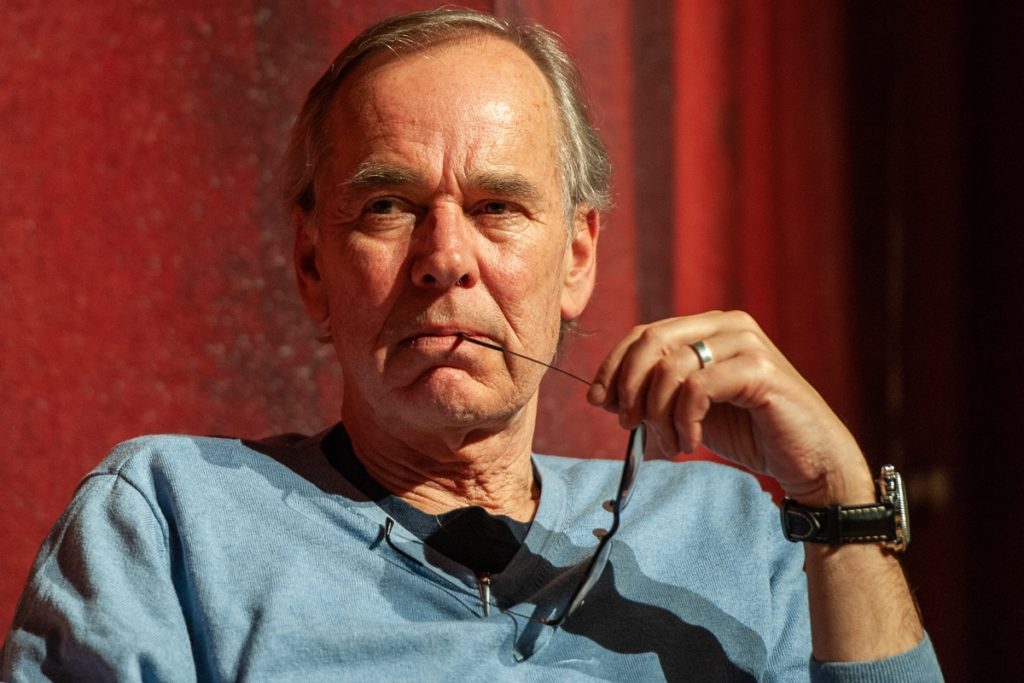
È un bilancio amaro, e tuttavia sereno nel suo lucido realismo, quello che alla fine il “figlio” trae dell’esperienza vissuta scrivendo questo libro: “Quando arriverà il suo momento non dovrà amareggiarsi di aver vissuto una vita diversa da quella che sperava. E il padre non avrà una seconda possibilità solo perché il figlio ha raccontato quel poco che c’era da raccontare di lui”.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.
