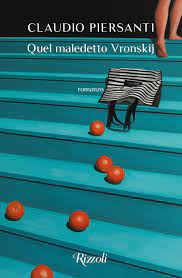
Claudio Piersanti, Quel maledetto Vronskij, Rizzoli 2021 (pp. 240, euro 18)
Certo, sempre di libri si tratta, ma metterli a confronto non ne rivela tanto il contrasto quanto un’eterogeneità così pronunciata da farne oggetti fra loro estranei, imparagonabili perché appartenenti a universi differenti, solo per comodità, e pigrizia, definibili come il vecchio e il nuovo. Eppure, il romanzo di Piersanti è stato tra i finalisti dello Strega 2022 insieme ai romanzi di Veronica Raimo (Niente di vero) e di Mario Desiati (Spatriati), il vincitore.
Fra le tante differenze, quella del ritmo della narrazione, la più evidente forse, non è la principale, ravvisabile invece nel significato e nella funzione che si assegnano al romanzo: tentativo di rintracciare un senso nel raccontare le vite dei protagonisti, facendone un bilancio; volontà di restituire – di esibire, sarebbe forse più calzante – esperienze di vita in itinere, aperte e (volutamente?) inconcluse negli altri due autori. Nei quali si registra – coerentemente, credo, con il loro modo di intendere gli scopi della scrittura, poco incline alle mediazioni e ai distinguo – la tendenza a farsi personaggi, autori di sé medesimi, a fronte dell’atteggiamento schivo dell’autore del romanzo qui segnalato.
Ciò detto, la storia di Piersanti è quella di un amore coniugale, e di una quotidianità che si consuma in un ambiente piccolo borghese (lui è stato un bravo tipografo, un proto di rara maestria anzi, che l’avvento di tecnologie nuove ha dequalificato; lei un’impiegata): la loro vita è fatta di giorni che si susseguono, di gesti che si ripetono; il loro amore di quella cosa solitamente descritta con un’espressione riduttiva, banalizzante: farsi compagnia. Che cosa di meno romanzesco si potrebbe immaginare? A meno che si scelga di raccontare proprio questo: che la ripetizione, al di là di differenze che possono sembrare decisive, è la regola della vita, il suo modo di svolgersi. E la lentezza deve governare una scrittura che si propone di rendere una constatazione simile, la cura del dettaglio, la capacità di resistere al timore di cadere nella monotonia. Perché ci pensa la vita stessa a rompere l’uniformità dello scorrere del tempo: la malattia che colpisce la moglie e la sua decisione, una volta scampatane, di andarsene senza spiegazioni, di scomparire; lo spaesamento e la solitudine del marito, preso oltre tutto dal sospetto che un bellimbusto, fascinoso e seduttore, sia entrato nella sua vita, che un uomo in tutto opposto a quel che è lui, un tipo della stoffa del Vronskij di Anna Karenina (che lei stava leggendo prima di lasciare la casa), lo abbia scalzato dal cuore di lei; poi il ritorno (“Avevano così tanto da dirsi che non si dissero quasi niente”), e la ripresa (lui “aveva un solo desiderio: riprendere la vita dove l’avevano interrotta”), ma “Come tutti sanno, la felicità viaggia a corrente alternata e non è priva di insidie e timori, primo fra tutti quello di perdere i suoi favori”. Fino all’ultima, irrimediabile perdita, ma anche della morte si può parlare “con una strana leggerezza” se si è in due (“Non è così terribile. Forse no. Il corpo sa che il suo ciclo è fornito. Come i fiori, le foglie. Come tutto”). Tanto più se non si è di quelli, i più, che “percepiscono la felicità soltanto quando è passata”, ma come Giovanni se ne ha invece “una percezione esattissima”, nel mentre se ne gode.

Ricorda lo Stoner di John Williams, il Giovanni di Piersanti: la stessa vita semplice, paga di quel che ha, destinata a non lasciare traccia. La vita della grande maggioranza.
Una vita che si può dire vissuta senza bisogno di certificazioni pubbliche.
