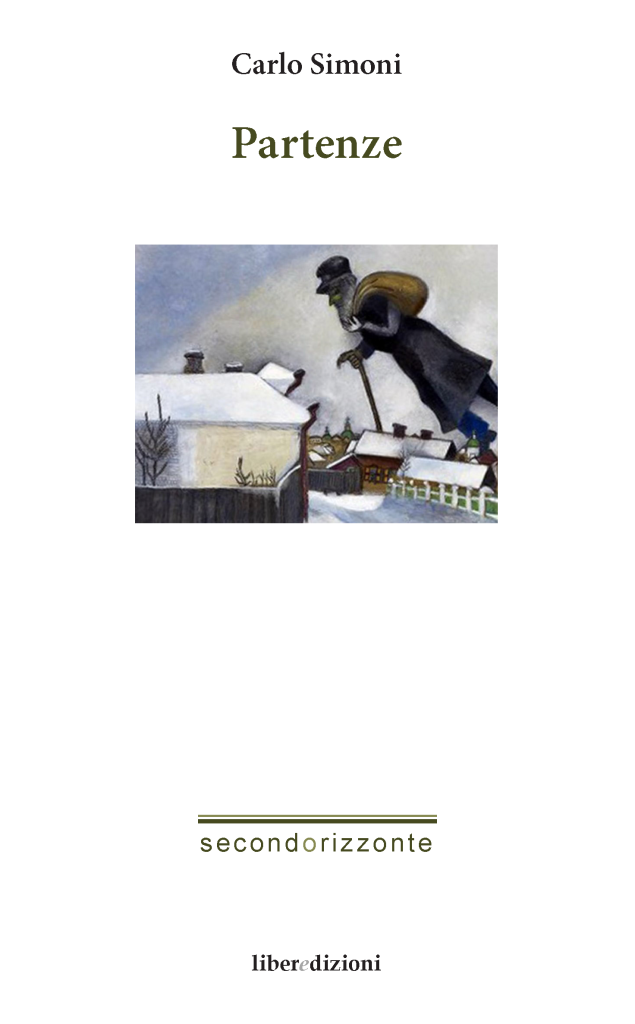
Carlo Simoni, Partenze, Secondorizzonte-Liberedizioni 2023 (pp. 280, euro 15)
Una partenza destinata a restare un proponimento, quella di Jean Jacques Rousseau; a lungo vagheggiato, e sempre rimandato, il distacco dalla propria città di Vittore Carpaccio; fino all’ultimo incerto, quanto ai motivi che lo ispirano, il viaggio di Michel de Montaigne. A ciascuno di essi, la partenza appare comunque l’evento nel quale si intravede la possibilità di una vita nuova, di una cesura nella propria esistenza, ma, nello stesso tempo, impone una decisione che obbliga a riflettere sull’alternativa, il restare, che non meno del partire comporta una scelta consapevole e impegnativa.
Decidere di rimettersi in viaggio, di riattraversare le Alpi come aveva fatto da giovane, appare all’anziano Rousseau il modo di sottrarsi definitivamente alle ansie e alle sofferenze che per lui il rapporto con gli altri ha sempre comportato, la via per tornare a vivere dopo tanto scrivere, la possibilità di morire, infine, senza la paura di non esser vissuto.
Rimanere nello stesso posto, per il grande pittore veneziano, significa accettare finalmente di vivere senza riserve la propria vita, intravedendo il senso di un altrove che non chiede, per essere raggiunto, di lasciare il luogo in cui è nato e le persone che gli sono vicine.
Il desiderio di andarsene e insieme il dubbio di non avere davanti a sé vita abbastanza per fare ritorno inducono l’autore degli Essais a prender atto della propria nativa, e feconda, irrinunciabile, irrequietezza.
La tenuta signorile di Ermenonville, nei pressi di Parigi, dove il filosofo trascorre le sue ultime settimane ospite di un marchese che condivide appassionatamente le sue idee e dove può passeggiare, come suo solito erborizzando; la Venezia di fine Quattrocento, innovata nella produzione culturale dalla diffusione della stampa e nel linguaggio pittorico dalle opere dei Bellini e dello stesso Carpaccio; il castello di Saint Michel de Montaigne, nel Périgord della seconda metà del Cinquecento, e la biblioteca nella quale l’autore degli Essais passa interi anni: luoghi e paesaggi diversi, situazioni e vicende irripetibili, figure più che mai vive nella nostra cultura, mentre vengono ricostruiti con cura documentaria e immaginazione partecipe, sono rivisitati attraverso la sensibilità del nostro tempo.
Quelle che seguono sono alcune pagine tratte dai tre racconti:
Da L’ultima passeggiata:
“Regnava il silenzio, quel giorno, fra gli alberi: per quanto mi guardassi attorno e scrutassi tra il fogliame dei faggi, non vedevo alcuno dei miei compagni chino a cercar funghi o a cavalcioni su un ramo a svuotare nidi.
Sobbalzai udendo una voce d’uomo canticchiare. Mi volsi a guardare e vidi un tale, minuto nella persona e di non alta statura, già in là con gli anni, che se n’andava naso all’aria. Mi accoccolai dietro un tronco a guardarlo e, curioso di scoprire chi fosse, non seppi distogliere subito gli occhi quando lo vidi fermarsi davanti a un albero e senza darsi pensiero mettersi a far pipì, canticchiando sempre e, avrei detto, beandosi della vista della fitta chioma che lo sovrastava.
Non era uno dei nostri contadini, né un vagabondo di passaggio: indossava una marsina e, sotto il tricorno, una parrucca, come un signore. Ma il cappello era gualcito, la parrucca arruffata, non s’era rasato la barba da giorni e indossava abiti stazzonati e scoloriti, come un contadino…
Non s’era accorto che ero lì, vicino. Mentre ancora era intento a soddisfare il suo bisogno, per la verità, si era ad un punto girato, come si fosse sentito osservato, ma non mi aveva visto, ed era tornato a canterellare quell’arietta, prima di ricomporsi.
Aveva poi ripreso il passo, guardando gli alberi uno ad uno, di quando in quando attardandosi a poggiare la mano su questo o quel tronco, o a farsi scorrere tra le dita le fronde più basse d’una pianta, come se, avendola riconosciuta, tenesse a salutarla. Oppure si fermava a raccogliere da terra qualcosa – una foglia o un’erba, credo, ma la distanza mi impediva ormai di distinguerlo –, per portarsela tanto vicino al viso da farmi dubitare volesse mangiarla, anziché riporla, come lo vidi poi fare più d’una volta dopo quell’osservazione meticolosa, fra le pagine di un quadernetto uscito dalla tasca della marsina.
(…)
Non avendo incontrato nessuno, se non quello sconosciuto, (…) dopo aver vagabondato fino a pomeriggio fatto tra faggi e querce andai, come pressoché quotidianamente facevo, a trovare Gris, il cucciolo che se ne stava là dove gli aveva trovato riparo Joseph, il più anziano dei nostri contadini, del quale ero amico. Joseph aveva qualche tempo prima avuto ordine dal guardiacaccia di mio padre di sbarazzarsi del cane, uno di quelli che fuggono atterriti alla prima schioppettata e non si lasciano educare alla caccia così come la praticano gli uomini, ma l’aveva portato invece a una capanna dove nessuno andava mai e che mio padre aveva fatto costruire accosto a delle grandi rocce e aveva intitolato a tale Jean Jacques Rousseau, un grande filosofo, il più grande – mi aveva detto –, ma del quale avevo continuato a non sapere nulla, neanche di quando fosse vissuto.
(…) Quel pomeriggio, però, Gris non c’era. Mi aggiravo da un po’ nei pressi della capanna, desolato, incredulo, quando me lo vidi correre incontro festoso, e dietro a lui, sorridente, l’uomo che avevo visto poche ore prima far pipì nella foresta.
Accennando un inchino, mi si presentò: Jean Jacques, sono lieto d’incontrarvi nuovamente.
Arrossii, sia per quel voi sia per la notizia che dunque, contrariamente a quanto avevo creduto, m’aveva visto: mio padre… cominciai. Ma lui m’interruppe: certo, certo, voi dovete essere l’ultimogenito del mio nobile ospite, ho conosciuto i vostri fratelli stamani.
Be’, io… Non sapevo come giustificare la mia assenza al suo arrivo, né la mia presenza nella foresta…
Ma lui mi tolse ancora dall’imbarazzo, complice Gris che non la smetteva di far le feste a me per poi passare a lui e di nuovo a me: il vostro amico è diventato anche amico mio, come vedete, e si chinò ad accarezzarlo fra le orecchie: ne devi aver passate anche tu, è vero? gli sentii sussurrare.
Dopodiché proseguì verso la capanna e, giunto alla porta, si girò ripetendo quel leggero inchino e vi scomparve.
Fino a quel giorno non avevo visto che Joseph entrare lì, per prendere o lasciare qualche attrezzo, e adesso sembrava che la capanna fosse casa di questo forestiero. E un pensiero mi traversò la mente: Jean Jacques aveva detto presentandosi… Possibile che fosse quel Jean Jacques Rousseau di cui diceva mio padre? possibile che un filosofo, per di più tanto insigne, fosse vivo, camminasse ancora su questa terra, parlasse come tutti gli altri?
Ebbi conferma della mia intuizione quello stesso giorno, a pranzo: mio padre non faceva che raccontare, a dei cugini nostri ospiti, degli elogi dei giardini che il giorno prima, al suo arrivo, gli erano venuti dal granduomo, che grande non era, piccolo anzi, e mingherlino. Non sembrava un filosofo.”
Da Altrove, qui:
“Eh sì, il mio caro Gerolamo: è stato con me che Antonello è arrivato a Venezia, perché, lo sai, la muda di Fiandra passa sempre da Messina. E Antonello era di quelli che il mondo lo vogliono vedere e allora è venuto con noi. È venuto con noi a Bruges e c’è rimasto per un po’, intanto che andavamo a trafficare cogl’inglesi. Poi l’abbiamo ripreso con noi, ma arrivati a Messina non c’è rimasto. Io gli avevo parlato di Venezia e lui è venuto. È così che Vettor l’ha conosciuto: l’incontro della sua vita. È stato da lì che si è convinto che il suo lavoro era quello del pittore. Andava già a bottega dai Bellini, ma tu lo sai: vai per stamperie e parli con quelli che han studiato e dunque tutte ’ste cose le conosci meglio di me. Io so quello che Vettor mi ha raccontato tante volte: che Antonello gli ha fatto vedere – e anche ai Bellini, a Giovanni in specie – che si poteva fare diverso. Perché Antonello era stato a Roma, e a Firenze, a Urbino, prima di star a vedere cosa facevano nelle botteghe dei pittori di là, della Fiandra. È da Antonello e da Giovanni Bellini che Vettor ha imparato a guardare, ma a fare anche: avevan capito, quelli, che conveniva lasciare l’uovo e passare all’olio per fare i colori, anche se poi occorre più tempo per averle asciutte, le tele.
Poi… Poi Vettor ha preso la sua strada, che i suoi teleri li riconosci subito, non puoi sbagliarti: con tutti quei forestieri che ci mette, tutte quelle torri e castelli che chi sa dove li ha visti. Perché lui da Venezia non s’è mai mosso, si può dire. È curioso come una capra ma gli basta venir qui o dove in ogni modo può incontrar gente come noi e ascoltare: quello che abbiamo visto, sentito, cosa dicono là dove siamo stati, come vestono, cosa mangiano, e se le donne sono belle… E chiede se abbiamo portato disegni, pitture di quei posti: non se ne lascia sfuggire uno. Ne ha la bottega piena, e perfino la casa. Dopo mette tutto nei suoi quadri. Come l’avesse visto coi suoi occhi. E piace, eccome se piace: non le Scuole grandi, dei signori, ma quelle altre, gli han dato lavoro. La scuola di Sant’Orsola, prima, e adesso sta finendo con la scuola degli Schiavoni. Insomma, s’è fatto. Eppure… Lo vedrai. È sempre lì che si danna. E io lo so perché: perché fin da quando eravamo ragazzi lui non andava d’accordo con suo padre, e quando ha lasciato la casa dei suoi voleva andar chi sa dove. Però voleva anche imparare e fare il pittore, e dunque è rimasto qui. Quando che però ha finito tutti i teleri di Sant’Orsola sembrava proprio che fosse venuta l’ora. Aveva già preparato tutto per partire. Poi… Ma stavolta credo che si decida, sono stato con lui qualche sera e mi sembra che stavolta non torni indietro.”
Da Notte di vigilia:
“Avevo probabilmente preso sonno. Mi ha fatto sobbalzare il cigolio della porta della torre (…) era lui. Con la candela accesa che gli illuminava il volto, i pochi capelli ritti sulla testa, i baffi senza la bella piega che di solito hanno.
È andato sino al portone che mette alla corte e ne ha tolto i catenacci. E’ uscito a fare quattro passi e ha raccolto qualcosa, che poi ha preso a rigirarsi fra le mani.
S’è accorto di essere osservato. Si è girato, mi ha sorriso ed è venuto verso di me: guarda che meraviglia, mi ha detto, mostrandomi il nido d’uccello che aveva raccattato, finito nel fango dopo che il vento l’aveva strappato da un albero vicino.
Noi non saremmo in grado di fare una cosa tanto bella. E utile, ha aggiunto. Poi mi ha dato un buffetto sulla guancia, ed è entrato nella stalla. Io gli sono andata dietro, ma mi sono fermata sulla porta, perché ho sentito che si metteva a parlare.
Come vorrei partire con te, mio fedele amico, diceva. Invece dovrò viaggiare con quegl’altri, ascoltare le loro voci, che raramente lasceranno il posto al silenzio. Sia ben chiaro: la conversazione mi piace, è una delle cose più naturali e gradevoli tra quante ne facciamo, ma la conversazione, non le chiacchiere, non le parole che non vanno dietro al pensiero e, al contrario, lo impediscono, annegandolo nella ciancia! E la cosa mi pesa tanto più perché proprio quando vado a cavallo io trovo la condizione ideale per pensare, per fantasticare. Mio fratello e mio cognato han procurato cavalli vigorosi e adatti a lunghi tragitti, non dico di no, ma per loro, come per gli altri due che verranno con noi, saranno solo strumento del viaggio, non compagni propizi al raccoglimento. E poi, lo posso prevedere con certezza, quando il percorso si farà aspro, o nei giorni di temporale, qualcuno di loro, quel lorenese, quel de Hautoy, ci scommetto, proporrà di proseguire almeno per un tratto in carrozza, coi nostri cavalli al seguito. Già mi vedo sballottato su quei sedili più duri di qualsiasi sella. Ma tu lo sai, non so star bene come in sella, appunto, sia quando sto bene che quando sto male. Anche perché – e qui l’ho sentito ridere piano, come fa lui – in sella la mia bassa statura non si nota. Non che ci abbia fatto una malattia, ma essere bassi è un difetto che mette in difficoltà quelli che hanno delle cariche, come a me è accaduto, senza contare che se un uomo è bello lo è perché è alto. Le donne possono essere belle per tante altre ragioni, non ti pare?
E poi ha ricominciato: ah, come viaggerei volentieri con te solo, senza mio fratello Bertrand, e quell’altro Bertrand, mio cognato, e gli altri due. Alla nostra amica d’Estissac non ho potuto negare il favore di portare con me suo figlio Charles, e così, dietro a quello, si è aggiunto il lorenese. Me li vedo: ciarlieri come fringuelli al mattino e poi, colla fatica del viaggio, corrucciati, le facce prima annoiate e poi sofferenti, e dunque insopportabili per uno come me che vorrebbe essere sempre in compagnia di persone allegre e che mostrano di star bene. E poi tu non avresti da ridire quando io mi fermo, riparto, devio. Ma del resto è così: io viaggio per il mio piacere. Se qui fa brutto tempo, vado dall’altra parte; se sono passato vicino a qualcosa da vedere senza potermi fermare, torno indietro. Non c’è luogo che sia escluso dal mio cammino. Non sto a tracciare prima la strada che farò. Non viaggio né per arrivare né per tornare: finché sento che muovermi mi piace, mi muovo. Non ho mete né tempi fissati. Ogni giorno il viaggio si conclude, e ogni mattina segna una nuova partenza. E qui ha taciuto per un po’, e poi, con voce più sommessa: del resto, il viaggio della mia vita procede allo stesso modo.”
Ordini

Se vuoi leggere il libro nella sua interezza lo puoi acquistare alla nuova libreria Rinascita di Brescia (15 euro).
Via della Posta, 7 – 25121, Brescia – Tel. 0303755394
libri@nlr.plus
Se vuoi riceverlo a casa puoi inoltrare il tuo ordine indirizzandolo a: ordini@secondorizzonte.it
e segnalando l’avvenuto versamento dell’importo indicato tramite bonifico sul conto corrente della libreria (IBAN: Unipol Banca – Agenzia di Brescia: IT 10 B 031 2711 20000000000 1851).
La spedizione non comporta aggravi di spesa.
Recensioni
Da Giornale di Brescia del 19 dicembre 2023
«Nel partire la promessa di una vita nuova; nel restare una scelta consapevole»
di Nicola Rocchi
(clicca sull’immagine per ingrandirla)

Magda Biglia (Bresciaoggi – novembre 2023)
Una partenza definitiva, per l’eternità; una partenza impossibile, meta che resta sogno, con la forza del sogno; una partenza da inquietudine, sofferta, ineluttabile. Avrà ragione Haraucourt col suo “partire è un po’ come morire”, oppure Orazio, “caelum, non animum, mutant qui trans mare currunt”. Sta di fatto che c’è dolore nel nuovo libro di Carlo Simoni per Secondorizzonte dal titolo “Partenze”. Che cosa agita una partenza dall’insicuro ritorno, fuga inutile, frattura, anelito alibi, nuova vita o addio agli affetti, ai luoghi, al vissuto? Addio. Anche alla vita. Morte ordinaria che accomuna tutti i viventi, senza inchino ad alcuna graduatoria. “Se pure le mie opere m’han dato qualche merito rispetto agli altri, non valgo nulla di più di qualsiasi altro, mi dico ora- afferma Jean Jacques Rousseau pensando data l’età alla falce incombente-, la tragedia s’è fatta commedia. La commedia che chiamiamo vita, che come tutte le commedie ha un termine privo della catarsi che la tragedia promette”. Rousseau è uno dei tre protagonisti illustri, con Vittore Carpaccio e Michel de Montaigne, ma si prende metà del libro dalla tenuta signorile di Ermenonville, vicino a Parigi, dove l’illuminista trascorse le ultime settimane della sua esistenza settecentesca. Siamo ancora in Francia ma nel Cinquecento con l’autore degli Essais, che teme e vuole il viaggio, respira nel bisogno di sentirsi altrove, “vivendo il domani più dell’oggi”; siamo nella Venezia di fine Quattrocento col pittore italiano che non ce la fa a lasciare la bottega per altri e più grandiosi lidi. L’operazione è quella, non nuova per Simoni, di narrarci l’uomo dietro il nome di fama, condendo conoscenza e immaginazione, con una scrittura intrigante e anche spiazzante tra il vero e il verosimile, dotta e immaginifica, tributo e furto a un tempo, esegesi e rilettura, appropriazione indebita e spionaggio nell’animo, nella solitudine dei grandi. Umani, con le loro labili debolezze, figli del loro tempo, per esempio nel rapporto con le donne o con i ‘concorrenti’. Fedeltà alle icone? Quanto basta. Anche nel linguaggio della narrazione a più voci che gioca fra passato e presente, come fanno taluni scrittori illustri con il dialetto e l’italiano. Ritorna anche, come in tanti altri testi, il tema del significato dello scrivere, per sé, per gli altri… perché. Simoni nasconde nei pensieri dei personaggi le sue riflessioni, tramite loro leggiamo di lui. “Si scrive se si sente appagato il proprio desiderio di solitudine, ma di più: se c’è l’agio di dialogare con se stessi, essendosi trasportati altrove, non importa se con la mente soltanto”, ma alla fine “si scrive per essere letti” fa dire al filosofo. E la lettura per il pensatore? “Porto sicuro per oltrepassare lo spazio della mia vita appena avviata come un territorio estraneo” nei suoi ricordi della fanciullezza”. La felicità? “Si è felici solo prima di essere felici”, come diceva pure il poeta.
Nino Dolfo (Corriere della Sera – novembre 2023)
Raffinato, mai chic. Una prosa elegante dalle campate solide, un’ estetica precisa, uno stile severo nel perlustrare le profondità intime della mente con perizia da cartografo. I personaggi dei romanzi di Carlo Simoni hanno una particolarità distintiva: vivono l’intensità degli sguardi e del sentire quando la vita li va a trovare. Siano grandi scrittori, artisti o intellettuali (i fratelli Mann, Klimt, Benjamin…) o dignitosissimi carneadi, non sono mai renitenti o impantanati in una zona grigia, accettano la sfida, abitano le domande che sono più ricche e decisive delle risposte. Succede così anche in Partenze (liberedizioni. Pp.269, euro 15.00), un trittico di racconti che hanno come protagonisti uomini che vivono un travaglio interiore, perché si trovano entre deux, tra arte e vita, dentro il gap che segna il divario tra due stati dell’essere. Uomini che hanno l’anima nomade e desiderante. In procinto di, come le perifrastiche attive.
Jean Jacques Rousseau, protagonista del primo e più cospicuo racconto, il filosofo grande ispiratore del pensiero democratico, il padre dell’illuminismo e del romanticismo, è una figura non priva di contraddizioni, reduce da una esistenza tormentata, sia per vicissitudini private che pubbliche. Colto e brillante, frequentatore di corti e salotti, sposa Thérèse Levasseur, una donna analfabeta, una “governante” come la chiama lui. Una consorte che peraltro non gli sarà fedele, cedendo alle lusinghe di un palafreniere molto più giovane. Da pedagogo e padre, abbandona i figli all’ospizio dei Trovatelli, perché non può garantire loro una vita economicamente dignitosa. Noi lo incontriamo a Emenonville, paesino dell’Oise, ospite nella tenuta del marchese de Girardin, suo ammiratore. Un soggiorno durante il quale potrà passeggiare erborizzando in compagnia di Amable, il figlio del marchese, ruminando i sensi di colpa nei confronti dei suoi figli biologici. Ma la morte lo coglie all’improvviso, quando aveva deciso di partire appunto, perché la prodigalità dei mecenati può risultare soffocante. “Il tipo di felicità che desidero non consiste tanto nel fare ciò che voglio, ma piuttosto nel non fare ciò che non voglie”: queste le sue parole che sono unmanifesto.
E’ sempre sul piede di partenza Vettor Carpaccio, pittore rinascimentale nella Venezia in fermento, che si ispira ai fratelli Bellini e ad Antonello da Messina, si interroga sul suo mestiere. Un carattere spigoloso in famiglia e smanioso di esperienze nuove, che si attarda in osterie e bordelli, ma non trova l’abbrivio per tagliare i ponti. Infine Michel Montaigne, sorpreso alla vigilia del suo viaggio in Italia in una notte in cui, nel castello del Perigord in cui risiede, alcuni fantasmi femminili si aggirano, ascoltano e palpitano come in un albergo del libero scambio di Feydeau. In quei giorni il filosofo scrive una lettera alla figlia Lèonor, ma nella stessa magione c’è un’altra giovane, una figlia spirituale “amata molto di più che di affetto paterno”. Una trinità di uomini illustri quanto fragili, sbirciati attraverso l’anatomia di un periodo o di un attimo della loro vita. Simoni rammenda lo strappo tra biografia e opere, tra spirito e carne, svela emozioni e situazioni che sapevano o non sapevano di sapere, restituendoli a noi nella loro irrequietudine modernissima.
La prova del nove per valutare se un libro ci è piaciuto è l’immediata sensazione epidermica che lascia appena letta l’ultima pagina: buon segno se, come in questo caso, si manifesta una reazione fisica, chissà se somatizzazione di uno riflesso intellettuale, che si esprime con un sorriso. Di gradimento e gratitudine, ovviamente.
