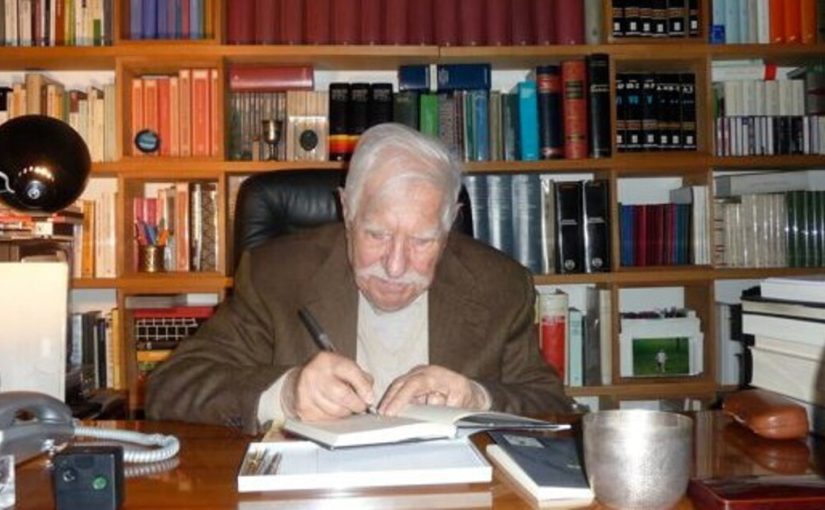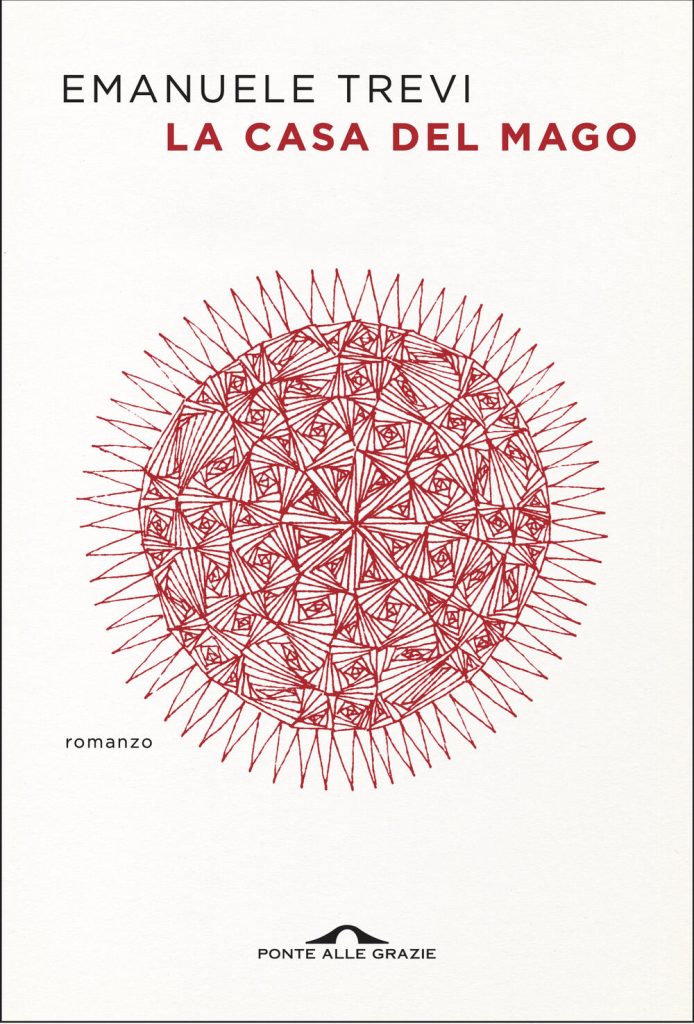
Emanuele Trevi, La casa del mago, Ponte alle Grazie 2023 (pp. 256, euro 18)
“‘Lo sai com’è fatto’. Quando mia madre mi parlava di mio padre ci metteva poco ad arrivare al punto, sempre lo stesso: per affrontare qualunque faccenda con quell’uomo enigmatico, con quel cubo di Rubik sorridente e baffuto, bisognava sapere-come-era-fatto. (…) Era evidente, d’altra parte, che non lo sapeva nemmeno lei com’era fatto, non lo sapeva nessuno”.
Se è vero che l’incipit rivela fin dall’inizio la qualità di un romanzo, questo di Trevi ne è la riprova. Apri il libro, leggi la prima pagina, la giri e a metà della seconda hai deciso: devi leggerlo tutto. E intanto ti chiedi che cosa ti ha conquistato e ti fa continuare.
La maestria lieve, paziente, penetrante di Trevi, innanzitutto, nel descrivere, raccontare, capire e far capire alcune persone che gli stanno a cuore: l’ha fatto in Due vite (in queste note nel maggio del 2021), lo rifà qui, con suo padre, il grande studioso e terapeuta seguace di Jung, “un uomo difficile, misterioso saturnino”, col quale, spiega l’autore, “mi sentivo a mio agio, mi piaceva passarci del tempo, ma non posso dire di averlo conosciuto bene”; “io – che pure intuivo di avere un carattere diametralmente opposto al suo – volevo già allora essere l’ombra di mio padre (…). Aspiravo a una rassicurante, affidabile mediocrità capace di generare l’unica sintonia possibile con quell’uomo così difficile da interpretare”, così incline a ritirarsi dal mondo rifugiandosi nel suo retrobottega – quello che secondo Montaigne ciascuno farebbe bene a portarsi dentro – mentre “per me esistono solo gli altri, i sentimenti che provano per me, quelli che io provo per loro” tanto che “anche nei sogni continuo a temere che non mi vogliano più bene”.
In parole come queste si chiarisce un’altra ragione per cui si prova piacere a leggere queste pagine: la voce di Trevi. Una voce che si pone allo stesso livello del lettore, non in vista della sua seduzione, ma grazie allo sforzo di osservazione che lo scrittore fa prima di tutto nei confronti di sé stesso, guardandosi come si trattasse di un altro: quello che succede a me può succedere agli altri, sembra sottintendere. Ma allora cosa distingue lo scrittore? La consapevolezza di quel che sta facendo e della responsabilità che comporta, a partire dalla propria capacità, appunto, di rendere l’unicità di una persona: “un grande scrittore non si limita a inventare un personaggio; la parte più difficile non è quella, è l’individuazione della legge nascosta che ne governa il destino, nell’apparente casualità dei fatti e del tempo che passa”. Senza tuttavia dimenticare che “scrivere di persone e vicende reali non è troppo diverso dal cimentarsi con storie totalmente inventate. La memoria è una grande romanziera: dilata, corregge, omette senza scrupoli, pretende di usurpare un’affidabilità che non le appartiene – con tutta la buona fede di chi la interroga. Non bisogna però trascurare il senso di colpa che le persone veramente esistite ispirano a chi le trasforma in personaggi”. Anche quando se ne racconta spinti dall’amore che si provava per loro e dal rimpianto che continuano a ispirare dopo la loro scomparsa. I racconti delle morti, quelle dei genitori in particolare, rappresentano un banco di prova rischioso per gli scrittori, per gli autobiografi in particolare, e Trevi supera certamente la prova: “Il problema dei cosiddetti momenti supremi è che non ricordiamo di aver provato nulla di particolare, vivendoli, o perché avevamo già provato abbastanza prima, o perché il presente, a volerci piantare i piedi, è più scivoloso di una lastra di ghiaccio. Quando diciamo che viviamo solo nel presente, ci convinciamo di qualcosa di apparentemente logico e dotato di una certa nobiltà. Perché le nostre radici non attecchiscono mai lì effettivamente, e a parte qualche asceta e illuminato, la vita delle persone comuni trascorre, almeno da che è finita l’infanzia, nell’anticipazione o nel rimpianto. Per questo motivo l’esperienza, che dovrebbe essere il bagaglio più sicuro e affidabile che ci portiamo dietro, è piuttosto una cosa ambigua e scoraggiante; da un lato, l’immaginazione erode i fatti ben prima che si verifichino; dall’altro, possiamo ipotizzare il significato di quei fatti solo quando appartengono al passato, proprio come quegli idioti che capiscono una barzelletta qualche giorno dopo averla ascoltata e ridono tra loro.”
Dal mondo abitato dal padre a quello senza di lui, dalla casa in cui a momenti c’era e in altri non c’era a quella in cui non c’è e non ci sarà più, anche se “quel luogo conteneva un residuo potente di energia mentale, una specie di braciere psichico non ancora del tutto spento”, perché era “l’antro di un grande guaritore”, che “sapeva maneggiare l’anima ferita” e “la faceva girare meglio, ricollocandola nell’insondabile meccanismo del suo destino”: “la sua funzione, il fulcro della sua arte, non erano le teorie dei libri (che pure rispettava), ma la presenza fisica, il vis-à-vis con le anime ferite, e i loro proprietari e proprietarie.”
Inevitabile che andare ad abitare in una casa del genere, come l’autore decide, non sia un passaggio scontato, in primo luogo per la congerie di oggetti che contiene e fa di lui “il curatore e il custode”, e di questo libro “una specie di catalogo ragionato”. Tra questi oggetti ci sono le decine di quaderni scritti dal padre per salvare fisionomie, pensieri, tracce di avvenimenti minuti perché, interpreta il figlio, lui “non si arrendeva alla sostanziale, irrimediabile incomprensibilità della vita, alla tirannide dell’insensato, e non perché avesse fede in un ordine nascosto sotto l’evidenza del caos, in un disegno provvidenziale: pure ammettendo che l’assurdo sia la potenza che finisce per prevalere in ogni cosa, come non riconoscere la possibilità di opporvi una forza contraria? Scrivere indefessamente (…). E quei quaderni, quella moltitudine di pagine che ogni giorno trovava il tempo e il modo di accrescere (…) erano un esercizio di consistenza – non saprei come altro definirlo – al quale non poteva rinunciare.”

La tentazione di cadere nell’evocazione nostalgica è comunque del tutto estranea a Trevi. Il suo periodare pacato, autoironico, non di rado aforistico, si apre spesso a brani esilaranti, come quelli del ritratto del padre alla guida della sua Citroën blu o quegli altri relativi alla colf peruviana inconcludente all’inverosimile ma narratrice “saggia e impassibile come uno scrittore verista”, o alla temporanea amante pure peruviana, impassibile nel suo appagamento di sé e del mondo. Ma non mancano rivisitazioni suggestive di Jung e del suo pensiero, senza che per questo il romanzo scivoli nel saggio di storia della psicanalisi. Se entra in ballo, l’inconscio, è per giocare al protagonista scherzi inquietanti: “misteriose coincidenze”, piccoli disguidi, lo avvertono della presenza di un’invisibile “Visitatrice” – femminile e seduttiva, gli piace per altro immaginare –, che non si sa se metta in scena i suoi giochetti per chi in quella casa non c’è più, il padre, o per lui, il figlio, per dirgli che è un “impostore” e fa bene, dunque, a provare la sensazione di “abitare abusivamente” nella casa che pure ha ereditato, assediato dalle cose che popolano quello che è di fatto un “museo” del suo primo proprietario. Non solo i quaderni infatti, ma anche gli album pieni di disegni astratti ed enigmatici, sul tipo dei mandala tibetani, vi trovano spazio, e in un numero indefinibile i ciottoli che il genitore lucidava, ripetendo lo stesso gesto per ore intere, un giorno dopo l’altro, fedele a una pratica che non aveva mai abbandonato finché l’artrite alle mani glielo aveva impedito. “Forse si trattava di un metodo per dislocare il centro della personalità verso la periferia, dalla mente inquieta ai polpastrelli laboriosi, tenaci”. Ma per il figlio è altro: una “prima lezione di scrittura”, la più efficace, “perché le parole sono identiche ai ciottoli di mio padre, non possiedono nessuna qualità evidente, non sono né brutte né belle, si confondono tra milioni di altre ugualmente opache e usurate. (…) Tutto sta nello sfregarle, e poi sfregarle ancora, e ancora – rasentando la demenza. E quando le cose non vanno, e passo un pomeriggio intero davanti al dannato schermo del pc a scrivere una frase per poi cancellarla, e le ore passano, e diventa palese che non era giornata, alla fine è lui che mi viene in mente, con i suoi rettangoli di carta vetrata – grana grossa, grana media, grana fine. Che altro potrei fare? Ricomincio a sfregare”: se l’analogia tra sassi e parole poteva ricordare quella fra queste ultime e i granelli della collezione di sabbia descritta da Calvino nell’ultimo libro pubblicato in vita, evocazioni come questa, della figura del padre, non possono non far pensare a quella, dettata da un sentimento analogo, che leggiamo nella Strada di San Giovanni.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.