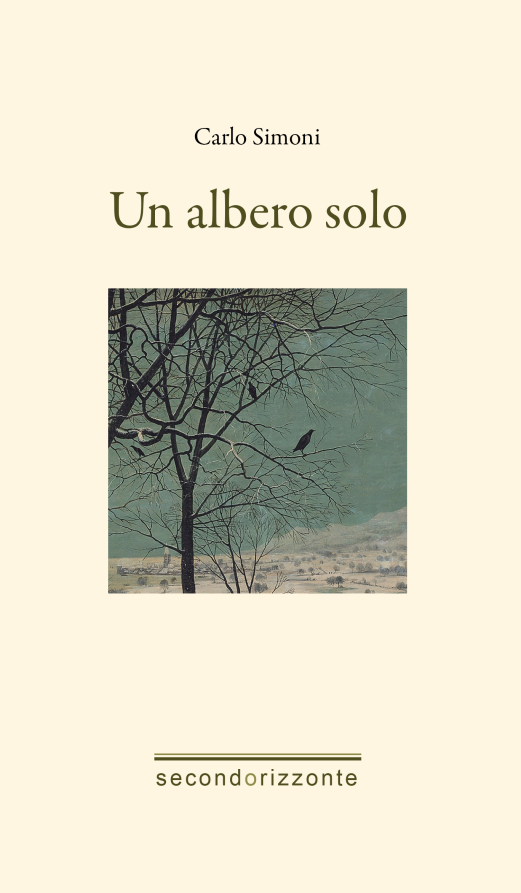
Carlo Simoni, Un albero solo, Secondorizzonte 2024 (pp. 135)
Il romanzo è scaricabile gratuitamente:
Una figura, tra quelle dei profughi che scendono da un pullman in arrivo dall’Ucraina nel marzo del 2022, richiama alla mente del protagonista, un anziano medico, il ricordo di un amore di gioventù. La breve relazione che l’aveva legato cinquant’anni prima a Olena, una ragazza di origine polacca, l’aveva fatto avvicinare a una cultura in cui la convivialità calorosa e ospitale non cancellava la memoria della tragedia degli anni del nazismo. Una memoria ancora viva nella madre di Olena, costretta a fuggire dalla sua città, Leopoli, e poi a vivere con la famiglia nel ghetto di Varsavia, prima di essere rinchiusa nel campo di sterminio dal quale solo lei si era salvata.
Piani diversi della memoria, vicende individuali e collettive, drammi del presente e del passato si intrecciano in un racconto nel quale il bilancio della propria vita e del rapporto che si è saputo instaurare con gli altri si confrontano con il ripensamento della mentalità e dei comportamenti diffusi fra i giovani negli anni Settanta.
Sarà l’esperienza della scrittura, a cui lentamente il protagonista si apre, ad offrirgli una consapevolezza nuova, di sé e delle scelte che ancora lo attendono.
Quelle che seguono sono alcune pagine tratte dal romanzo:
Una mattina come tante altre, dicevo. Non potevo immaginare che invece sarebbe successo qualcosa di inatteso, e che, dopo, tutto sarebbe stato diverso.
(…) Non mi aspettavo di vedere, invece dei primi venuti a formare la solita fila nella piazzetta fra la chiesa e l’oratorio, un pullman, appena arrivato, da cui stavano scendendo donne, soprattutto. Qualche vecchio, ma nella stragrande maggioranza donne. E bambini. Me l’aveva pur detto, don Fausto, che a giorni sarebbero arrivate, ma mi era uscito di mente, non ci avevo più pensato. Sarà che gli altri stranieri mica li avevo visti arrivare. Non era difficile pensare ai viaggi tremendi che avevano dovuto fare, ma quando ne avevo qualcuno davanti, in carne ed ossa, non mi venivano in mente le immagini delle traversate nel deserto, dei gommoni in alto mare, degli sbarchi drammatici. Invece, ricordo, le donne che scendevano una dopo l’altra dal pullman mi sembravano le stesse che avevo visto anche la sera prima al telegiornale. Veniva spontaneo pensare che solo poche ore prima erano ancora là, in quell’inferno. Che poi non erano poche, quelle ore. Don Fausto mi ha detto che avevano viaggiato ininterrottamente dalle dieci della sera di lunedì fino a quel momento, le nove di mattina del mercoledì. Trentacinque ore di viaggio, due notti sul pullman, per fare poco più di mille chilometri.
Al momento mi sono sembrate tutte uguali, quelle donne. Ce ne sono parecchie in città, donne ben piantate, come mia nonna. Donne che non hanno la preoccupazione di restare magre e di sembrare giovani anche quando non lo sono più.
(…) Ricordo una donna, con un bambino in braccio. Teneva per mano l’altra figlia, più grandicella, che si portava dietro un trasportino. Era appena scesa che l’ha aperto e invece del gatto che mi ero aspettato di vedere è uscito un cagnolino, bruttino, le zampe cortissime. Il bambino si è messo a urlare disperato indicando la bestiolina e la sorella che la rincorreva, senza badare alla madre che la chiamava, stravolta. Ma tutto si è sistemato alla svelta: il cagnolino si è fermato ad annusare un cane più grosso di lui, un randagio, probabilmente, arrivato lì a vedere cosa succedeva. Si è subito lasciato accarezzare dalla bambina e quando lei ha preso in braccio il suo animale se n’è andato, tranquillo. Come si fosse accertato che andava tutto bene e poteva riprendere la sua strada.
Ricordo anche che in quel momento si era fatta vicina una ragazza che urlava in un microfono, davanti a lei uno con la cinepresa in spalla che rinculava inquadrandola. Una televisione locale, di quelle che non guardo mai.
È come se lo sentissi adesso quel che diceva: arrivano per la maggior parte dall’Ucraina occidentale, alcuni anche da Kiev, fuggiti a Leopoli e altre città vicine. Hanno negli occhi le lacrime e la paura della guerra, l’ansia per i propri familiari, bloccati in Ucraina. O che hanno scelto di rimanere: mariti figli fratelli che sono rimasti a combattere.
Non sembrava la prima volta che le diceva, quelle parole. Si guardava intorno, mentre continuava a parlare nel microfono.
Ha agganciato una donna che sorreggeva una vecchia, la madre probabilmente, e allora è passata all’inglese: what’s your name, lady?
Svetlana mi chiamo, le ha risposto la donna.
Ma lei parla in italiano…
Certo, io qui, Italia, tre anni, poi tornata Ucraina, e adesso…
La vecchia si è messa a piangere, e a dire qualcosa nella sua lingua all’intervistatrice, che non capiva: è sua mamma? ha chiesto a Svetlana.
Sì, mamma.
E i suoi?
Tutti là, marito figli nipotina. Tutti là.
La cronista ha dovuto arretrare, lasciare spazio a quelli che scendevano dal pullman.
Mi sono spostato anch’io, e mi sono venuto a trovare vicino a un’altra donna che in punta di piedi si sforzava di vedere chi scendeva: ma sei sicura che sono su questo? l’ho sentita chiedere a una più giovane.
No, ma… Mi hanno detto che erano partiti ma poi il telefono non prendeva più…
Don Fausto, che si aggirava in questa ressa trovando qualcosa da dire a tutti, non so in che lingua, mi ha preso sotto braccio: è Dana – mi ha detto della donna che continuava a guardare l’uscita del pullman. È di Ivano Frankivsk, non tanto lontano da Leopoli e da Ternopil. È qui da quasi tre anni, le ho trovato io un lavoro, da badante, ma sono giorni che viene a dirmi che la notte non dorme da quando si è saputo che hanno bombardato anche la sua città.
E in quella Dana, come volesse confermare quel che il prete mi aveva raccontato, stava ripetendo, non so a chi, la stessa frase: sono sotto le bombe, sotto le bombe…
(…) Ormai tutti erano scesi. Il pullman era vuoto, ho visto l’autista risalirci: cos’avrebbe fatto? sarebbe tornato subito indietro, a Leopoli? L’ho chiesto a don Fausto: no no, figuriamoci, è stanco morto anche lui, gli diamo noi una stanza, qui in parrocchia. Si ferma un paio di giorni, intanto che raccolgono quelle che sono già pronte a tornare, o perché avevano solo accompagnato qui la madre, i figli, o perché non ce la fanno a restare mentre i loro uomini sono là.
Mentre parlavamo, con la coda dell’occhio ho visto che invece qualcuno sul pullman c’era ancora, e stava scendendo solo adesso. E se ricordo il resto, questo momento mi si è stampato nella mente.
Una donna piccola, grassa, sui settanta avrei detto. Una vecchia. Una vecchia come tante.
Sono sempre gli altri a sembrarmi vecchi, le donne soprattutto. A volte incontro dei colleghi che hanno lavorato con me anni prima e mi stupisco che abbiano a fianco mogli che sembrano più vecchie di loro, e invece sono coetanee magari, o addirittura hanno meno anni dei mariti.
Questa poteva avere su per giù la mia età, ma si muoveva lenta. Anche perché si trascinava un trolley enorme cui si era rotta una ruota, mentre con l’altra mano stringeva una borsa di plastica rossa e un paio di sacchetti pieni, con un impermeabile avvoltolato sul braccio per giunta. Se una donna non le si fosse avvicinata a sostenerla mentre scendeva i gradini del pullman non credo ce l’avrebbe fatta. Un cenno di ringraziamento e appena ha messo i piedi in terra se n’è andata, senza una parola.
È stata la camminata, stanca, goffa, che mi ha dato una sensazione di familiarità, come l’avessi vista e rivista ma non ricordassi quando, e comunque mi fosse rimasta in mente, una figura del genere.
Si è allontanata, arrancando in quel suo vestito di maglia nero, lungo fino ai piedi, che conteneva come un sacco il corpo informe.
Gli occhi a terra. Sembrava non aver niente da guardare lì dove era appena arrivata, che niente potesse sorprenderla, o inquietarla. Aveva quasi l’aria di una del posto che ha concluso il suo tragitto usuale e non le interessa nulla e nessuno se non andare a casa. Ma ce l’aveva una casa? era forse ospite di qualcuno? Non erano pochi ad appoggiarsi a parenti o compaesani, specie i primi giorni.
Si è mescolata fra gli altri, l’ho persa di vista.
Era ebrea Ida.
Vicina ai sessanta, piccola, grossa, le guance cascanti e le palpebre basse sugli occhi d’un azzurro acquoso, i capelli rosso scuro, grigi alla radice. Su entrambi i lati della bocca le si apriva un vuoto quando rideva, ma rideva poco. Credo non avesse mai messo in conto di farsi mettere i denti che aveva perduto. Forse non l’avrebbe fatto neanche se ne avesse avuto i mezzi. Più che della trascuratezza, era l’immagine della rassegnazione.
Non so più quanto somigliasse alla donna che ho visto scendere per ultima dal pullman: nel momento stesso in cui mi è tornato in mente il suo nome, la figura di Ida si è del tutto assimilata a quella della donna ucraina.
Eravamo giovani, io e Olena. Ventitré anni io, lei venti. Mi aveva portato a casa sua già la seconda o la terza volta che ci vedevamo. Non mi aveva presentato alla madre, com’eravamo entrati era andata in camera sua a cambiarsi e mi aveva lasciato solo con lei, che mi aveva chiesto se preferivo quella con i grani di pepe, l’altra nella seconda bottiglietta, al limone, o quella nella terza, pura: la facevano in casa la vodka? Le ho chiesto assaggiando quella al pepe. Mi ha guardato come se le avessi chiesto se avevano l’acqua corrente.
Parlava un italiano sciolto, con un lessico capace di sorprendere per varietà, finezza. Solo un particolare, nella pronuncia, lasciava intravedere la provenienza straniera, tedesca avrei detto: diceva qvesto, non questo… Ascoltandola, in seguito, mi sono trovato a pensare che quell’errore di pronuncia non fosse che un vezzo, o il segno d’una volontà venata d’ironia, o d’autoironia, di mantener vivo qualcosa – anzi, qvalcosa – che per lei risaliva a molto tempo prima, al tempo della sua infanzia e si poteva ricondurre sì al tedesco, ma, come avrei appurato in seguito, al tedesco filtrato dall’yiddish, con il quale Ida aveva fatto a tempo a stabilire un certa dimestichezza cinquant’anni prima, quando passava intere giornate con il nonno, un ebreo della Galizia, uno dei tanti che vivevano a Leopoli.
(…) Avevamo cominciato da poco a lasciare la compagnia, certe sere, per starcene da soli, fare passeggiate interminabili sul lungo fiume, restare fino a tardi su qualche panchina, quando Olena trovò una nuova casa nella prima periferia, su un vialone che correva sulla riva opposta al centro, dove aveva fino allora abitato. Non era lontana da dove stavo anch’io, ancora con i miei.
Aveva visto l’avviso del possibile affitto un giorno che si era spinta fin lì per vedere la casa in cui vivevo. Le avevo detto dove abitavo e, come le piaceva sentire di quel che avevo fatto prima che ci conoscessimo, così le era venuto quel desiderio: voleva sapere tutto di me, mentre restava spesso nel vago se ero io a rivolgerle domande sul suo passato.
Per lei, quella che aveva trovato, era diventata da subito la nostra casa.
La madre era contenta dell’aria primo ’900 che aveva. Leon, il fratello di Olena, per quel che ci stava, in casa, era rimasto indifferente alla nuova sistemazione.
Le quattro stanze, grandi, alte, al primo piano – l’unico, oltre quello terreno occupato dal magazzino di un negozio di mobili – davano su un cortile che dal viale si vedeva solo durante il giorno, quando il portone restava aperto al via vai dei furgoni, ma quando questo cessava, nel secondo pomeriggio, tornava invisibile dietro al portone chiuso. Il rumore del traffico si faceva lontano e dalle finestre dell’appartamento di Olena si sentivano gli uccelli riunirsi sull’albero che stava in un angolo del cortile e superava in altezza la casa. Era un tasso, come quelli che c’erano nel giardino della chiesa ortodossa, sull’altro lato del viale, a un centinaio di metri.
Mi ero sforzato inutilmente di vederli, nascosti tra le foglie della pianta, gli uccelli intenti a chiacchierare fitto fra loro, la prima volta che Olena mi aveva portato alla nostra casa.
Le stanze erano ancora vuote, era stata quel giorno stesso a prendere le chiavi dal proprietario e poi aveva portato lì solo un paio di coperte e un cuscino, una tovaglietta e due tovaglioli, una bottiglia di vodka al pepe, la mia preferita, e per accompagnarla una bella porzione di zapiekanka, dei tranci di baguette tagliata per il lungo e ricoperti di formaggio fuso, pomodoro e funghi trifolati.
Siamo stati a lungo a guardare il tasso, finché gli uccelli hanno smesso di cantare e l’albero è diventato una sagoma nera.
Olena ha apparecchiato, come fosse un tavolino, il davanzale della finestra di quella che aveva deciso sarebbe diventata la sua camera: è stata la prima delle molte cene cui sarei stato invitato in quella casa.
Era alla finestra a fumare quando mi ero svegliato infreddolito, le ero andato alle spalle senza farmi sentire, l’avevo abbracciata. Eravamo stati in silenzio a guardare il tasso, appena mosso dall’aria notturna.
Sembra, ma non è solo, mi ha detto Olena, e mi ha raccontato. Anche lui doveva essere là, nel giardino della chiesa dove c’erano i suoi genitori e i fratelli. Un uccello aveva mangiato una delle loro bacche, ma il seme che c’era dentro è velenoso, gli uccelli lo sanno, e dunque mentre volava l’aveva lasciato cadere, proprio in questo cortile, e così lui, il nostro tasso, era cresciuto qui. Ma gli uccelli – aveva continuato Olena – vanno e vengono e gli portano notizie e saluti dai suoi, e poi volano da quelli con le sue risposte. Alcuni si fermano là, la notte, altri qui. Adesso dormono, ma ci sono.
Erano stati loro a svegliarci, mentre cominciava a venir chiaro.
Stavo visitando una donna di Ternopil, che mi diceva come da tempo vedesse quello che aveva intorno come fosse tutto sott’acqua, e mentre la rassicuravo – il suo non era che uno dei modi più comuni di descrivere l’effetto della cateratta – spiegandole che si poteva rimediare, un pensiero mi si è insinuato, insistente: quello che stavo facendo, e che facevo ormai ogni giorno non aveva alcuna possibilità di bilanciare la sofferenza che avevo inflitto a Olena, non la poteva in nessun modo risarcire. Anche se l’avessi potuta ritrovare, le avessi detto del mio pentimento, mi fossi dichiarato pronto a cercare insieme a lei un modo per riparare al male che le avevo fatto, non avrei risolto nulla: lei non era, non è più la donna che era allora, né io l’uomo di quel tempo…
Il bene si dispone accanto al male, senza annullarlo. Non siamo la somma algebrica di quel che abbiamo fatto. La nostra vita, per quanto si possa fare, non si risolve mai in un gioco a somma zero.
A questa conclusione ero arrivato, tra me, quando mi sono sentito osservato, ho guardato alle mie spalle: l’amico scrittore era lì, aspettava che finissi con la mia paziente.
Sta facendo un gran lavoro, la ammiro, mi ha detto sorridendomi.
Non è il caso, e rimasti soli, mi son messo a raccontargli esattamente quel che stavo pensando poco prima.
Mi ha ascoltato: ci può essere una sorta di soddisfazione, a suo modo pacificante, anche nel macerarsi nel senso di colpa…
Già già: siamo tutti peccatori, chi non ha peccato scagli la prima pietra e dunque… Sono cose che potrebbe dirmi anche don Fausto.
Ci eravamo seduti in un bar vicino, abbiamo preso due caffè.
Bellini taceva. Come altre volte ho temuto di averlo offeso: quel che intendevo è solo che io non credo che si facciano peccati che si possano poi cancellare pentendosene. Si fa del male agli altri, e a sé stessi, e il pentimento, di fatto, non risolve nulla.
Era un pericolo quello cui volevo alludere, mi ha risposto. Un pericolo da cui guardarsi: non ho parlato di pentimenti e penitenze, ma di rodimenti che possono finire col girare ossessivamente attorno a sé stessi, a loro modo appagandosi della ripetizione.
Ho cercato di spiegarmi meglio: quello che voglio dire è che mi trovo a dover accettare, per la prima volta nella mia vita, di non essere uno che non ha fatto mai male ad altri – se si esclude quello inevitabile che consegue al fatto stesso di essere vivi e di nutrirsi di altri viventi, diversamente da come sanno fare le piante. Non ho che da prendere atto che non sono quello che ha sempre saputo come riparare ai torti fatti, e dunque riscattarsi, tornare a essere quello che voleva essere… Mi ero messo in testa che avrei trovato il modo di non lasciarmi dietro offese cui non avessi trovato il modo di rimediare, per tornare a sentirmi… non dico giusto, buono, ma…
Intero? mi ha suggerito Bellini.
Ecco, sì: intero. Adesso mi vedo fatto di pezzi, pezzi che non formeranno mai un che di compiuto, come le tessere di un puzzle non finito, in parte accostate a lasciar intuire un disegno sensato, o distinguibile almeno, e in parte sparse, nell’attesa, che si lascia prevedere vana, di essere collocate al loro posto…
Adesso lo può scrivere, il suo racconto, adesso sì, mi ha detto convinto Bellini, con un sorriso simile a quello che mi aveva rivolto poco prima, quando si era complimentato per il mio lavoro, o forse per il conforto che stavo dando a quella donna.
Quella che a me pareva una resa, una constatazione amara, disarmata, sembrava che a lui apparisse invece una conquista, mia e in qualche modo nostra: nel suo sorriso mi è sembrato di vedere la soddisfazione di avervi contribuito. Il piacere di vedere un altro giungere, sul suo stesso cammino, dove lui era da tempo arrivato.
Ho rimestato il fondo della tazzina con il cucchiaino. Non sapevo cosa dire. Mi era già capitato, con lui: di capire restando nel dubbio d’aver capito davvero.
Il mio racconto… Ci ho già provato, non fa per me scrivere. Di me poi… Mi sembrerebbe di scrivere di un altro, anzi: di pretendere di diventare un altro. Be’, mi ha risposto divertito, non credo che la scrittura abbia questo potere: siamo quel che siamo, dentro la nostra vita fino alla fine. Ma a volte scrivere di un altro è l’unico modo per scrivere di sé… Non si tratta di illudersi di vivere un’altra vita, né di ricomporre i pezzi che formano la propria, ma di vederli riuniti. Sparsi magari, come le tessere di un puzzle, ma tutti sullo stesso tavolo…

