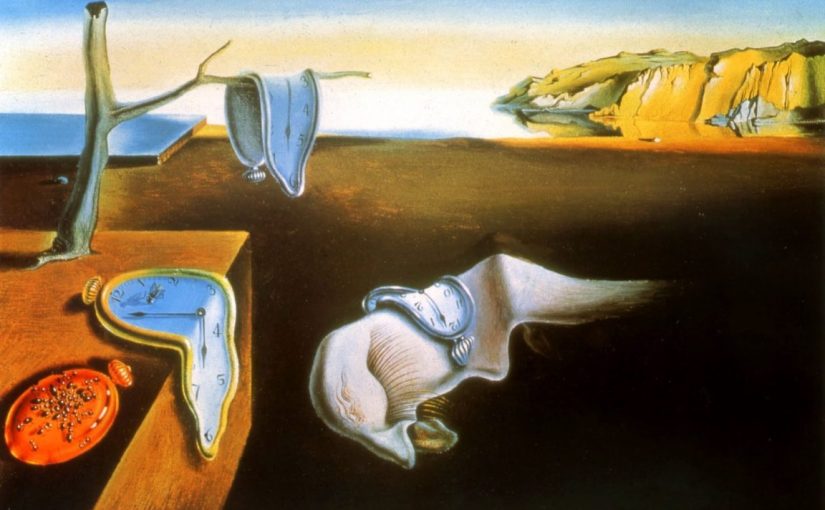Rossana Rossanda, Amar. Favola laica, Marsilio 2024 (pp. 96, euro 14)
Ristampata nel centenario della sua nascita, Rossanda aveva scritto questa “favola” nel 1996, a qualche anno di distanza da un seminario che con Filippo Gentiloni, altra firma storica del “manifesto”, aveva coordinato all’eremo benedettino di Monte Giove, nelle Marche, dove si riunivano spesso esponenti della Sinistra come Mario Tronti, Pietro Ingrao, Luigi Ferrajoli, Giacomo Marramao, Raniero La Valle per confrontarsi su temi esistenziali, come la morte.
“Non c’è bisogno di aggiungere – osserva Maria Fancelli nella postfazione – che sullo sfondo di questa favola c’è il tramonto di grandi ideologie e un orizzonte d’attesa che si è fatto infinitamente più basso, più debole e più vero”, incapace di proporre l’impegno politico e la speranza di un grande cambiamento come garanzie di un’ideale continuità della propria vita in quella dei compagni.
È sicuramente questa una chiave di lettura del racconto, che colloca in un lontano passato considerazioni attuali, ineludibili per la sensibilità contemporanea – non ultima quella della differenza con cui le donne, rispetto agli uomini, sanno rapportarsi alla propria finitudine.
Amar, allievo del sapiente Ben Maimon – teologo, filosofo, giurista e medico ebreo andaluso del XII secolo –, “aveva imparato che non sempre si guarisce, e una volta si muore. E questo gli dava sgomento, ma non amarezza”. Dopo la morte dei genitori, tuttavia, “si sentì esposto”, ma fu la morte del giovane figlio a ridurlo in uno stato tale da “non (sapere) più nulla di sé stesso” e sentirsi “pieno di sabbia”. Eppure continuò a credere che “non c’era spietatezza nel signore, c’era un ordine, noi ne eravamo un segmento e nell’esserlo c’era una grandezza”, ma soprattutto, come gli spiegava Ben Maimon, dalla sventura “non si è puniti” per aver fatto qualcosa. Nonostante questa sua accettazione, il suo modo di sentire, negli anni successivi, sarebbe stato comunque diverso da quello della moglie Sita, perché lei “non andava alla fine ma al ricominciamento” e, contrariamente al marito, anche dopo che la peste aveva portato via l’unica figlia, sarebbe tornata “a regolare le cose di tutti i giorni mentre egli – Amar – giaceva guardando al niente sopra di sé”, incredulo ormai che un dio “si (curasse) della specie umana” e persuaso piuttosto che “aveva creati gli uomini perché vivessero nell’ansia e cadessero nella morte dibattendosi”. Una sorte ingiusta e crudele, che non avrebbe risparmiato di lì a poco lo stesso Ben Maimon. A questo punto Amar, che non condivide con Giobbe la virtù della pazienza, osa sfidare il signore: “Hai fatto la vita e la morte. Se sei Dio, metti fine alla morte. (…) Voglio non morire. (…) Voglio guarire il mondo. Te lo contenderò. (…) Voglio che anche Sita viva con me”. Senonché la moglie si contenta del fatto che non vedrà morire l’amato consorte: quanto a vivere sempre, no, non ci tiene. E così solo “Amar non invecchiò”: “la sua scommessa era che la morte dell’uomo fosse superflua alla vita dell’uomo”, l’unico essere al quale “era stato dato un lume di coscienza per saperlo”.
Una morte che non fa parte della vita, e per questo, appunto, “superflua”. Sembra di sentire il Sartre dell’Essere e il nulla (“moriamo sempre per soprammercato”) e Simone de Beauvoir – che Rossanda conosceva bene e aveva spesso frequentato –, secondo la quale “l’essere umano esiste sotto forma di progetti che sono non progetti verso la morte, ma progetti verso fini singolari”, da cui la morte è esclusa.
Mentre gli tocca assistere alla morte della moglie, “non interessata a strappare altro tempo per sé” e dunque capace di “(scendere) con grazia verso la fine”, Amar prosegue la sua lunga, interminabile vita attraverso epoche e luoghi diversi, ormai straniero fra i contemporanei, proprio come il protagonista di un romanzo della stessa de Beauvoir – Tutti gli uomini sono mortali, del ’46 (non certo dei suoi migliori). Come quel personaggio, anche Amar deve rendersi conto, nella sua solitudine di uomo che continua a vivere fra i propri simili che invece scompaiono uno dopo l’altro, che “il limite degli immortali (è) opposto ma della stessa dimensione di quello dei morituri”: anche aver guadagnato l’immortalità non risolve la domanda sempre inevasa di quale senso abbia la vita. E anzi, obbliga a constatare la coazione a ripetere degli uomini. “L’uomo non (sa) – infatti – la sola cosa che avrebbe potuto sapere, stare con gli altri mortali senza distruggersi, e, già che doveva finire, senza patire l’innecessario. Non (ricorda), si (infila) sempre nelle stesse trappole”.
La conclusione è quella di parecchie altre storie che han cercato di immaginare le conseguenze di una guadagnata immortalità: Amar ammette di aver sbagliato, chiede a Dio che fermi il tempo e nessuno, non solo lui, muoia, per poi rendersi conto che neanche questa è la soluzione, perché quel che avviene, una volta bandita la morte, è la perdita di ogni orizzonte di senso, di quello almeno aperto ai mortali, la cui vita è “fatta di desiderio e di fine, attesa e perdita, speranza e timore che (fluiscono) in una crescita invisibile e scintillante. Perfino nella sofferenza, più scintillante di quell’opaca perdita di senso”.
E così anche Rossanda, certo capace di una levità e dotata di una sensibilità culturale che traspare fin dalla nota introduttiva, si aggiunge con questo racconto alla schiera di quanti – oltre alla de Beauvoir – han voluto raccontare di come un’eventuale immortalità non darebbe la felicità agli uomini: da Swift che porta il suo Gulliver nell’isola di Luggnagg, dove si continua a invecchiare ma si viene dichiarati legalmente morti a 80 anni, venendo tagliati fuori da ogni rapporto con gli altri, al Čapek de L’affare Makropulos, la cui protagonista non vuole continuare a vivere a causa della noia; da Borges che con L’immortale conta di dimostrare che essere immortali è essere nessuno, ossia non essere, a Saramago che nelle Intermittenze della morte racconta le complicazioni e i disordini sociali e politici che smettere di morire indurrebbe, sino al recente, Gianmaria Parrotta, i cui Immortali (Bartha 2021) si trovano a rimpiangere ben presto la loro primitiva condizione.

Immaginare una condizione di immortalità per suggerire che essere mortali non è poi il peggio che potesse capitare agli uomini? Si può sospettare che questo sia, di fatto, lo scopo più o meno consapevole di queste opere, ma che in Amar appare messo in questione dall’autrice stessa: “La favola di Amar è un frutto del disagio. Non mi riusciva di scrivere se non in forma fantastica che, se non morissimo, non conosceremmo niente di simile alla vita che tanto ci è cara. Eppure è un’evidenza. Ma (…) è un’evidenza della ragione cui non si accompagna quel senso di pacificazione che altre volte il ragionamento sembra darci”. Perché “la materia di cui è fatta la vita è il tempo che fugge, il suo sangue è la nostalgia d’un sempre che non ci appartiene, ma sul quale soltanto ci misuriamo”. Non c’è niente da fare, occorre ammetterlo: “Il finito non sopporta la finitezza. Almeno l’umano finito”, l’animale umano. Per il quale, anche quando la morte si fa vicina, il suo modo di rapportarsi alla fine resta ambiguo: “Il sapore del vivere dato dal ‘moriremo’ (…) l’ho sospettato tardi, forse è l’ultima fantasia di dominio”.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.