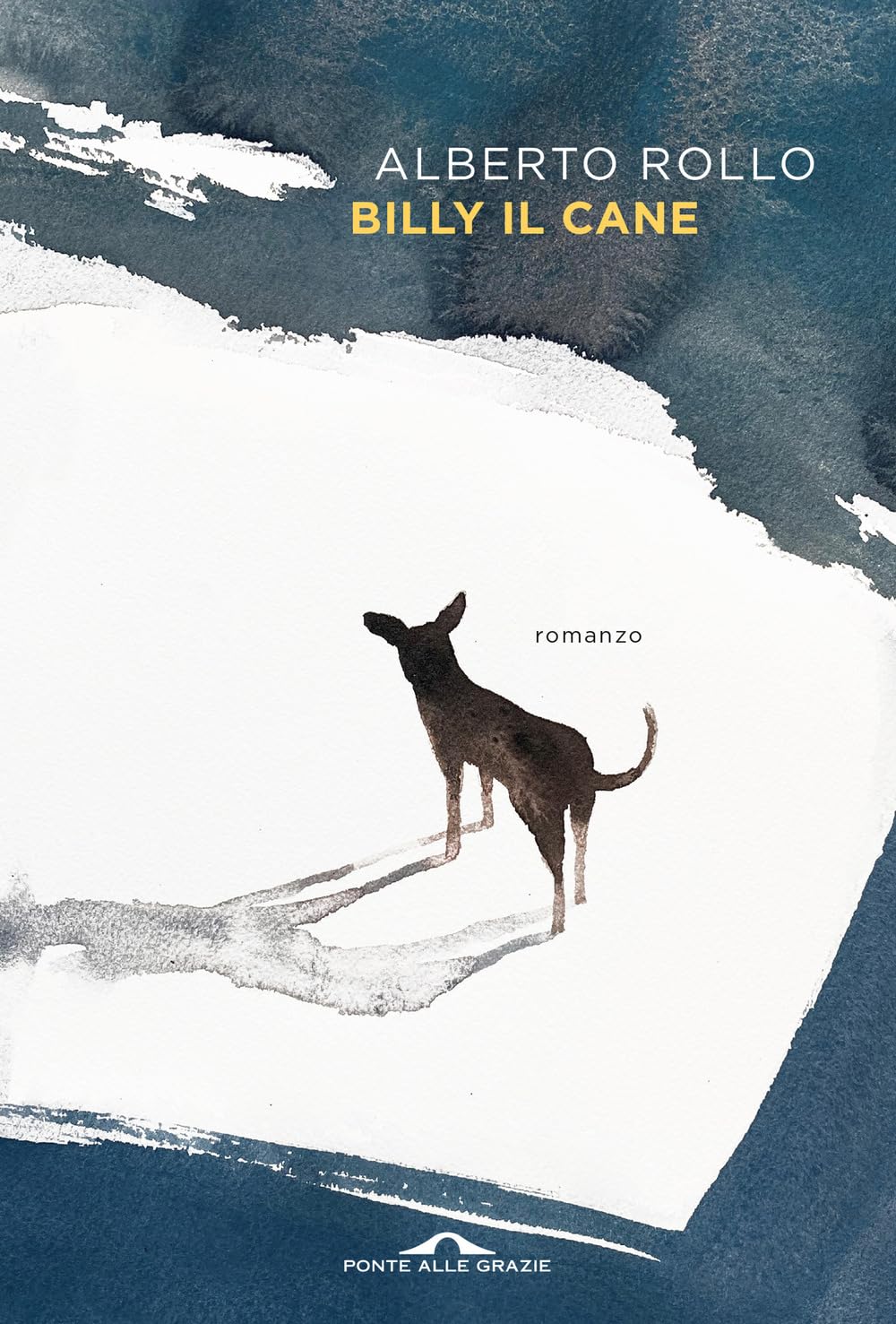
Alberto Rollo, Billy il Cane, Ponte alle Grazie 2024 (pp. 192, euro 16,90)
“Che cosa si prova a essere un pipistrello?”. Una domanda paradossale. A porla non è stato un etologo, ma un filosofo, Thomas Nagel, cui premeva di far presente l’inadeguatezza della nostra mente umana a immaginare l’esperienza di un animale tanto diverso. Si direbbe non la pensasse diversamente un altro pensatore, Ludwig Wittgenstein, certo del fatto che “se un leone potesse parlare, noi non potremmo capirlo”, perché lui vive il suo mondo, un mondo di cui noi uomini non sappiamo nulla, o quasi.
Quella che sembrerebbe la sottolineatura di una limitatezza umana si ribalta in un’indiscutibile superiorità in altri: “l’animale – affermava Martin Heidegger, senza curarsi di quale creatura si parlasse – è povero di mondo”. Può anche vivere con noi, come fanno un cane o un gatto, ma è solo apparenza quel sentimento di vicinanza che molti provano. Un abisso ci divide infatti dall’animale che, a differenza degli umani, non esiste, ma semplicemente vive, chiuso nel suo mondo, capace di un’esperienza che non sa tradursi in comunicazione, in linguaggio. Vecchia storia questa: gli animali non parlano, dunque non pensano. Se sembra a volte che lo facciano (quanto volte restiamo incantati a osservare lo sguardo attento del nostro gatto che guarda non si sa cosa fuori dalla finestra o quello imperscrutabile del nostro cane che punta gli occhi all’orizzonte come fosse preso da una riflessione profonda), è perché la domesticazione gli ha fatto assumere posture – se non proprio di pensiero, di sentimenti senz’altro – che sembrano rivelare una somiglianza con le nostre (è o stesso Heidegger a concederlo).
Ebbene, l’autore di questo romanzo è mille miglia lontano – sempre che se ne sia mai interessato – da posizioni simili. Il suo cane Billy pensa eccome; ma di più: parla, tra sé quantomeno: “la lingua degli umani mi è entrata dentro senza fatica, più come una pioggia che cade dal cielo che come una conquista (…) so che potrei farne a meno di questa lingua, ma ci sono impastato dentro da una vita”. E dunque, se non risponde al richiamo del padrone non è perché non lo capisca, ma perché, per una volta, ha deciso di non farsi trovare.
“‘Billy!’ chiamo (…). Sono sicuro che mi sente. Mostrati, sussurro fra me e me”: un’altra voce subentra nella narrazione di tanto in tanto, nella forma di brevi corsivi: la voce del padrone del cane – del suo tutore anzi, come preferisce definirlo Billy –, che non si rassegna alla sua scomparsa, del tutto ignaro delle motivazioni, e delle capacità soprattutto, del suo animale.
“Della loro lingua possiedo, me ne rendo conto, una certa proprietà. (…) non sapranno mai che io sapevo, che so, e che sapendo posso competere”, pensa Billy, cui neanche la memoria fa difetto. Ci racconta la sua vita infatti, a partire da quando era “un cucciolo bastardo strappato a una cucciolata bastarda” – un cane come tanti, simile a quello che gli acquerelli di Nicola Magrin ci mostrano –, un cane che passando poi da un padrone all’altro può “spiare la follia degli umani”, finché arriverà alla sua casa, dove vivrà per anni, la stessa casa da cui però ad un certo punto ha deciso di andarsene. Perché? Per sentirsi “splendidamente solo”, per lasciarsi pervadere dalla sensazione nuova, ma presentita, di sentirsi “antico”: “antico come un lupo”, come il lupo di cui serba memoria pur essendogli mancata la vita del branco. Ma soprattutto, motivato dalla volontà di sfuggire “all’uomo in camice bianco” cui i pur amorevoli padroni finirebbero per consegnarlo: è ad una prevedibile, imminente eutanasia che il vecchio e ormai malandato Billy ha deciso di sottrarsi. Andando a morire solo.
È forse soprattutto il guadagno che si riceve dall’avere un cane che questo romanzo vuole spiegare (per questo aspetto, vicino a Autobiografia dei miei cani, in queste note lo scorso settembre): “sapevo che lui c’era, non perché mi guardasse – se lo faceva erano occhiate di perplessa considerazione – ma perché c’era e non metteva distanza”, ammette il padrone di Billy. Anche se, vista dalla parte dell’animale, la cosa è più complessa: quando l’uomo lo fissava, come cercando di “arrivare dove un cane è un cane”, lo sguardo che riceveva in contraccambio veniva “da quella distanza di cui non sospettava l’esistenza. Vedeva l’abisso, vedeva dentro la convessità dei miei occhi il precipizio del Tempo”, ma chissà se era davvero capace di raccogliere il muto ammonimento che in quel momento gli veniva: “non sono tuo fratello”. Eppure sono attimi di autentica vicinanza quelli che talvolta scoccano fra l’uomo e il cane, ed è quest’ultimo a rilevarlo.

Momenti di riflessione come questo affiorano continuamente a ritmare la storia e, si badi, se chi ha consuetudine con un cane ci si riconoscerà, gli altri vi potranno trovare il segno di come considerare la propria relazione con l’animale, per rintracciarvi ciò che da esso ci differenzia, coincida da sempre con lo sforzo di definire noi stessi, animali umani. Anche se, nel romanzo di Rollo, questo bisogno non sminuisce mai l’animale, non lo subordina entro una gerarchia: l’alterità dell’animale, riconosciuta dall’uomo, assume alla fine i tratti di una suprema dignità: “Qui – pensa Billy rintanato nel suo ultimo nascondiglio – mi posso consegnare al nulla senza la pietà dei tutori. Quella che devono già esercitare per i propri simili. (…) Io vado, con il mio corpo, dentro un corpo più grande, cerco luoghi felici”. Conscio del fatto che “gli uomini non possono essere felici, ma possono immaginare quanto potrebbero esserlo, ed è perciò che talvolta cercano in noi la risposta alla letizia di cui sospettano solo l’esistenza”.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.
