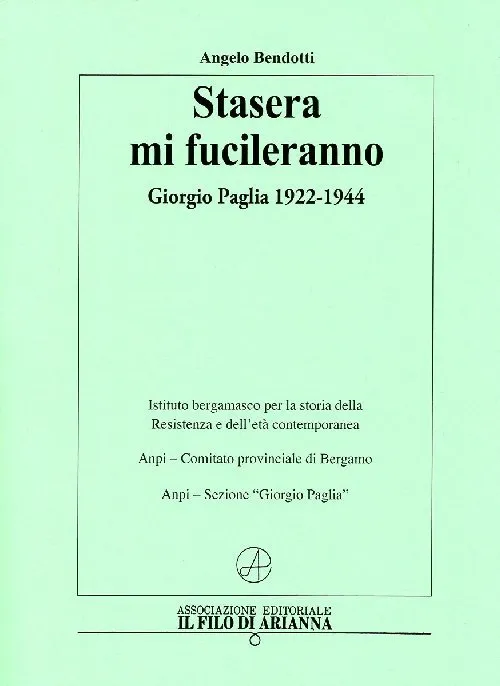
Angelo Bendotti, Stasera mi fucileranno. Giorgio Paglia 1922-1944, Associazione editoriale Il filo di Arianna 2024
È l’ultimo libro che Angelo mi ha inviato, nel novembre dell’anno scorso: l’ultimo in ordine di tempo, nella nostra pratica di scambio di ciò che via via pubblicavamo, fin da quando ci eravamo incontrati nella sua Schilpario, dove l’avevo conosciuto nella veste di ideatore e organizzatore del locale museo etnografico, uno dei primi in Lombardia.
Ma è anche l’ultimo dei suoi libri, questo, perché Angelo è morto un mese dopo, poco prima di Natale.

In queste note, di un altro libro di Bendotti avevo parlato, a inizio aprile 2019. Si trattava di Nel segno di Fenoglio. Lo straordinario e il vero, libro nel quale lo storico riconosceva apertamente che “per studiare la storia della lotta partigiana bisogna innanzitutto partire dai grandi scrittori”, perché la letteratura non è un di più rispetto alla ricerca storica: “la storia é anche racconto della storia”. Una convinzione tradotta nei fatti: chi ha ascoltato Angelo nel corso della presentazione dei suoi libri ha colto la sua attitudine narrativa; chi li ha letti vi ha trovato sempre un nucleo che avrebbe potuto essere sviluppato sino a diventare un romanzo. Un nucleo o a volte un personaggio, come il Fritz Langer, Untersturmführer delle SS di Bergamo fra il 1943 e il ’45, protagonista di un altro libro di Bendotti, L’amico Fritz: mi era risultato inevitabile, leggendolo, pensare al protagonista delle Confessioni del cavaliere d’industria Felix Krull di Thomas Mann. Come quello, anche la figura dell’ufficiale tedesco si propone come una di quelle che si prestano a una trasposizione narrativa, o cinematografica. Il che si deve alla capacità di scrittore che Angelo rivelava rendendo la doppiezza congenita dell’uomo, calcolatore e opportunista ma si direbbe, anche, portato a credere alla parte che di volta in volta recitava, a indossare quando gli conveniva la maschera del “nazista buono”, sensibile alle singolarità delle persone con cui veniva a contatto; gran seduttore, nel senso più ampio del termine; a suo modo coerente nella propria attitudine all’ambiguità.
È una relazione filiale, il nucleo narrativo che mi sembra invece dare ulteriore significato alla vicenda di Giorgio Paglia, partigiano ventenne. Figlio di un fascista della prima ora, legionario della Marcia su Roma, caduto nella guerra di Etiopia, Giorgio sa emanciparsi dalle idee del padre mantenendo la dedizione che, bambino e poi ragazzo, l’aveva legato a lui; mentre la madre, che segue nelle sue peripezie il figlio, sino alla fucilazione, capisce la complessità di questo sentimento. Non lo giudica. A suo modo, dolorosamente, lo condivide.
Il rigore dello storico, l’incontrovertibilità dei documenti e la loro lettura critica convergono, in questo come negli altri libri, con la perizia del narratore: Angelo sapeva che la verità storica ha bisogno di essere proposta attraverso il racconto per risultare coinvolgente, e persuasiva. Ma sapeva anche che occorre “trovare parole sempre nuove” se si vuole “parlare ai giovani, giovani com’erano giovani quelli che scelsero di andare in montagna anziché arruolarsi e di rischiare la propria vita nella lotta armata”: la Resistenza come straordinaria storia di giovani, è questo che Angelo Bendotti ci ha innanzitutto raccontato.

