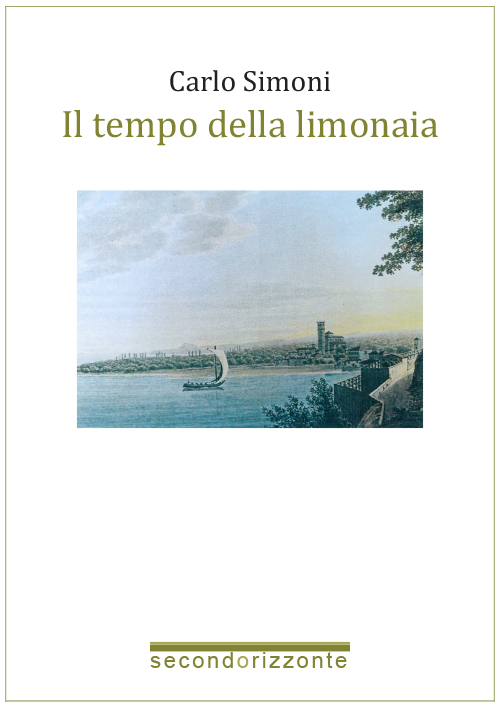
Il fragore dei magli si ode sin dall’ingresso nel paese, ma non giunge fin là, alle limonaie vicine al porto: Toscolano non è paese di giardini d’agrumi. È Gargnano quello, dove se non sono carbonai o pescatori sono giardinieri, e vivono quieti il loro tempo, segnato dal sole e dalla luna, e dalle stagioni. Qui no, qui a dir le ore, estate e inverno, notte e giorno, è l’arrivo da Desenzano dei barconi carichi di stracci per far carta, il passo dei mulattieri coi loro animali che van lungo il fiume a portar sacchi di quella materia per poi riportar di nuovo giù al porto risme candide, e a contare i minuti non è il battere degli orologi ma quello dei magli, che di quegli stracci fan la poltiglia da cui si trae il foglio.
Laggiù alla Capra però, come si dice la piana di ulivi che stan sulla parte sinistra della penisola fatta dal fiume, è ancora la campana della parrocchiale a marcare il tempo, perché oltre la chiesa non ci sono cartiere ma limonaie, le poche che prosperano nel paese della carta.
È là che Geraldo andava, ogni mattina, non per mescolarsi ai traffici del porto però, ma a badare al suo giardino. Non era vecchio, e pure ansimava sotto il peso della gerla. Le doghe, ben commesse, non lasciavano filtrare che qualche goccia d’acqua, ma i suoi passi, malcerti per la fatica, ne facevan traboccare secchiate ad ogni gradino, sì che quando arrivava alle piante la gerla s’era per quasi metà svuotata. La deponeva inginocchiandosi un poco, poggiandone il fondo prima allo scalino a tre piedi e poi a terra.
Il bambino che l’accompagnava ne cavava allora l’acqua, con un secchio, e la versava attorno ai fusti delle piante, ancora giovani.
Geraldo l’aveva portato con sé, la prima volta, un giorno di dicembre, e al bambino i frutti che pendevano tra le fronde di quegli alberi chiusi tra le assi e i vetri che sono la veste del giardino in inverno, erano sembrati animali vivi, gialli uccelli mai veduti: sarebbe stato questo il primo ricordo che, ormai uomo fatto, avrebbe conservato. Insieme ad un altro, di quando l’anno successivo, alla limonaia aveva visto comparire strani personaggi, silenziosi e garbati, colla barba, lunghi riccioli che scendevano accanto al viso e neri cappelli dalla tesa larga: se n’erano stati a soppesare ed osservare minuziosamente i cedri che intendevano acquistare. Provavano a metterli in certi vasi a forma d’uovo che tiravan fuori dai loro sacchi. Si erano decisi alla fine e avevano lasciato un bel gruzzolo a Geraldo, che aveva spiegato al suo garzone esser quelli ebrei di Riva, che ogni anno venivano lì a cercare il frutto necessario per celebrare una delle loro feste grandi. La festa cosiddetta delle capanne.
Ma gli ebrei rivani eran cosa di un giorno. Geraldo teneva alle tre piante di cedro che aveva piantato per poterli far venire fin lì, ma eran le altre piante, quelle di limoni, a chiedere per il resto dell’anno il grosso del suo lavoro.

Svuotata la gerla d’acqua, tornava a ricaricarsela e a scendere con quella sulle spalle fino alla riva. Aveva da poco passati i trent’anni, era un uomo sano, ma non lo si sarebbe potuto dir robusto. La schiena gli doleva per giorni dopo che, una volta la settimana almeno, s’era dato al lavoro di dacquar le sue piante. Un lavoro da non fare nelle ore calde. Le piante non vogliono acqua quando le foglie stanno al sole, ma solo alla sera, quando la brezza che viene dal lago le rinfresca, insieme asciugando il sudore degli uomini, e il Pizzocolo, dietro al quale il sole è da poco tramontato, segna colla sua grande ombra le acque fin quasi all’altra sponda, illuminata ancora. Il Baldo sembra vicino a quell’ora, a cento passi si direbbe, perso nella foschia rosata della sera.
Non aveva un pozzo Geraldo, e dunque per irrigare il suo giardino doveva far questa fatica. Lui e, per quel che lo poteva aiutare, Luchino, che fosse stato per lui ci sarebbe vissuto addirittura, lì, tanto gli piaceva coltivar limoni.
Il giardino d’agrumi di Geraldo era l’ultimo di quelli che s’allineano oltre la contrada del Porto. S’era svenato per rimetter in piedi questo rudere, perché non era niente di più quando l’aveva adocchiato. Lasciato andar in malora da quando il padre di sua moglie era morto. Proprio lì, cadendo nel mentre copriva la limonaia. Era l’ottobre di venti anni prima. Geraldo non aveva neanche fatto in tempo a conoscerlo, e così quel che aveva imparato l’aveva imparato dai giardinieri che il loro lavoro lo fan di mestiere. Dal Vincenzo, in ispecie, che non era mai stato geloso, e teneva i giardini lì accanto dei signori che avevan palazzo al Porto. Quando gli aveva chiesto di aiutarlo perché voleva mettere a coltura il giardino del suocero quello gli aveva detto ch’era matto. Fin la terra avevan portato via, mica solo le pietre dei pilastri, le assi, i vetri… Era una rovina. Non lo vedeva?
Ma Geraldo l’aveva sognata una limonaia sua. Fin da quando, perso nelle nebbie della Bassa, vedeva arrivare quelli del Garda a vendere limoni ai padroni della terra su cui lavorava anche suo padre e aveva lavorato suo nonno, e dicevano che là, sul lago, erano proprio quelli a tener lontana la pellagra, i limoni, e poi il pesce, l’olio… Altro che polenta oggi e polenta domani.
Una volta uno di quei carrettieri che venivan di là gliene aveva dato uno, ammaccato, e lui l’aveva assaggiato. Non aveva mai sentito in bocca una sensazione di quel genere. Sembrava che la lingua si fosse ritirata, e poi i denti eran diventati asciutti che in bocca non gli sembravano suoi. Però gli era piaciuto, perché veniva da là, dal lago.
Non gli aveva detto di rimanere suo padre, quando era arrivato all’età di poter andare via da solo. Erano due braccia in meno, certo, però se restava era anche un figlio di più a patire la fame. Che andasse a cercar fortuna al Garda, visto che il contadino non lo voleva fare.
Geraldo s’era messo con uno che girava per i paesi a vender nastri e fazzoletti: di tutti i colori e per tutte le borse, diceva. Con quello era arrivato a Toscolano, e non aveva voluto andar più via. Aveva messo un banco al Ponte. La domenica lo spostava alla Piazza, e delle volte lo portava fin a Maderno. Aveva cominciato così a metter da parte qualche soldarello e allora si era inteso con una di quelle ragazze che gli giravano intorno a guardare i suoi nastri. Era stata una battaglia: la madre della Betta aveva fin chiamato il prete a benedire la figlia. Non voleva che andasse moglie a un merciaino che, non aveva dubbio, cercava solo d’attaccar il cappello al chiodo. Perché lei, pur vedova, non stava male e la sua figlia, l’unica, poteva sperare di maritarsi meglio. Ma dai e dai, la Betta e Geraldo si erano sposati, e lei s’era messa nel commercio del marito. Avevano messo in piedi una bottega nella via di Mezzacampagna, oltre al banco che Geraldo ormai metteva solo nel giorno di mercato. Col passar del tempo a vendere si vedeva sempre più spesso lei, perché Geraldo andava giù al Porto, a studiare quelle poche pietre che eran rimaste della limonaia, frattanto passata in eredità alla Betta, colla morte di sua madre.
Non li diceva in casa i suoi intenti. Solo col Vincenzo ne parlava, e solo quando ebbe un’idea di quel che occorreva e delle spese cui bisognava andar incontro parlò.
Quel luogo era per la moglie maledetto. Se lo ricordava lei, bambina, il corpo di suo padre per terra, che sembrava avesse preso sonno in mezzo alle sue piante. Ma Geraldo seppe rassicurarla, e l’impresa ebbe inizio.
C’eran voluti sei anni. Le pietre era andato lui stesso a rimediarle, su ai piedi del Monte Castello, e s’era fatto aiutare per rappezzare la muraglia a mattina, che era mezza caduta, e i pilastri, mangiati come pane da quelli che avevan trovato convenienza a portarsi via le pietre già squadrate. Anche il castagno per gli sparadossi e i canteri l’aveva trovato sui monti sopra il paese, e dunque quei pali per reggere le assi del tetto non erano costati quanto il larice per fare il resto: le tavole per coprire la limonaia, per darle un tetto alla fine della bella stagione, e le altre per far le portiere e le usciere, e i misili per tener le une e le altre e così chiuderla a mezzogiorno, e poi le filarole che van da pilastro a pilastro. Tutta roba che aveva dovuto far venire dal Tirolo, colla barca. Erano stati denari sonanti: mica poteva andar lui a prenderla di là del confine. Invece la terra buona – perché quella di lì non dava sostanza alle piante – quella sì, non se l’era fatta portare dalle donne della Veronesa, che fan quel lavoro da bestie. Era stato lui a portarla di qui del lago, lui e certi barcaioli suoi amici che si erano contentati di poco. E finalmente era arrivato a metter giù le prime piantine, cresciute sei anni nel giardino di uno di Gargnano che gliele aveva date per antica amicizia col padre della Betta. Avevano cominciato, lui e il bambino, a dacquarle ogni settimana quando ancora Vincenzo era sullo scalino, nel giardino che confina con quello di Geraldo, a finir di raccogliere i limoni della seconda spiccanda. Un anno buono, quel milleottocento e sei: con quelli che avevan fatto nella prima, a maggio, Vincenzo diceva che ogni pianta ne aveva fatti dai cinque ai seicento.
Gli pareva già di poterli toccare colle mani, a Geraldo e a Luchino, i limoni che sarebbero venuti, i loro limoni, e si vedevano a tornare coi cavagni pieni tanto da aver bisogno di caricarne carretti.
Le stagioni eran corse via come una ruota, spiccanda dopo spiccanda, e gli anni erano passati senza che le giornate, alla limonaia cambiassero. Neanche quando era arrivata la guerra. La gente di Toscolano, portata di suo a tenersi alla larga dalle mene dei politici e dallo strepito delle soldataglie, vi era stata a forza immischiata, e s’era rifugiata nella Valle delle cartiere e su per i monti quando il 16 del Febbraio 1814 i Francesi, guidati niente di meno che dal Viceré Eugenio, avevan cacciato da Salò gli Austriaci, e la loro flottiglia li aveva inseguiti sino a cannoneggiarli sulla strada che entra in Maderno.
Geraldo no, lui era rimasto giorno e notte alla sua limonaia in quelle turbolenze, e là era anche quando gli Austriaci si erano asserragliati proprio allo sbocco della Valle, erigendo barricate sulla sua riva sinistra, presso il ponte, e terrapieni sulla destra. Ma la guerra aveva raggiunto anche le acque del lago: i legni napoleonici si erano scontrati con quelli degli Austriaci proprio davanti a Toscolano, avendone ragione.
Tra i Toscolanesi che stavano sulla riva a veder la battaglia c’era anche Geraldo, naturalmente. Invano si sarebbe invece cercato, accanto lui, Luchino. Fattosi oramai un ragazzo forte e curioso del mondo, per il mondo se n’era andato. Non dietro ai travaini, com’eran detti gli apprendisti delle cartiere, a cercar fortuna in quelle di Rovereto dove le paghe eran migliori. Luchino di lavorare al chiuso, e con uno alle spalle a vedere che tu non perda tempo, non aveva mai voluto sapere, e dunque ben più a settentrione di Rovereto era andato: a fare il boscaiolo, nei boschi dell’Impero. Una volta, uno di Maderno, che andava lontano a vender calendari e stampe, aveva detto d’averlo visto nella valle dell’Inn; un’altra, il figlio di un pastore, che non aveva voluto seguire la sorte del padre e s’era dato alla vita del contrabbandiere, aveva assicurato di averlo incontrato nella Pustertal.

Le ossa di Geraldo scricchiolavano oramai, e quando c’era da dacquar le piante o coprire la limonaia doveva prendere a ore qualcuno vecchio quasi quanto lui, perché i giovani erano tutti alle cartiere. Non si lamentava però, né brontolava come Betta per quel figlio che non si sapeva dov’era: non se n’era andato pure lui, da giovane? non aveva lasciato la famiglia per farsi una vita nuova? E forse proprio perché se l’era fatta da solo continuava ad andargli bene. Per questo, ma anche per altro: non avrebbe scambiato la sua condizione con nessuno dei signori che stavano in paese e tenevano cartiere nella Valle, quando era su, tra i rami delle sue piante a spiccare i suoi limoni, e a riempirne il grümiàl, la sacca di pelle di capra che gli stava legata in vita. Si sentiva in paradiso, e la sera raccontava a Betta come andava la spiccanda, mentre lei gli diceva dei nastri nuovi arrivati quel giorno dal paese dove li facevano, un paese del Comasco, su un altro lago che loro non avevano mai visto. Sì, anche questo gli regalava la limonaia. Perché lo sapeva, Geraldo: vi sono uomini che credono d’incontrare la donna di cui non possono fare a meno in diversi successivi esempi del genere femminile nei quali s’imbattono, ed altri invece che la Donna la san vedere in un esempio soltanto, e vedutolo non han più occhi per gli altri che incontrano o potrebbero incontrare. Ed era fra questi ultimi Geraldo, che pure non s’era per questo messo l’animo in pace, come chi reputa che nulla più possa venir a turbare la sua vita. Lui s’era piuttosto fatto persuaso, a furia di almanaccarci, là, nel mentre curava i suoi limoni, che la solitudine è il destino di chi nasce, e che solo chi sa di non poterla vincere ma soltanto addomesticare può vivere, non felicemente forse, ma serenamente, almeno.
Così dunque avevano di fatto stabilito di vivere Geraldo e Betta. Lei alla bottega a vender nastri alle giovani per farsi ammirare, ai giovani per dichiararsi a quelle, alle donne non più giovani che volevan ricordare a chi sapevan loro che giovani lo erano pur state. E lui al suo giardino. Lui che, quando il lago era calmo e non faceva udire la sua voce, se ne stava le ore, come qualcuno giurva d’averlo sentito dire, ad ascoltare i suoi alberi a crescere. Solo, e al tempo stesso certo di non esserlo per davvero; come del resto Betta, che non avrebbe saputo vivere con il marito in bottega, e che passava le sue giornate sapendo che anche quella sera lui sarebbe venuto, come ogni sera.
Altri anni ancora sono passati, e Betta è sempre dietro il suo banco colorato di fettucce variopinte. Geraldo passa invece i suoi giorni accanto alla stufa, o alla finestra di dove vede il lago, nella casa che tanto tempo fa si sono fatti sopra alla bottega. Non ha più forza nelle gambe che gli basti a scendere alla limonaia a guardare me, Luchino, a continuarvi il lavoro suo, e che anche mio era stato prima che il mondo mi chiamasse. Per portarmi tra quei boschi, dove m’era parso che la vita procedesse in un modo tutto diverso da quel che era stato là dove fin allora ero vissuto. Che lassù accadesse sempre qualche cosa, m’era sembrato, e altro stesse per accadere. Ogni grande abete che la mia ascia abbatteva mi sembrava che un avvenimento avesse interrotto il fluire del tempo, e la giornata ne fosse segnata ed avesse per questo il suo senso; m’ero sentito fiero, i primi tempi, di esser della squadra che di quegli avvenimenti era artefice. Poi, poco a poco, avevo cominciato a non sentir più quella fierezza, a dispiacermi invece, per quelle piante che morivano crollando come grandi animali sotto lo sguardo delle sorelle, e sempre più forte si era fatta in me la nostalgia di vederle crescere le piante, di farle crescere, come una volta, quand’ero un bambino, là, con mio pare, e quel divenire lento, che solo chi non stava alla limonaia tutto il giorno non sapeva vedere, riempiva il tempo.
È quel tempo che ho riguadagnato, tornando infine alla limonaia, alle sue giornate che fluiscono quiete, e mi sembrano, a momenti, addirittura tornar sui propri passi se guardo Aldo, il bimbo mio e di Agnes, la donna che fin qui mi ha seguito. Aldo ogni giorni viene con me: ancora piccolo per prestarmi aiuto, se ne sta le ore a giocare sulla riva coi sassi che il lago ha rotolato e levigato sino a farli tondi e lisci. Come limoni.
In questo racconto, scritto da Carlo Simoni per AB, ricompaiono alcuni personaggi del suo romanzo Il segreto dell’arte (Cierre, 2012).

Il racconto è disponibile anche in formato audio

Clicca qui per scaricare il testo del racconto in pdf
