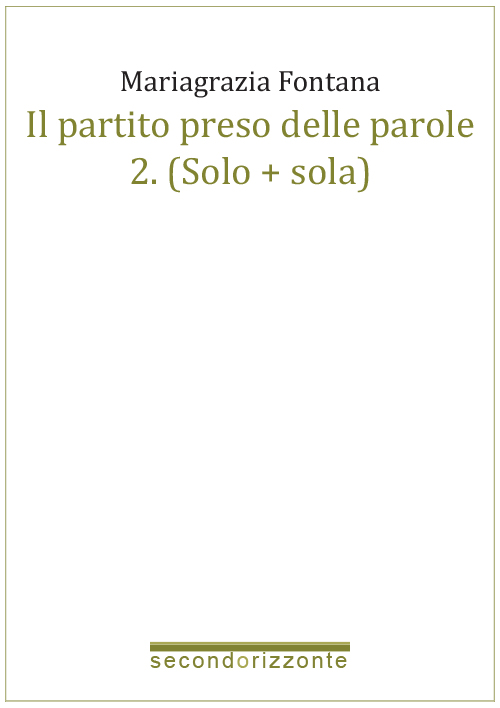
2. (Solo + sola)
Il solito sgabello nel solito bar. Era un locale senza pretese, niente happy hour, niente musica, niente macchinette mangiasoldi. Un bar di quartiere mai rinnovato, tavoli di legno segnati dalle bruciature di sigaretta, a testimoniare che per anni nei bar ci si era potuto fumare, e dalle cicatrici a cerchiettini lasciate dai calici. Sembrava pulito, anche se era tenuto un poco in penombra, forse per lasciare indefiniti i pensieri consumati, i ricordi rosicchiati dal tempo degli avventori, quasi tutti anziani, che di passato da dimenticare non mancavano.
Lui si sedeva al bancone, in uno solo non occupi un tavolo. Sceglieva l’ultimo posto, quello dove il banco aveva già fatto la curva e ci si poteva appoggiare al muro. Non aveva bisogno di ordinare: Beppe il barista, lo conosceva, anche se in verità parlati non s’erano parlati mai. Sapeva che lui beveva birra, birra da poco, per poterne ingurgitare di più.
Dick era tollerato, il barista lo lasciava accovacciarsi sotto il suo sgabello, perché sapeva che era un cane ben educato, uno di quelli che non attacca briga, che non abbaia, uno che gli basta stare con il padrone, andare dove va lui, sedersi dove lui si siede e fare silenzio quando si deve. Quel cane non lo abbandonava mai e non pretendeva gran che. Certo c’era da portarlo fuori almeno due volte al giorno, ma se proprio Franco non era in grado, Dick si arrangiava da solo. Aveva imparato ad afferrare con le zampe anteriori la maniglia della porta d’ingresso e ad appendercisi di peso fino ad aprirla per poi scendere le scale e fare i suoi bisogni nel cortile condominiale. Tanto lì erano tutti poveracci, per lo più immigrati, e alla pulizia mica ci badava nessuno.
A Franco non piaceva quella storia del cane che sgusciava da solo in cortile, hai visto mai che i cinesi del quarto piano se lo cucinavano per cena. Non hanno proprio religione quelli, per loro un cane è come un pollo. Ma certe sere non ce la faceva proprio ad uscire, era come insabbiato in una tristezza dolciastra, di quelle che ti si attaccano come la colla e ti imbrattano di grigio dentro. Altre era troppo sbronzo per reggersi in piedi e neanche riusciva a raggiungere il letto. Succedeva che si svegliasse il mattino rannicchiato sotto il tavolo della cucina, la faccia in una pozza di grappa da poco, colata dal collo della bottiglia.
Aveva cominciato a esagerare con l’alcool, poco per volta. Non che avesse deciso di imboccare quella strada, era la strada che gli si era distesa sotto i piedi da sola, prima che lui potesse realizzare, scegliere. E di bicchiere in bicchiere il tasso alcolico lievitava e ogni sera di bicchieri ce ne voleva uno di più.
La birra aveva il pregio d’invogliare al rutto, e il rutto, si sa, manda giù. E lui da mandare giù ne aveva parecchio.
Aveva deciso che non era una buona cosa bere da solo, per via di quella parola solo che gli prudeva sulla pelle. Non sarebbe diventato un vecchio ubriacone, di quelli che trovano stecchiti in casa magari dieci giorni dopo la morte, già decomposti. Allora aveva preso l’abitudine di andare verso sera al bar di fronte, lui e Dick, a bere sbirciando la strada polverosa di fuori. No, Dick non beveva di certo, anche se una volta l’aveva sorpreso a leccare del rosso che lui aveva rovesciato sul tavolo. Beppe, gli dava sempre un pezzo di pane vecchio e il cane gli faceva festa, gli leccava le mani, raddrizzava le orecchie come a ringraziare.
Era una bella compagnia un cane, l’unica di cui un uomo si potesse fidare. Un cane non pretende, al massimo butta fuori due versi a fauci spalancate per farti capire che una corsetta non gli andrebbe storta, o che un poco di cibo a riempirgli la pancia sarebbe gradito. Soprattutto un cane non parla, non ti racconta i fatti suoi e non ti chiede i tuoi, non ti dà il tormento, non ci da sotto con la rava e la fava, non ti vuole diverso da ciò che sei. Con un cane si può stare in silenzio come se si fosse soli.
Franco aveva capito molte cose sullo stare soli. Da solo s’era allenato a sopravvivere quando la nostalgia gli toglieva la forza, a blandire la collera quando gli deflagrava dentro. La sua vita si torceva giorno dopo giorno come il tronco d’un ulivo, dentro di lui il buio s’insediava e Dick stava lì, presente, silenzioso a vederlo sgonfiarsi poco a poco come una gomma bucata, senza recriminare, senza consigliare, senza pretendere.
Forse era per quello che tutti i punkabbestia avevano un cane, rognoso come loro, sporco lurido, ma accoccolato vicino, all’apparenza felice di quel poco. E loro, i punkabbestia, camminavano con il cane a fianco, mai legato per via di quell’illusione della libertà, la barba lunga, i vestiti che non si potevano guardare e dormivano per strada, cane e punk abbracciati, che quasi si assomigliavano rannicchiati nel vano di un portone. Chissà se erano felici? Chissà se spogliarsi di tutto, se ridurre la vita all’osso, a mera sopravvivenza, era meglio? Forse loro avevano capito quello che conta davvero.
Lei glielo aveva lasciato Dick, in uno slancio di generosità imprevisto che lo aveva stupito. Quella donna era così, ti buttava fuori casa e poi ti regalava il cane. Due giorni dopo quella sera dell’appostamento sotto casa con la carabina carica, si era presentata alla porta delle sue due stanze fetide, bella, luminosa, ma con un’onda di tristezza nello sguardo che lui volle interpretare come rimpianto, o forse malinconia. Forse lui cominciava a mancarle?
All’inizio gli era balenato il dubbio, la speranza che lei lo rivolesse con sé, ma era stata la frazione di un secondo. Non era da lei tornare sui suoi passi, lei era una calma, non irosa come lui, lei non s’infiammava, lei ponderava, analizzava e poi alla fine decideva. E allora era finita, quando lei si metteva in testa una cosa non gliela levava più neanche il Padreterno.
Non l’aveva invitata a entrare, non voleva esibire il suo squallore, la sua disperazione e tutta quella solitudine arrampicata sulle pareti, distesa sul pavimento sporco. Aveva con sé il cane e glielo stava consegnando. Il loro cane, quello che avevano scelto insieme al canile perché il bambino s’era fissato con il desiderio di un animale. E neanche a farlo apposta, quel bambino anemico aveva scelto il cane più pulcioso, svergolo e sgangherato di tutti quelli disponibili. Forse era la pena che lo muoveva, forse il bambino si specchiava nel cane, o forse lei l’aveva infettato con quella storia di aiutare deboli e indifesi, di non tirarsi indietro, di stare dalla parte degli ultimi. Figlio sfigato e cane sfigato, bella accoppiata.
Ma lui con lei non riusciva a farsi intendere, provava a comandare, a dire la sua, ma lei, che con le parole ci sapeva fare, lo metteva nel sacco alla svelta, squadernando delle buone ragioni che lui neanche aveva considerato. Allora lui alzava la voce, metteva in fila due frasi stitiche e le urlava fuori con impeto astioso, come se il volume potesse compensare tutto quello che non riusciva a dire.
A ben vedere, Dick era un gran cane e con lui s’era inteso subito, subito l’aveva individuato come capo branco. Almeno il cane capiva qualcosa, almeno per il cane Franco contava qualcosa. O forse era perché toccava a lui portarlo fuori la sera e la mattina presto. Era così, moglie e figlio sceglievano e lui si pascolava le grane.
Erano impagabili le passeggiate col cane, soprattutto il mattino presto. Dick cominciava a leccargli le mani già prima delle sei, e se lui fingeva di non sentire, passava ai piccoli morsi, solo un accenno, forse un avviso che se non si fosse alzato avrebbe addentato di più. Franco s’infilava una tuta, si tirava in testa il cappuccio e fuori, Dick davanti a correre, poi ad annusare tutti gli angoli e i portoni per decidere se quello era il posto giusto per farci pipì. Che non la faceva tutta insieme come fanno i cristiani, ne buttava lì un goccetto e poi ricominciava a correre. Dopo qualche minuto, eccolo pronto per il secondo goccio, e poi per il terzo. E in mezzo, fra una pipì e l’altra, aveva un gran da fare a zampettare e saltare. E gli toccava accelerare anche a lui per stargli dietro, anche se Dick aveva ben altro fiato e filava come un razzo avanti e poi indietro per vedere se Franco non si fosse perso, e gli addentava la tuta perché lui si desse una mossa, perché la città addormentata era un sogno da godersi tutto, senza rallentare, senza perdersi nei pensieri.
Lei glielo stava affidando e quel dono lo sorprendeva. Avrebbe dovuto essere imbestialita con lui per la cazzata del fucile. Invece, eccola con cane al guinzaglio, ciotola e cibo. Che avesse annusato la sua disperazione? Che lui le avesse fatto pena? E allora perché non se lo riprendeva? Perché non veniva a proporgli di riprovarci invece di liquidarlo con un cane, come se anche lui non fosse che una bestia?
Non glielo chiese, l’orgoglio impediva la domanda. E poi non avrebbe saputo come, che parole usare per farsi capire, per proporre senza implorare. Che un maschio deve conservarla la dignità. E poi c’era il brizzolato della bmw, quello con la faccia malinconica. Meglio tacere.
Senza neppure un grazie, aveva preso il guinzaglio e le aveva chiuso la porta in faccia. Che andassero al diavolo lei, quello della bmw e la compassione che le aveva letto negli occhi. Lo metteva a posto con un cane, come se una bestia bastasse a riempire il vuoto d’amore.
Neanche l’aveva guardato Dick quella sera, perché gli sembrava troppo poco, una miseria, un cane al posto di una famiglia, che faccia tosta.
E invece Dick era ben più di una bestia, lui capiva un sacco di cose senza bisogno di dirgliele, lui sapeva quando era ora di mettersi tranquillo, di dormire o di fare finta di dormire. Il cane lo teneva d’occhio a modo suo, senza rompergli l’anima, senza dirgli che cosa dovesse fare.
Una notte in cui Franco era svenuto e giaceva incosciente sul pavimento, un tasso alcolico poco compatibile con la sopravvivenza, Dick s’era attaccato alla maniglia della porta d’ingresso con tutto il suo peso, era uscito e aveva cominciato ad abbaiare e a grattare alla porta dei negri del Camerun per chiedere aiuto. E i negri, incredibile a dirsi, avevano chiamato un’ambulanza. Forse questi giargia, non tutti, questi del Camerun, non erano poi così male.
Bella bestia quel cane, bel cervellino, bella prontezza di spirito e, soprattutto, a lui ci teneva, altrimenti chi glielo avrebbe fatto fare di sobbarcarsi tutto quell’abbaiare, e grattare, e saltare per salvarlo.
E senza neanche sfasciargli le scatole perché smettesse di bere. Dick se lo teneva così, non proprio lindo, la barba rossiccia sfatta, lo sguardo annacquato e quel leggero tremore nelle mani. Non ne faceva una questione, perché quando si vuole bene non si rompono le palle.
Entrano nel bar come ogni sera, senza salutare nessuno. Non é lì per fare amicizia e poi sono quasi tutti vecchi che giocavano a briscola.
Franco solleva le sopracciglia in direzione del barista, Beppe solleva un calice a mo’ di benvenuto e prepara il pane per Dick che salta per azzannare il boccone al volo e poi gli sorride. Succede che qualche cane lo faccia mostrando denti e gengive, ma in realtà è con gli occhi che un cane sorride, sorride e ringrazia. Poi si accuccia sotto lo sgabello e comincia a dormire, mentre Franco dà l’attacco alla prima birra.
La prima è per togliere le sete, la seconda per ammorbidire la prima, ma è la terza quella magica, quella che scioglie i muscoli del viso, pulisce il cervello come una spugna, poi con la quarta non c’è più niente che non sia il bar, gli aneddoti dei vecchi ripetuti cento volte, la polvere sulla strada, l’ultimo raggio di sole che colpisce di sbieco il cartello stradale.
Ce n’è sempre una quinta, una sesta e, nelle sere buone, anche una settima. La birra ha questo di bello, ti sbronza lentamente, poco per volta, non ti dà la botta secca dei superalcolici. E poi non costa cara.
Che cosa vuole quella secondo te Dick? –chiede accarezzandogli la testa. Guarda me o te quella bionda? Vuoi vedere che ci tocca condividere anche le femmine oltre che il letto! Facciamo un patto: quelle a quattro zampe sono tue, quelle a due sono mie – gli dice mentre gli viene quasi da ridere. Dick apre un occhio come a sigillare l’accordo e poi riprende a sonnecchiare, mentre lui ordina la settima birra, questa sera ci vuole.
La bionda non molla l’osso e ora lo guarda dritto negli occhi, come se volesse risucchiargli il fiato.
Da non credere, che cazzo vuole quella biondina slavata? Si guarda alle spalle nel dubbio che sia un altro quello cui è diretto lo sguardo, ma c’è solo il muro. Beppe sorride di sbieco, Dick ronfa della grossa.
Non l’aveva notata prima, non è che di donne in questo bar ce ne vengano molte. Non era una cui di solito avrebbe concesso una seconda occhiata. Se ne sta seduta a un tavolo in fondo, sola, con davanti una tazzina di caffè. Un caffè in questo bar lui non ce l’ha mai bevuto, pensa, e sorride un’altra volta. E’ allora che lei si alza e si avvicina. Magari ha pensato che Franco sorridesse a lei e s’è illusa, ha creduto di piacergli. Ma sbronzo com’è, sorriderebbe pure a una scimmia.
E’ lei che parla per prima. Sono sempre loro, le femmine che decidono, ai maschi lasciano l’illusione di gestire il timone, ma in verità i maschi non contano mai un cazzo – pensa fra sé.
Non è che capisca bene quello che lei dice, è troppo intento a contarle con lo sguardo gli orecchini e poi tutti quei bracciali che pare una ferramenta. Lei intanto parla. Fanno così le donne, blaterano e ti rimbambiscono, e finisce che credi che hanno ragione loro, e fai quello che vogliono.
Le parole di lei gli rimbalzano nella testa come palline da tennis, le sente ma non ne capisce il significato, o forse teme che le sue domande possano strappargli i vestiti di dosso fino a lasciarlo nudo e indifeso. La sente parlare come in lontananza e aspetta in silenzio che tutte quelle parole gli si organizzino nel cervello come soldati in parata, per poter cominciare a capire. Ma tutto quel vociare gli rimbomba dentro e lo stordisce.
Eppure sente forza in quelle parole e sotto ci vede germogliare dolore. Gli parlano dritto al cuore, come allacciando il sogno alla realtà. A tratti ha l’impressione di poter affondare in quella coltre di parole calde, di potersi affidare, come se avessero il potere di fare avverare le cose.
Lui si stropiccia la faccia e appoggia una mano sotto il mento come a sostenere meglio la testa assediata dai discorsi che gli vengono incontro troppo veloci, che sembrano tramortirlo.
Dick si è svegliato e le fa le feste. Cane bastardo, che gioco fai?
Gli viene il dubbio che il cane si stia confondendo, che abbia scambiato la bionda per sua moglie, per la sua ex moglie. No bello mio, lei ci ha mollati tutti e due, sono cinque anni che ti ha scaricato sulla porta di casa mia. Lei non ci vuole più, prima te lo metti in quel cranio duro meglio è.
O forse Dick aveva nostalgia del bambino e questa bionda, così magrolina, glielo aveva fatto ritornare in mente.
Alza una mano per ordinare l’ottava birra, non che ne abbia voglia, ma così, per togliersi d’impaccio, perché non riesce proprio a seguirla questa donna che gli chiacchiera in faccia come se lo conoscesse. Lui resta muto, diffidente e non prende parte alla faccenda.
Beppe finge di non sentire la sua ordinazione, forse non vuole vederlo piombare a terra nel suo bar, non vuole dover raccogliere il suo vomito. Non che fosse mai successo, era sempre riuscito a fermarsi prima, o al massimo a vomitare per strada, ma il pavimento del bar non l’aveva inzaccherato mai. L’aveva calpestato a tentoni, quello sì, perché si sentiva balengo e perché quel pavimento, a una certa ora, diventava obliquo, pendente e se non ci stavi attento ti faceva perdere l’equilibrio.
A casa invece vomitava spesso, e ci si svegliava dentro nel suo vomito, i pantaloni umidi di piscio.
Ora erano per strada, il cielo screziato dalle nubi. Non ricordava come fosse successo, come fosse uscito dal bar, se il pavimento fosse dritto o storto quella sera, se avesse pagato le birre. Camminavano fianco a fianco, lui, Dick e la bionda che gli si era incollata addosso sa Dio perché. In fondo l’odore di una donna non lo sentiva da anni, perché no
Il sole entrava obliquo dalle persiane e le colpiva il volto. Aveva una donna nel letto e il cane, quel traditore, dormiva accoccolato vicino a lei. Restò immobile, gli occhi spalancati come ad interrogare il giorno, per capire che intenzione avesse, che cosa avesse previsto per lui. Sentiva una tremenda pressione dentro che lo faceva ritrarre nel suo guscio di lumaca.
Provò a rimettere insieme i frammenti della serata. Sicuramente aveva bevuto, beveva tutte le sere. Si ricordava i suoi occhi insistenti, lo sguardo aguzzo indagatore e quelle parole che gli erano franate addosso e che non aveva capito. E ora che cosa le avrebbe detto? Perché qualcosa doveva pur dire, una donna se le aspetta sempre le parole.
Tentò di alzarsi in silenzio con l’idea di sgattaiolare via, uscire di casa e non farsi trovare. Ma Dick era balzato in piedi e l’aveva svegliata. Lei aveva allungato le gambe, si era sgranchita come un gatto e aveva aperto gli occhi. Sembrava non riconoscere né lui né la stanza, poi le sue labbra si erano distese in un sorriso.
Beh, ora te ne puoi anche andare – aveva sibilato lui prima che potesse frenare le parole. Ora che hai avuto quello che volevi, lasciami in pace.
Lui era capace di parlare solo così, con furore, con parole fuori misura, parole nervose che sapevano solo mordere. Le cercava le altre parole, ma loro lo disertavano. Nei giorni buoni riusciva a sentirle in fondo a non si sa cosa, ma erano come schiacciate, trattenute da una mano invisibile e non c’era pinza che le stanasse. Allora si metteva in salvo negli abituali insulti e nel rumore che sollevavano superando ciò che voleva dire. Nel cuore, il silenzio di una cattedrale deserta.
Il viso di lei si era accartocciato in una smorfia e d’istinto aveva allungato una mano verso il lenzuolo per coprirsi, come volesse rimangiarsi quello che avevano fatto, come per pudore. Sul viso le si era sparso un forte rossore, la bocca tesa in una linea secca, offesa. Per un attimo sembrò che la vista le si annebbiasse, mentre nella stanza entrava un forte senso di disagio. Poi un fiume di rabbia le aveva attraversato lo sguardo, due minuscole rughe le erano comparse fra le sopracciglia e, arrotolata nel lenzuolo grigiastro, si era messa in ginocchio sul letto, gli occhi in fiamme pronti allo scatto. Niente ho avuto, se proprio lo vuoi sapere, non è successo niente.
Com’era possibile che avesse fatto cilecca, con tutta la fame che aveva?
Lei gli lesse il dubbio nel volto e gli chiarì che non aveva fatto fiasco, che proprio neanche ci aveva provato; che, dopo un rutto da far tremare i vetri, si era schiantato sul letto e era caduto nel mondo dei sogni.
Beh, se ti devo pagare dimmelo e poi vattene – buttò fuori come un veleno la sua bocca.
Lei si alzò di scatto, lasciò scivolare a terra il lenzuolo e rimase nuda, diritta davanti a lui guardandolo con disgusto. Poi cominciò a strillare, come se strappasse a morsi le parole, che lei non era una bagascia, che lavorava in una stireria, che non le servivano certo i suoi soldi sporchi, che s’era solo sentita sola, che l’aveva visto solo e aveva pensato che soli in due era meglio. Perché non è che solo più sola faceva due solo, e neanche un solo al quadrato, per lei faceva meno soli, magari fra due parentesi tonde come abbracci.
Lui sedeva afflosciato sul bordo del letto, a un palmo dal suo livore, le braccia penzoloni fra le cosce, un mozzicone di sigaretta spenta che gli pencolava da un angolo della bocca.
C’era qualcosa di disarmante in quell’uomo, si aveva l’impressione che respirasse ai bordi esterni di ciò che accadeva, come riuscisse a starne fuori.
D’improvviso, lei lo guardò dritto in volto come a trafiggerlo e lo colpì con due colpi secchi, due schiaffi di quelli ben assestati. Bel colpo per ‘sta magrolina – pensò lui mentre le afferrava i polsi con le sue mani grandi. E più lui stringeva e più lei urlava e si dibatteva, scuotendo i capelli a destra e a sinistra.
Aveva paura la ragazza, la mostrava scritta in quegli occhi febbrili che sembravano sopraffare tutta la faccia e nella bocca tirata. In fondo di lui non sapeva proprio niente, magari era un violento, magari aveva un’arma. Certo che ce l’aveva, una carabina di lusso. Ma dopo l’ultima cazzata l’aveva data in deposito a suo padre, perché non si fidava più di sé stesso, perché sentiva che il passo dalle parole ai fatti non era poi così lungo. Anche per questo beveva, per tenere a bada tutta quella rabbia, oltre che la tristezza.
Era carina senza trucco e senza la ferraglia, forse un po’ troppo magra per i suoi gusti, ma ben fatta. E tutta quella foga, quegli strilli la facevano quasi bella.
Franco la guardò, pareva una corda tesa e lui sentiva la sua presenza come una pressione sulla pelle, come qualcosa che lo toccava dentro. Quella donna camminava dal lato buono della vita.
Franco le sorrise e, delicatamente, la avvicinò a sé e la baciò con tenerezza. Lei cercò di divincolarsi, c’era troppa notte in quell’uomo, ma poi a poco a poco si sciolse, dimenticò di essere arrabbiata e annacquò la sua solitudine in quella di lui.
Dick si tenne decorosamente in disparte, un cane come si deve sa quando è ora di togliersi di torno.
