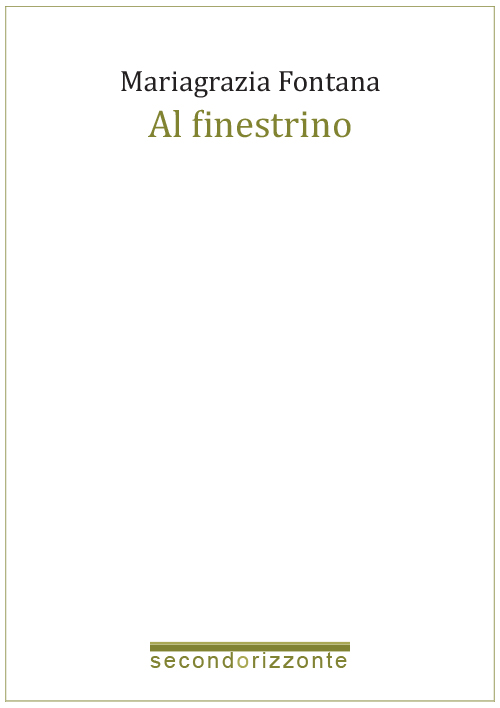
Verde, azzurro, azzurro, verde, verde, azzurro, verde, marrone, azzurro, azzurro, poi verde e ancora verde e azzurro a rincorrersi l’un l’altro. Quando prende velocità, il treno accelera i colori, e ciò che appare al finestrino è un minestrone di verde, azzurro e marrone, a volte giallo, non fusi insieme, ma in successione così rapida da confondere gli occhi. E questo inseguirsi di colori attanaglia lo sguardo, muove ritmicamente le pupille avanti e indietro in un ripetersi di vegetazione di pianura che stupisce, che incanta.
Non si può smettere di guardare, gli occhi incollati a quel riquadro rettangolare come fosse uno schermo. Concederglisi è perdere il senso del tempo, restare appiccicati a un movimento continuo solo apparente.
Ci si può illudere di essere immobili di fronte allo spettacolo del mondo di fuori che s’è messo ad accelerare di colpo al solo scopo di ammaliare.
A volte, invece, mentre il treno corre in avanti, capita che la memoria cominci ad andare a ritroso. Il passato prossimo la calamita per primo: eventi recenti, ordinaria amministrazione: impegni dimenticati, gesti incompiuti, parole frettolose o mal misurate balzano fuori da ieri e dall’altro ieri.
Sembra che a molte persone il treno faccia questo effetto: metta in moto il ricordo. Sarà quell’incedere ripetitivo, il mantra del rumore della velocità, dell’aria incisa dal movimento, quel continuo susseguirsi ossessivo di alberi e case che invita il passato a manifestarsi, a prendere posto in vettura, togliere il cappotto ed accomodarsi di fronte per lasciarsi scrutare a piacere.
Sono i ricordi buoni quelli che si addicono al viaggio, sapori dolci, tepore, un vestito che ti calza come un guanto, un incontro imprevisto che rivanga negli anni, una musica dimenticata che riprende fiato in uno scompartimento. Raramente gli eventi opachi, paralizzanti, che hanno fatto ingombro per decenni si fanno vivi in quel panorama, scelgono abitualmente contesti più intimi, raccolti.
Era entrata in silenzio, di soppiatto. O forse era lei che s’era persa nei colori, o imbambolata nei ricordi a lasciare lo sguardo sfiorare le cose di fuori, a guardare senza vedere e non l’aveva sentita arrivare. Le si era seduta proprio di fronte. Non che non ci fossero altri posti, lo scompartimento era vuoto, a parte loro. È che lei, deliberatamente, le si era piazzata dritta in faccia.
Si sforzò di ricordare se mai l’avesse conosciuta. Le succedeva spesso di scordare volti, e non solo i volti incontrati di rado, anche quelli che di consueto incrociava sul marciapiede di casa. Non è che li scordasse proprio, è che non sapeva dove metterli, il suo cervello le segnalava che li conosceva, ma non chiariva chi fossero, che relazione avessero con lei, quanto prossimi le fossero, se fosse il caso di interpellarli con il tu o con il lei. E questo la metteva in difficoltà e le iniettava dubbi, la rendeva guardinga e insicura.
Non era una vicina, neppure una paziente o una collega, ma qualcosa in quei lineamenti non le era estraneo: il modo di inclinare il capo, così come il vezzo di tenere sollevato il bavero della giacca e annodato il foulard al collo.
Si accorse di studiarla oltrepassando, inconsapevolmente, quell’area privata, intima che solo in amicizia si oltrepassa, a volte. Succede quando una persona ti si piazza di fronte in uno spazio limitato, di non sapere bene dove guardare, di cadere vittime di una sorta di imbarazzo, di timidezza, di incertezza dello sguardo che non sa dove posarsi, perché se si guarda l’altro in faccia si rischia l’invadenza, se non lo si guarda affatto l’indifferenza. Pensò di proteggersi dietro le pagine di un libro, ma c’era qualcosa in quella donna che l’attraeva.
Puntò di nuovo gli occhi al finestrino: verde, azzurro, verde, azzurro, verde, verde da stordire il cervello. Poi, con lentezza studiata, obliquò lo sguardo di quel poco sufficiente per osservarla di nuovo, nel dubbio di doverla salutare. Teneva le spalle un poco piegate in avanti, come se appoggiarsi al sedile, rilassarsi, le costasse fatica. Si intuiva qualcosa di potente dentro di lei che le toglieva le forze.
Forse la conosceva proprio, forse le ricordava qualcun’altra. O forse doveva salutarla solo per cortesia. No, in verità il bon ton imporrebbe il saluto alla nuova venuta, non a chi già se ne sta comodamente seduto sul sedile di un treno – pensò – e rise fra sé all’idea di essere ancora vittima di quei dettami materni che tanto l’avevano irritata.
Ma restò in silenzio, continuando di sottecchi a soppesare la donna che le si era seduta di fronte. Pareva accigliata, forse un pensiero, un cruccio, problemi di lavoro o un figlio che non faceva giudizio. Quel volto aveva un’aria fragile, come fosse crepato, come qualcosa che si fosse rotto e poi riaggiustato alla bell’e meglio.
L’estranea di fronte aveva i capelli ricci come i suoi, ma li lasciava grigi e non le stavano affatto male. Le risuonò in testa il rovello consueto: li tingo o non li tingo? Negli anni aveva continuato con la liturgia del colorarsi i capelli, ufficialmente per non mettere in crisi le figlie che non la volevano in disordine, cioè che non volevano vederla farsi vecchia, non illudendosi d’essere innocente sul quel versante: anche lei faticava a digerire il passo rapido del tempo e, in fondo, un po’ di colore in testa non faceva male a nessuno.
Anche la signora seduta in treno, come lei, aveva mani lunghe e dita sottili che teneva intrecciate come in preghiera. Ora si arrotolava un ricciolo con un dito mentre guardava fuori dal finestrino, forse lei pure calamitata dal correre delle cose di fuori. Ora pareva sorridere, cioè non proprio sorridere ma distendere un poco il viso, come se la contrattura delle afflizioni s’indebolisse. Doveva essere stata felice un tempo, quel volto tradiva le corde della felicità.
Continuava a frugarle il viso con lo sguardo. Forse ci stava ricamando sopra.
Provò a datarla, a darle un’età approssimativa, e sentì una femminile, perfida soddisfazione al pensiero che era sicuramente più vecchia di lei. Più vecchia, ma altrettanto triste, fu costretta ad ammettere.
E fu quel pensiero che le calò addosso come un maglio, che le allungò il mento verso terra e le piegò gli angoli della bocca da farla sembrare una barca rovesciata sulla battigia.
Quella donna faceva da specchio alla sua tristezza. Era triste, erano tristi entrambe.
Vide il proprio volto riflesso nello specchio del finestrino: quei lineamenti sfuocati e imprecisi confermavano la propria tristezza, prima solo dubitata ma ora percepita acutamente.
Era la tristezza della donna che le stava seduta di fronte che certificava la sua propria tristezza, le dava spessore, la rendeva inevitabile.
Verde, azzurro, azzurro, azzurro, verde, azzurro, verde.
Non aveva ragione quella tristezza, nessuna giustificazione plausibile, almeno per lei.
Forse era quella signora lì di fronte a lei che se l’era portata appresso. Era entrata zitta zitta, le si era seduta davanti per intristirla, per infettarla con quella malinconia amara.
Azzurro, verde, verde, verde e ancora azzurro.
Non voleva guardarla più in faccia quella donna, perché se avesse permesso al proprio sguardo di soffermarsi un attimo di più, quella malinconia si sarebbe levata improvvisamente davanti a lei, spaventosa, esigendo di essere nominata. Voleva inchiodare gli occhi a quegli alberi, al tronco, alle foglie solo intraviste, per non lasciare che la tristezza le si rovesciasse addosso. Perché certi virus, se non li contieni, si prendono tutto e allora non bastano più il verde e l’azzurro. Allora nulla può salvare.
Ma fuori cominciava a far buio, il cielo continuava a correre veloce, i contorni delle cose ora si distinguevano a malapena e cominciavano lentamente a scomparire. Impossibile appendere lo sguardo alla chioma di un albero per sfuggire a quegli occhi interminabili, a quella spenta tristezza.
Il tempo rallentava, mentre il treno non smetteva di correre e suoi pensieri storti e ansiosi sollevavano un gran fracasso dentro di lei. Le si era screpolata la bocca e aveva preso a mordersi ritmicamente il labbro inferiore per attutire il rumore dei pensieri.
L’assalì il dubbio che la meta di quel viaggio potesse essere quell’incontro, imbattersi nella profondità della malinconia che s’infila nell’anima e che vi s’annida, perdersi nell’uragano senza bussola. E il fiato le si fece corto di botto.
Pensò di rompere l’incantesimo e di parlarle, di chiederle conto di tutta quell’angoscia, di quegli occhi persi, di tutto quel vuoto che ci si intravvedeva dentro, del troppo spazio che quel corpo sembrava ospitare
Ma non sono domande da farsi a un’estranea, e spesso neppure a una cara amica.
Però, forse il treno potrebbe essere un porto franco – pensò – un luogo estraneo in cui concedersi a chi non si vedrà mai più. In certi romanzi succede che due persone sconosciute s’incontrino e si scambino segreti indicibili, mettano sul piatto dolori profondi senza ritegno.
Fu tentata di suggerirle una cura, o meglio degli strattagemmi per sfuggire alla malinconia, gli stessi che lei frequentava abitualmente e che la tenevano in vita: una corsetta, o una passeggiata in montagna, qualche parola buttata giù su un foglio bianco. Ma lo sguardo di quella donna comunicava una disperazione che andava oltre ogni possibile terapia, come se già lei avesse frequentato tutte le possibilità ed ora si trovasse al capolinea, lì dove niente può salvare, lì dove ci si può solo lasciare invadere dal nulla.
E, come in preda alla febbre, spostò lo sguardo dal riflesso del suo volto nel finestrino al viso dell’ospite inattesa e, contro la sua stessa volontà e contro ogni buon senso, cominciò a raccontare.
