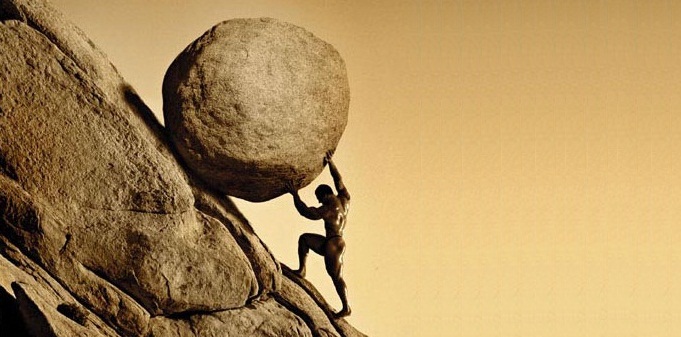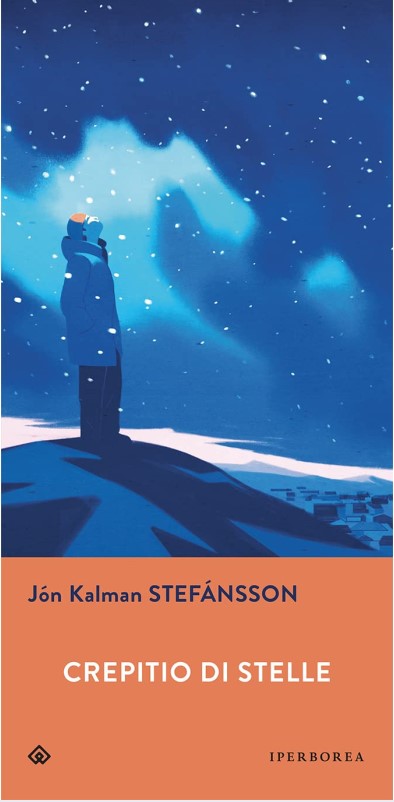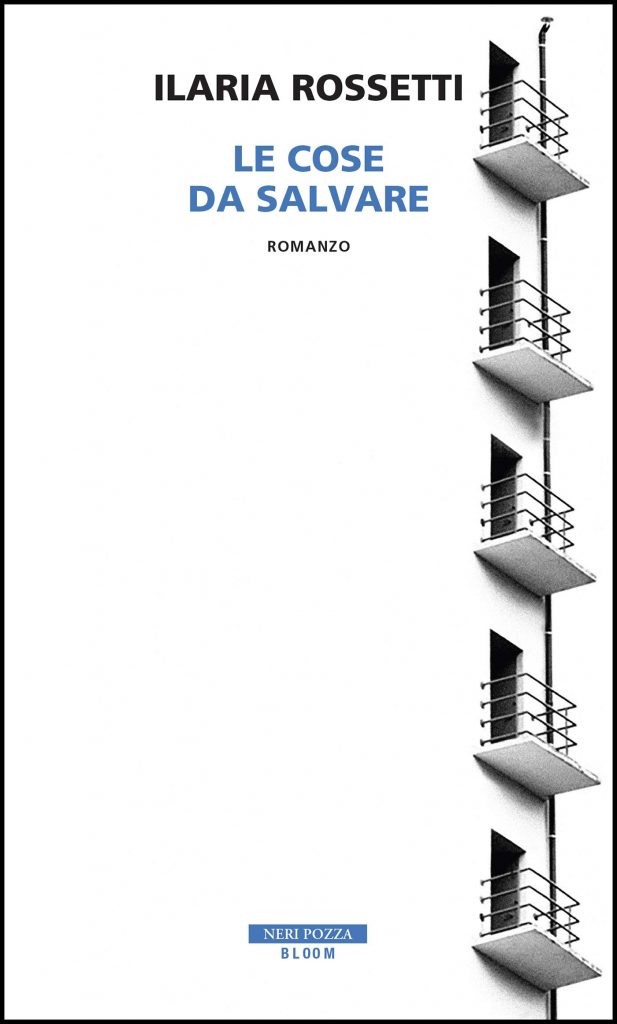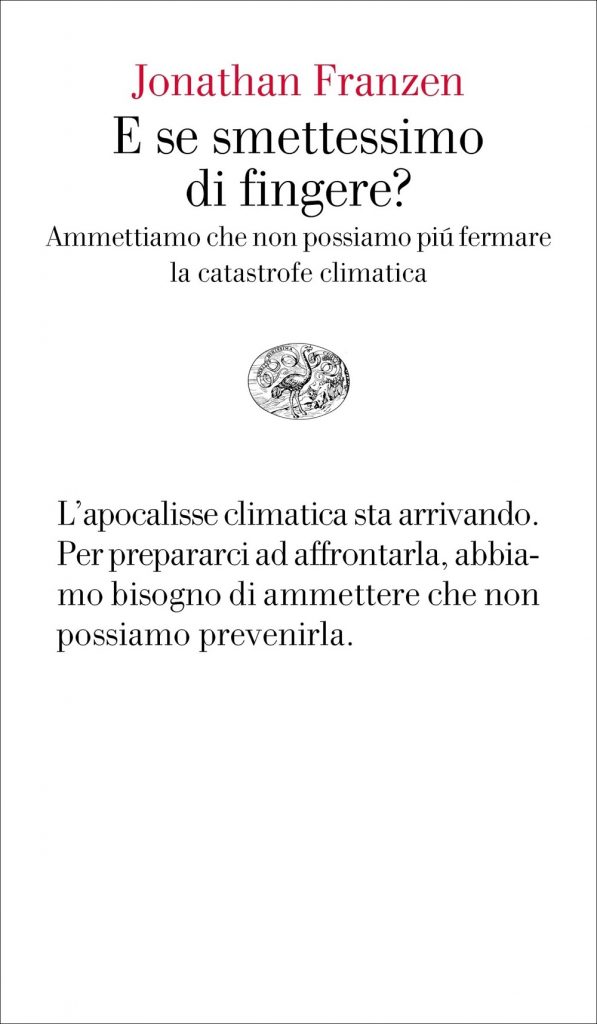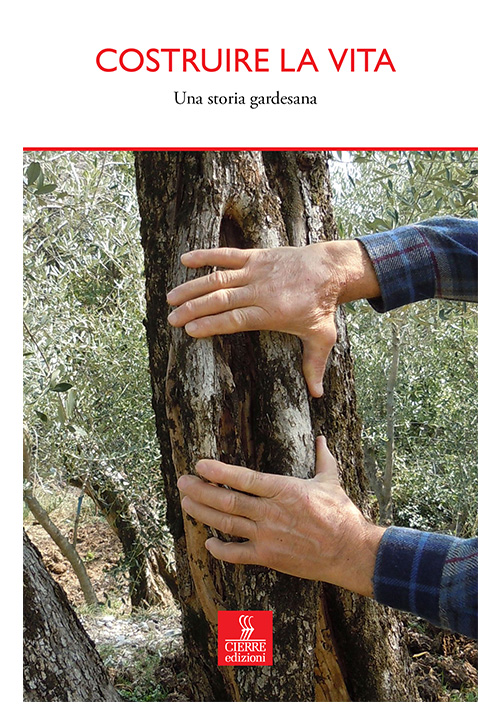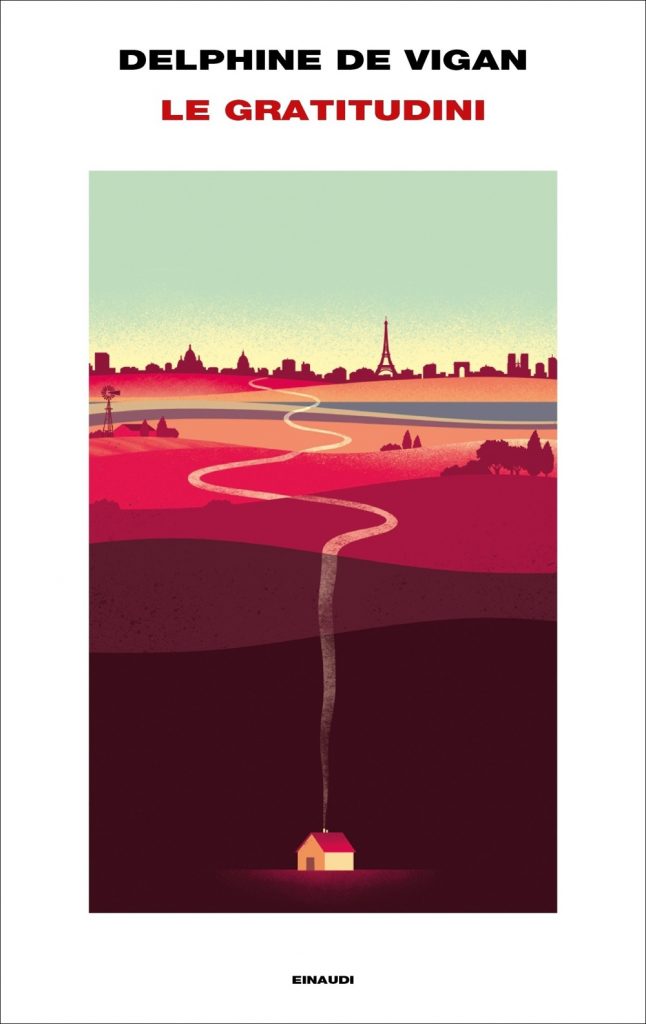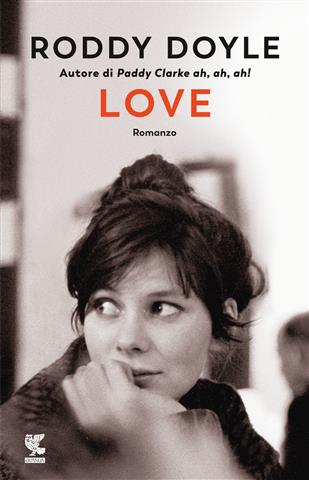Dörte Hansen, Tornare a casa, Fazi 2020 (pp. 310, euro 18,50)
L’atmosfera, il paesaggio, i personaggi fanno tornare alla mente Heimat, il fluviale film del 1984 di Edgar Reitz. Oggi la si chiamerebbe una serie, forse. Era la storia di un villaggio di campagna nella Germania profonda, nella regione della Renania-Palatinato: la vicenda del paese di Schabbach e della famiglia Simon, dagli anni Venti agli Ottanta del Novecento.
Il villaggio, nel romanzo di Hansen, si chiama Brinkebüll, uno dei tanti sparsi in una terra, la Frisia, in cui “di bellezza (non c’è) neanche l’ombra. Solo terra nuda, una terra che sembrava devastata e sfinita”. Una terra che non sembra avere altra storia che quella che Ingwer, ricercatore universitario, cerca sottoterra, nei reperti che trova. Una terra inospitale che trova un corrispettivo nella brutalità della sua gente, violenta, invidiosa, vendicativa.
La famiglia è quella dell’oste Sönke Feddersen e della moglie Ella, con la figlia Marret e il nipote Ingwer. Sönke “aveva fatto tutto il possibile affinché quel bambino senza padre, figlio di Marret Fine-del-mondo, venisse su più o meno normale”, ma quello se n’era andato, in città, a studiare, rifiutandosi di continuare a servire boccali di birra nella locanda come gli avevano fatto fare fin da bambino. Se n’era andato, via dai nonni e via dalla madre che si era guadagnata quel soprannome perché per lei “i pesci morti (…), l’estate senza cicogne e i campi senza lepri erano tutti presagi della grande catastrofe”, della fine del mondo appunto. Il paese si era abituato a queste profezie strampalate: Marret era svitata. Ce n’era uno in ogni paese di personaggi del genere.
Senonché, Igwer non può restare lontano: il tempo è passato, il nonno ultranovantenne si ostina a restare dietro il bancone della locanda ma non ce la fa più, anche perché la moglie è andata fuori di testa e se non le badi scappa di casa. Del resto, la vita universitaria è stata avara di soddisfazioni e quella privata ancora di più: “La sua vita sentimentale era entusiasmante come una serata di giochi da tavolo in casa di riposo. Forse anche meno. Status relazionale indefinito, né carne né pesce. Due uomini, una donna, un triangolo strampalato, una convivenza fuori dagli schemi” condotta in nome della rivoluzionaria convinzione che “Chi ama una persona sola, in realtà non ama nessuno, tutti e tre avevano letto Erich Fromm. Nessuno di loro aveva mai voluto sentir parlare di casa di proprietà e di matrimonio e di tutti quei discorsi sul nido”. Però lui, Ingwer, è arrivato al capolinea. Non si è mai davvero ambientato in quella convivenza, perché “Hai voglia a laurearti con i massimi voti, prendere summa cum laude alla tesi di dottorato, Ingwer si sentiva ancora come l’impostore con il curriculum gonfiato che non stava al posto suo. Ingwer Feddersen di Brinkebüll, che aveva rifiutato la sua vita ereditata. Che aveva detto no a una locanda sul Geest, ai quindici ettari di terreno, alla casa e alla fattoria. No a tutto quello che Sönke Feddersen, il vecchio, voleva dargli. No alla moglie e ai figli. Semplicemente no, grazie mille. Ma a cosa aveva detto sì? Se Brinkebüll non faceva per lui e neanche la casa condivisa a Kiel, qual era la sua strada?”
E allora torna. Perché nonostante tutto “Lui era affezionato a quella terra ruvida, logora, come si è affezionati a un peluche sdrucito dalle coccole, a cui manca un occhio e che non ha più pelo sulla pancia”, ma anche perché “Lui voleva chiudere le cose per bene, avrebbero giocato a padre-madre-figlio scambiandosi i ruoli. Questione di mesi, forse un anno, ormai a loro non doveva restare molto. Ingwer Feddersen, studentello, topo di biblioteca, per una volta avrebbe fatto qualcosa di utile, di normale. Pulire, cucinare e stare al bancone … Mantenere la posizione finché Sönke Feddersen non avesse abbandonato la nave, in sostanza si trattava di questo. Ma anche di saldare un debito”.
Una storia dura, insistita nei suoi toni aspri, ancorata a un registro malinconico, ma capace di non chiudersi nella vicenda dei suoi protagonisti: l’accorpamento delle proprietà imposto dalla riforma fondiaria e il progresso tecnologico che surclassa i metodi di coltivazione e allevamento in uso da sempre scompone il precario equilibrio del paese. Mentre quelli che possono tentano di ammodernare le loro fattorie ma, senza saper bene che cosa hanno perduto, si riducono spesso in una disperazione cupa, senza futuro, fino a giungere al suicidio in molti casi, arriva la “gente di città”: “Tutta quella gente di Berlino e di Amburgo che improvvisamente si trasferiva nei paesini, non si capiva cosa stesse cercando. Compravano fattorie dismesse, vecchie fucine e scuole di paese abbandonate, stazioni ferroviarie in disuso e mulini che non andavano più. Sembrava che volessero prendersi tutto ciò che era particolarmente vecchio e sgangherato e fatiscente. (…) C’era stato un grosso equivoco. La gente che veniva dalla grande città cercava la natura e le radici, ma nei paesi se ne stavano disfacendo”: “Era come se si stessero vendicando di quello che avevano subito in passato, estirpando tutto ciò che volesse crescere, verdeggiare, fiorire e consumare inutilmente. Via tutto ciò che era storto, logoro e misero, da contadino, da bifolco. Si liberavano dalla natura come schiavi dai loro padroni (…). La gente che veniva dalle grandi città (…) non capiva che i propri vicini avevano un conto aperto con quel territorio. Loro abitavano lì da poco, su quella terra, non sapevano cosa volesse dire vivere di quella terra”.

È qui che il romanzo diventa potente, capace di render conto – senza mai rischiare di abbandonare il terreno della narrativa gravandolo di digressioni saggistiche – dei guasti irreversibili che una modernizzazione guidata solo da criteri economici e accelerata dalle innovazioni tecniche inevitabilmente porta con sé disgregando comunità già minate e destituendo di senso le vite dei singoli.
“Il tempo dei contadini giungeva al termine. Avevano spento il fuoco, tolto le tende e abbandonato gli ultimi residenti. Homo ruralis. Quasi estinto. Le ere cominciano e finiscono, niente di trascendentale. Per uno del mestiere – come il professor Ingwer Feddersen – era sorprendente averci messo così tanto a capirlo”.
Sua madre Marret-fine-del-mondo, a suo modo, aveva visto quel che stava accadendo. Ma “quel posto se ne infischiava totalmente dell’inezia umana”.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.