“Se in una famiglia nasce uno scrittore, quella famiglia è perduta.”
(Evelyn Waugh)
“Se in una famiglia nasce uno scrittore, quella famiglia è perduta.”
(Evelyn Waugh)
“Dov’è la gioia? Nelle rane, non nell’idea degli altri che leggono la mia poesia sulle rane.”
(Silvia Plath)

Roberto Alajmo, L’estate del ’78, Sellerio 2018 (pp. 173, euro 15)
In tutte le vite c’è un prima e un dopo. Un giorno, una stagione, un anno che hanno fatto da spartiacque. Ma devono essere passati perché la loro crucialità risulti evidente.
L’estate attorno alla quale gravita il racconto di Alajmo è quella in cui ha visto per l’ultima volta la madre, e che fosse l’ultima non lo sapeva. Sarebbe stata diversa, si sarebbe comportato in un altro modo… Ma non affoga nel rimpianto o, peggio, nel rimorso, Roberto: racconta, invece, il prima e il dopo di quell’estate. E non ci sono né colpe da espiare né risarcimenti possibili; né buoni né cattivi, e il disamore arriva com’era arrivato l’amore, “la felicità non si cerca né si trova: la si incrocia”. Tutti hanno fatto quel che han saputo fare. Nella sua come in tutte le famiglie. Avrebbero potuto fare diversamente? Certo, se non fossero stati dentro il momento che stavano vivendo, se avessero potuto vedere il loro presente come fosse già passato e fosse stato loro possibile riconoscere in un gesto quotidiano l’evento che segnava irreversibilmente il cambiamento.
Era e continua ad essere così. Ora che è adulto e ha un figlio, Roberto lo confessa: non si è reso conto del “lungo smottamento impercettibile durate il quale lui cresceva e io invecchiavo”, una trasformazione silenziosa – direbbe François Jullien – di cui l’evento non è che lo sbocco. C’è stata l’ultima sera in cui ha accompagnato in camera sua il figlio, ma non ha saputo accorgersi che quel momento portava “ognuno su un binario diverso”.

E’ una riflessione dolente sulla vita, sul tempo che la attraversa e travolge quadri famigliari che erano sembrati destinati a durare in eterno, ma il tono non è quello del lamento, tantomeno dell’angoscia: non pacificato ma neanche assillato dalla caducità delle persone e dei loro affetti, il racconto richiama la schietta, empatica curiosità per la vita dei genitori che avevamo trovato nel Ford di Tra loro, ma ancor più l’atmosfera di Lessico famigliare, in cui lo sguardo bonariamente ironico che sottolinea le idiosincrasie dei personaggi ne restituisce l’ irripetibile unicità.Che cosa avrebbe “pensato – lei , la madre, finita tragicamente nel gorgo della depressione e della dipendenza dai farmaci – della mia vita, delle scelte che ho fatto, delle donne che ho amato, dei libri che ho scritto”, si chiede l’autore nelle ultime pagine: che cosa avrebbe pensato “di questo libro. Le sarebbe sembrato troppo duro?”
Domande senza risposta: scrivere dei morti serve a noi, non a loro.
“Il tempo dei posteri prosegue, scavalcando ogni dolore”.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora
“La scrittura è fatta per crescere. Come una foresta, o come una casa che s’innalzi dalle sue fondamenta. Non si scrive se non aggiungendo. Una lettera dopo l’altra, una frase che si salda alla successiva.”
(Giulio Busi)
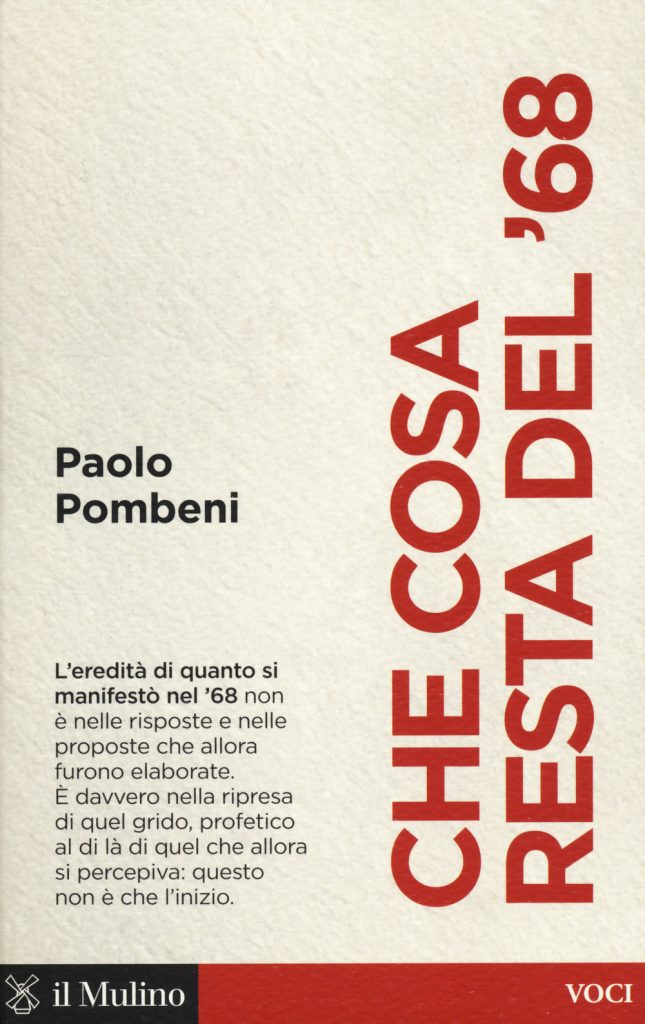
Paolo Pombeni, Che cosa resta del ’68, Il Mulino 2018 (pp. 128, euro 12)
Paolo Pombeni, storico, politologo, tenta un bilancio del’68: vent’anni in quell’anno; settanta oggi che ne scrive.
“Per la mia generazione – riconosce – quell’anno è stato una specie di battesimo collettivo, il rito di passaggio da un mondo a un altro.” Fra i tanti libri usciti per l’anniversario, che spesso raccolgono i “ricordi proposti dai reduci, a volte celebrativi, altre volte dominati da un desiderio di autoflagellazione”, questo vuole offrire “una modesta riflessione che viene da chi partecipò sia pure in quinta fila, a quegli eventi, ma nei cinquant’anni seguenti per varie vicende ha dovuto misurarsi con l’eredità di quella fase.”
Prima di tutto, che cosa è stato il ’68? “Molte cose, ma senz’altro in gran parte un’operazione intellettuale”, compiuta, e vissuta, da studenti universitari, cresciuti in un paese che si era rapidamente modernizzato ma nondimeno propensi a sentirsi “defraudati della speranza di entrare con coraggio in quella che appariva la modernità”. Destinati comunque a subire – spesso cedendovi – le lusinghe di “alleati subdoli”, dall’industria culturale al mercato, così come il fascino di “cattivi maestri”. Risultato: l’abbandono del prosaico, “faticoso e impegnativo riformismo di cui aveva bisogno l’Italia”, e il prevalere della critica dell’esistente, della pars destruens, senza che venissero riservati pari entusiasmo e intelligenza alla pars costruens.

Non ci sono motivi per essere trionfalisti ma neanche per sentirsi sconsolati nel ripensare quel “momento storico”, perché tale è stato il ’68, non si può non ammetterlo: “Ci fu allora un impegno alla riflessione che, pur con tante ingenuità, non fu più rinnovato”.
Detto ciò, l’autore passa in rassegna i campi su cui questa riflessione si concentrò, le argomentazioni che elaborò, le speranze che concepì, ma analizza, anche, l’eredità non di rado “ambigua” che da quel fermento ci è giunta: la critico al sistema educativo, pur non misconoscendo il valore del patrimonio culturale in esso sedimentato, si è di fatto risolta nella “trappola del soggettivismo” in cui oggi ci dibattiamo, fra genitori avvocati dei loro fogli e insegnanti di nuovo autoritari, gli uni e gli altri – ma si tratta di atteggiamenti che vanno ben oltre la scuola – arroccati sulle loro posizioni e ostili ad ogni coinvolgimento dialettico.
Dall’operaismo, altro tratto decisivo della cultura del ’68, e dall’incontro operai-studenti – più episodico e transitorio di quel che apparve in quegli anni – si è giunti alla “chiusura dei sindacati verso le esigenze delle nuove generazioni”; la critica radicale al capitalismo e al consumismo non ha impedito che molti dei protagonisti delle lotte di quei giorni si siano acclimatati nel mondo accademico, economico, politico-parlamentare, così come il rinnovamento del mondo cattolico ha lasciato il campo a una religione intesa come “scelta personale”.
Come da tempo e da più parti riconosciuto, sono il femminismo, la ridefinizione del ruolo della donna con le sue conseguenze su quella del ruolo maschile, ad aver registrato un “successo duraturo”, mentre la contrapposizione al mondo della politica dei partiti non ha costituito un baluardo, a partire dai primi anni ’80, contro il venir meno di una “cultura riformista e riformatrice”, sfociando in alcuni casi in una critica radicale priva di orizzonti che non fossero millenaristici. E involuzione non dissimile ha subito il “comunitarismo”, la logica accogliente dei “gruppi spontanei”, altro aspetto che ha marcato il ’68, molto presto inquinati dallo spirito settario.
Eppure: il comunitarismo stesso, come il femminismo di cui si diceva, e l’idea di un’Italia “paese sbagliato” perché privo di una rivoluzione che abbia segnato una cesura nella sua storia, ma anche la distanza critica dal consumismo o l’attenzione alla dimensione internazionale sono tutti aspetti che hanno lasciato “ un’impronta profonda nella psicologia sociale”, nell’immaginario collettivo degli italiani “per lunghi decenni”. Decenni che si sono conclusi? è lecito chiedersi, perché a questo servono gli anniversari: a cercar di capire a che punto si è riflettendo dove si era, o si credeva di essere. Nel caso concreto, a riconoscere che quella del ’68 è “un’eredità in cui sopravvivono più gli elementi utopici nell’immaginare il nostro futuro, che le componenti razionali utili a circoscrivere i problemi per provare a risolverli”. Si può essere d’accordo, a patto di ammettere anche che di “elementi utopici” abbiamo bisogno. Oggi, in Italia, più che mai.
E’ alle giovani generazioni – conclude Pombeni – che spetta il compito di raccoglierli, e calarli nel mondo globalizzato dei nostri giorni. Così dando conferma – chissà… – che quello del ’68 “non era che l’inizio”.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora

Andrea Moro, Il segreto di Pietramala, La nave di Teseo 2018 (pp. 380, euro 18)
Vivo e vegeto nonostante tutto, il romanzo non ha smesso di assumere forme diverse.
Uno storico della letteratura, Stefano Ercolino, ci ha spiegato che esiste ad esempio, nel panorama intricato della letteratura postmoderna, il romanzo massimalista (Bompiani 2015), tipo Infinite Jest di Wallace, Underworld di DeLillo, Le correzioni di Franzen: tutti poderosi (e ponderosi) tentativi di disciplinare la complessità del mondo attraverso la narrazione.
Ma prima, tra fine ’800 e prima metà del ’900 c’è stato il romanzo saggio (Bompiani 2017), quello del Doktor Faustus di Thomas Mann e dell’ Uomo senza qualità di Robert Musil, che cercava di far fronte alla crisi che da tempo minava l’apparato simbolico della modernità e si era fatta cataclisma con le due guerre mondiali, e dunque un romanzo in cui la narrazione si contaminava con l’argomentazione, l’intreccio con il ragionamento, le vicende con le nozioni.

Ecco, se lo si dovesse collocare, quello di Moro lo potremmo considerare un “romanzo saggio”, racconto di una vicenda condita di avventura e di suspense ma infarcita di considerazioni scientifiche che solo un linguista, qual è l’autore, avrebbe potuto seminare di pagina in pagina. Sino a farci arrivare, alla fine, alla incontestabile verità che, se mai avessimo pensato il contrario, “le lingue umane sono oggetti naturali e non convenzioni culturali di natura arbitraria, progettabili a tavolino” come vorrebbe l’avversario del protagonista, Elia Rameau (un linguista, ovviamente). Ma per arrivarci occorre – a Elia, e al lettore – aggirarsi prima fra le case abbandonate del paese fantasma di Pietramala, in Corsica, e le vie trafficate di New York, inseguendo e poi cercando di sfuggire al professor Shannon, velleitario e maniacale ideatore di lingue e leader di un’organizzazione misteriosa – il Giardino degli Equivalenti – che ricorda un po’ la Spectre.
Trama e teoria dunque. Dalle parti del Pendolo di Foucault di Eco, per intenderci. Con la linguistica al posto delle teorie del complotto.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora
“Scrivere significa sostenere l’incertezza per anni, a volte lavoro e piango pensando che non arriverò mai alla fine. Eppure bisogna fidarsi dell’incertezza…”.
(Nicole Krauss)
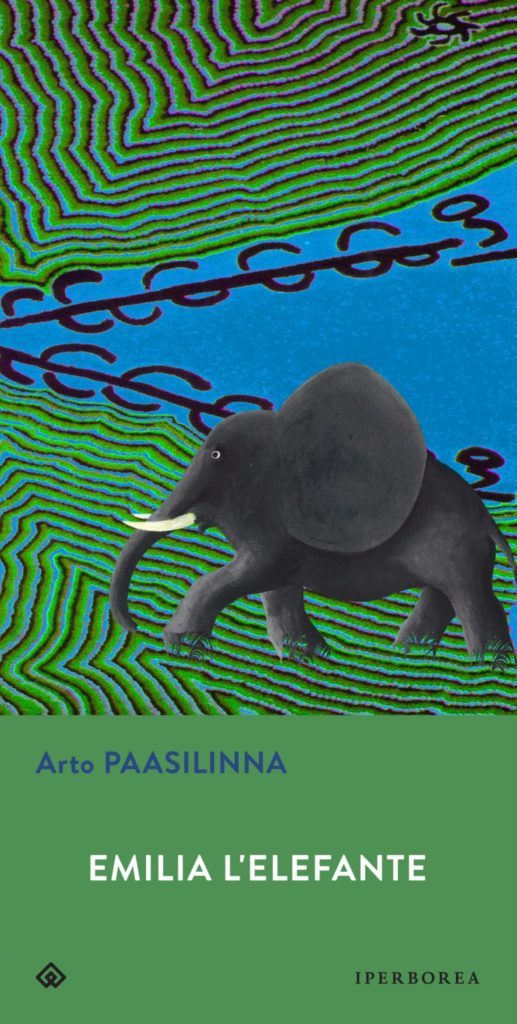
Arto Paasilinna, Emilia l’elefante, Iperborea 2018 (pp. 252, euro 17)
“L’elefante è un miracolo di intelligenza e un mostro di materia”, ma non solo. A sorprendere, in questo essere contraddittorio, è anche la sensibilità:
“Il suo odorato è squisito e ama con passione i profumi di tutti i tipi e soprattutto i fiori fragranti; li raccoglie, li coglie uno ad uno, ne fa mazzetti e dopo averne assaporato il profumo li porta alla bocca e sembra godere del loro gusto”.
La simpatia che Buffon mostra nei confronti di questo bestione, a prima vista temibile quando non sovranamente indifferente a ciò che gli sta intorno, si ritrova nel romanzo di Paasilinna: Emilia non perde occasione di manifestare la sua “animale amicizia” cingendo con la proboscide e sollevando a un paio di metri da terra chi le si è dimostrato amico, e il suo sguardo, con quelle morbide e lunghe ciglia, ha un’“aria dolce e commovente”.

Ma quello di Paasilinna richiama anche altri pachidermi costretti a viaggi interminabili, in terre a loro estranee: sono spaesati i protagonisti dei testi raccolti in i Morte di un elefante a Venezia (Canova 2004), dell’Elefante di Napoleone di Paolo Mazzarello (Bompiani 2017), e soprattutto quello che incontriamo nel Viaggio dell’elefante di José Saramago (Einaudi 2010). Il peregrinare di Emilia non si deve tuttavia al fatto di essere stata spedita in dono da un sovrano all’altro, come avveniva in passato: lei è un’elefantina da circo che si esibisce lungo la Transiberiana prima di finire in Finlandia, esule ma sempre accudita con amore da Lucia, sollecita e affettuosa con il suo animale anche più del cornac dell’elefante di Saramago. Non solo custode del suo benessere ma anche mediatrice tra il suo buonsenso animale e la follia, l’ipocrisia, l’avidità degli uomini. Mai condannati però, dall’autore, che come sa restituirci la saggezza intelligente dell’elefante così guarda agli umani con l’ironia bonaria e lo humor che gli sono propri, segno di un piacere di raccontare – senza fretta, indugiando su particolari e cedendo a digressioni – che comunica quel senso di leggerezza, scherzosa ma non del tutto, che con i suoi romanzi ci regala da più di vent’anni (risale al 1994 la pubblicazione in Italia dell’Anno della lepre, con Iperborea).
Attenzione però: bonario sì, ma anche pungente, e apertamente critico, quando se la prende con il formalismo protocollare della UE che non sa tener conto della specificità locale dei problemi, o con il gruppo di verdi che col “Movimento di difesa dell’elefante” si rivelano più interessati alla loro visibilità mediatica che alla difesa della salute di Emilia, senza riuscire tuttavia a impedirle di raggiungere alla fine un parco nazionale del Sud Africa dove “gli elefanti e gli altri animali selvatici possono muoversi liberi, mentre i turisti sono sprangati nei loro campi base da cui possono uscire a vedere la fauna solo in macchina, accompagnati da guide professioniste”.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora
“Il romanzo non è significativo perché ci presenta il destino di altri, ma perché nella fiamma che lo divora ci dà il calore che non possiamo mai ottenere dal nostro.”
(Walter Benjamin)
“Se mi sono messo a scrivere è perché la vita è breve. Prima di schiattare vorrei farlo, un grande libro. Almeno uno.
Uno dove ci sia dentro tutto quello che ho capito.
E anche quello che non ho capito.”
(Tiziano Scarpa)

Durian Sukegawa, Le ricette della signora Tokue, Einaudi 2018 (pp. 184, euro 18)
Per fare i dorayaki, dolci tradizionali giapponesi a base di pandispagna e marmellata di fagioli, occorre sentimento: a Sentarō, il pasticcere, sembra una stravaganza della vecchia Tokue – aiutante che da subito si rivela maestra – quello stare a guardare i fagioli da vicino; a osservarli uno ad uno, come se volesse sentirne la voce, o sperasse comunque di sentirla.
Ma capirà: il libro è tutto qui. Nel percorso di un uomo che si lasciava vivere, oppresso dai dolori del passato e dai debiti nel presente, e che poco a poco comprende che la via per imparare a vivere sta lì: nel cercar di “sentire la voce di ciò che non ha voce”, nell’imparare ad “essere all’ascolto”. Non è una cosa facile: Tokue è sessant’anni che si esercita, ma si può cominciare a qualsiasi età, anche se si è adolescenti come la studentessa golosa di dorayaki. Perché la differenza di età non impedisce che l’esperienza, fatta di una ricerca ininterrotta, si possa trasmettere: il tempo della vita non è poi tanto importante rispetto a quello delle stagioni che donano aspetti differenti al ciliegio che sta davanti al negozio di Sentarō e fiorisce, mette foglie, le perde, resta spoglio, rigermoglia, torna a rifiorire.

In questo, come in molta letteratura giapponese, la vicenda è tramite di un messaggio che, proprio perché originato dai fatti e aderente alla vita dei personaggi, non suona teorico, ed è quindi tanto più in grado di raggiungerci: nulla di ciò che facciamo – che cuciniamo dolci o scriviamo libri – si esaurisce nella sua strumentalità, nell’efficacia del procedimento, nella bontà del risultato, ma può esprimere – se si è all’ascolto – un irripetibile modo di rapportarsi a se stessi, e al mondo, e dunque essere la traccia che ognuno lascia del proprio passaggio sulla terra. Perché “siamo nati per guardare e ascoltare il mondo. E il mondo non desidera altro. Perciò – conclude Tokue, non con l’aria di chi sostiene una tesi ma di chi fa una semplice constatazione – il mio essere venuta al mondo ha un senso”.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora
“Ogni autore ha un insieme limitato di temi archetipici, a volte uno soltanto.
Più che sceglierli, questi temi li ereditiamo dalla configurazione della nostra vita, e anche se cerchiamo di espellerli dal libro a cui stiamo lavorando spesso riescono a trovare un modo per intrufolarsi di nuovo.”
(David Mitchell)
“Scrivo perché è una delle poche cose che mi sembrano reali. E’ l’unico modo, a parte la morte, per fermare il tempo.”
(Phillip Lewis)

Marco Balzano, Resto qui, Einaudi 2018 (pp. 192, euro 18)
La “marcia su Bolzano” nel ’22, con incendi di edifici pubblici, pestaggi, e i carabinieri che restano a guardare. La città ne esce cambiata: “ancora oggi camminare per Bolzano mi scombussola.
Tutto mi sembra ostile. I segni del ventennio sono tanti”. E dalla città alle valli, ai paesi: “Mussolini ha fatto ribattezzare strade, ruscelli, montagne”, “hanno italianizzato i nostri nomi, sostituito le insegne dei negozi. Ci hanno proibito di indossare i nostri vestiti”. E l’italiano, “una lingua esotica” per chi viveva in “Alto Adige”, è l’unica lingua ammessa: la protagonista, se vuole insegnare, deve farlo nelle “catacombe”, fare la “maestra clandestina”, sotto la minaccia dell’olio di ricino o, peggio, del confino.
Qualcosa sapevamo (i cartelli bilingui, con quelle italianizzazioni spesso fantasiose, a volte grottesche…), ma non altrettanto si sa di quel che il fascismo ha seminato fra i monti del Sud Tirolo: “Sperare in Adolf Hitler era la ribellione più vera”. Essere antifascisti e filonazisti. E quando, nell’estate del ’39, “i tedeschi di Hitler vennero ad annunciare che, se lo volevamo, potevamo entrare nel Reich e lasciare l’Italia”, dividersi: fra “optanti” e “restanti”, fra chi accetta l’opzione e se ne va in Germania con la speranza di farsi una nuova vita e chi decide di restare perché il posto in cui è nato ha un significato, le strade e le montagne gli appartengono come lui appartiene ad esse.
Ma oltre al fascismo e all’opzione offerta dai nazisti, oltre alla guerra e alla vita alla macchia, alla fuga continua e alle morti di chi ci si era trovati vicino, oltre a tutto questo c’è il progetto della diga, i lavori che si era sperato la guerra fermasse e che riprenderanno invece, costringendo di nuovo alla scelta. Erich, protagonista del romanzo, insieme alla moglie Trina, la voce narrante, non ha dubbi: lui resta. “Perché qui ci sono nato, ci sei nata tu, ci sono nati i miei figli. Se ce ne andremo avranno vinto loro.”

“Le industrie – scrive Trina: per nessuno, per se stessa – stavano trattando Curon e la valle come fossero un posto senza storia. Invece noi avevamo un’agricoltura e allevamenti e prima che arrivasse quell’esercito di cafoni e quella marmaglia di ingegneri regnava l’armonia tra i masi e il bosco, tra i prati e i sentieri. Era una terra ricca e piena di pace, la nostra. Sacrificare tutto questo per una diga era semplicemente selvaggio. Una diga si può costruire altrove, un paesaggio una volta devastato non può rinascere più. Non si può rimediare né replicare, un paesaggio”.
Ma paesaggio è anche quello della Val Venosta di oggi per i turisti che si fermano e si fotografano davanti a quel campanile che spunta dalle acque del lago artificiale, che nel 1950 ha sommerso il paese, “come se sotto l’acqua non ci fossero le radici dei vecchi larici, le fondamenta delle nostre case, la piazza dove ci radunavamo. Come se la storia non fosse esistita.”
La storia è esistita invece, ma se si è fatta romanzo e proprio per questo è riuscita a raggiungerci è perché l’autore ha saputo intravederci le vite, irripetibili come sono le vite, di donne e uomini in carne ed ossa: “Se la storia di quella terra e della diga non mi fossero parse capaci di ospitare una storia più intima epersonale – scrive infatti in una “nota” conclusiva – attraverso cui filtrare la storia con la s maiuscola, se non mi fossero immediatamente sembrate di valore generale per parlare di incuria, di confini, di violenza del potere, dell’importanza e dell’impotenza della parola, non avrei, nonostante il fascino che questa realtà esercita su di me, trovato interesse sufficiente per studiare quelle vicende e scrivere un romanzo».
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora
“Montaigne ci insegna che il solo modo per imporre se stessi al lettore – senza correre il rischio di imbarazzarlo o disgustarlo – è presentarsi in abiti casual, possibilmente sgualciti.”
(Alessandro Piperno)

Auður Ava Ólafsdóttir, Hotel silence, Einaudi 2018 (pp. 188, euro 18,50)
“Devo spararmi in sala o impiccarmi in camera da letto, il gancio del lampadario della cucina oppure quello del bagno? Cosa sarebbe più appropriato, il pigiama, un vestito elegante o i vestiti di tutti i giorni, con le scarpe o solo coi calzini?”
Il tono è questo: dire che questo romanzo tratta, dall’inizio alla fine, di un proposito di suicidio potrebbe fuorviare se non ci fossero questi incisi, queste perplessità irrisolvibili che possono a volte richiamare i tratti dello Zeno Cosini di Svevo.
Certo, ragioni ne ha: la madre non si sa quando c’è con la testa; la moglie se n’è andata; la figlia non è davvero figlia sua. Ed è anche lucidamente realista : “Mi rimpiangerà il mondo? No. Il mondo sarà più povero, senza di me? No. Il mondo se la caverà senza di me? Sì.”
E dunque, perché continuare a vivere, a sopportare una solitudine inattaccabile? Persino il vicino, che pure cerca la sua compagnia “non dialoga, monologa”, e non c’è da far conto – come i padroni di cani, forse, o gli appassionati di whalewatching – neanche su una possibile un’empatia tra uomo e animale, tra lui e una foca ad esempio: “I loro sguardi si sono incrociati, uomo e animale, nient’altro da dire, nessun significato più profondo”. Quanto a conforti che possano venire dall’Alto, non c’è da farci conto: “non credo più in Dio e ho paura che Lui non creda più in me” – (potrebbe essere una battuta di Woody Allen).
No: l’unica cosa di cui si può esser certi è la morte, la propria morte. Lo sapeva già quando trent’anni prima, quando nei suoi diari di ventenne scriveva che “La gente muore. Gli altri. Si muore. Con «si» intendo me stesso – (altro che Woody Allen: qui siamo a Heidegger) – . Io muoio. Se avrò dei figli anche loro moriranno. Quando succederà, io non sarò con i miei figli…”.

Senonché: se proprio lo si è deciso, meglio morire lontano, non lasciare a nessuno – tanto meno alla figlia – il compito di occuparsi di quel che lasci… E dunque via: biglietto di sola andata. Per dove? “Navigo in rete alla ricerca della meta più adatta e focalizzo l’attenzione a latitudini di guerra.” E difatti è in un luogo devastato da eccidi e bombardamenti che va – per suicidarsi, naturalmente – nella cornice di un paesaggio speculare a quello interiore: “la devastazione è ovunque”.
Senonché: all’Hotel silence scopre che qualcuno, di cui non sospettava l’esistenza, qualcuno che per lui era nessuno, ha bisogno di lui.
E’ là che la voce della madre lo raggiunge, in sogno. Lui non se ne rende conto, al momento, ma quella che ha ricevuto è una specie di rivelazione: “Anziché smettere di esistere, non puoi smettere di essere tu, e diventare un altro?”
Grandi domande sulle cose essenziali della vita, e poche risposte, e se non quelle racchiuse nelle vicende che la vita stessa propone e il racconto sembra limitarsi a riferire. Si direbbe, questo, l’orizzonte in cui si muovono i personaggi di molti scrittori islandesi di oggi.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora

Alessandro Dal Lago, Populismo digitale. La crisi, la rete e la nuova destra, Cortina 2018 (pp. 169, euro 14)
“Populismo perché i leader pretendono di agire in base al mandato diretto del popolo; digitale perché la nuova relazione tra leader e popolo avviene soprattutto nell’acquario del web.”
Tutto qui. E non è poco: il popolo “nella realtà materiale non esiste – lo dimostra la rapida ricostruzione che l’autore fa dei significati via via attribuiti al termine – se non nelle convenzioni o nelle finzioni della democrazia rappresentativa”. Ma ecco la novità: quello stesso popolo “si è ora ricostituito in rete”. Le promesse di democrazia diretta che la rete – o meglio, i suoi più o meno consapevoli e interessati cantori – ha diffuso, hanno creato il terreno entro cui è rigermogliata l’idea, o la pretesa, di “un popolo che sopprima le differenze di ceto, religione, educazione”. Idea suggestiva ma equivoca: “oggi, dopo l’esaurimento dei grandi movimenti sociali del XX secolo”, ristrette élite sono tornate ad attribuirsi “il compito di guidare il popolo verso la realizzazione della sua natura più profonda” (quella appunto in cui non esisterebbero né differenze di classe né appartenenze religiose diverse e dislivelli di natura culturale). Senonché, data la crisi delle istituzioni democratiche, “ora si suppone che il popolo parli e decida direttamente per sé”. E qui sta il punto: la rete e i social oscurano il dato reale, ossia che l’essenza del populismo continua ad essere rappresentata dal fatto che qualcuno parla per conto di “un popolo che non c’è”.
Analisi convincenti del dilagare di questo populismo condotto con altri mezzi dagli Stati Uniti alla Russia si accompagnano a quelle rivolte a casa nostra: Berlusconi, certo, ma il M5S soprattutto. Non tanto perché sia il nemico principale (qui non si gioca, come prima del 4 marzo, al gioco del peggio Berlusconi o peggio Grillo, anzi: Di Maio), ma perché rappresenta “un esperimento politico che non ha precedenti al mondo”, configurandosi come “un sistema multi-aziendale capace di integrare attivismo di base, azione parlamentare e uso sapiente di Internet”; governato, nella sostanza, da un blog controllato da una società di consulenza aziendale.

Demonizzazione della rete, dunque, vista come origine della degenerazione politica attuale? No. L’incapacità della Sinistra – finiti i tempi in cui si poteva ancora parlare di “ritardo”… – di comprendere il carattere epocale dei cambiamenti economici e sociali degli ultimi decenni è un fatto, così come è lì da vedere la maggiore abilità della Destra di sfruttare le potenzialità della rete. Ci sono responsabilità più definite tuttavia, nell’affermazione del M5S: “L’elettorato tradizionalmente progressista e radicale si è sentito senz’altro abbandonato a se stesso sia dal decisionismo presuntuoso di Renzi – cui del resto pulsioni populiste sono tutt’altro che estranee – sia dalla scomparsa di qualsiasi opzione di sinistra”. Ma c’è stato dell’altro: l’iniziale “illusione di tanti intellettuali e artisti – ma anche politici: D’Alema e Bersani, ad esempio – e cioè delle élite per lo più di sinistra, delle virtù taumaturgiche di Grillo”.
E comunque: non è un pamphlet, un esercizio pur legittimo di indignazione, il libro di Dal Lago. Piuttosto l’offerta di spunti per una considerazione pacata del cambiamento profondo in atto, che non si misura solo nella politica e nell’informazione, ma nella rivoluzione del vissuto dello spazio e del tempo che il digitale determina, e nella connessa perdita di terreno del pubblico rispetto al privato. Un privato esibito continuamente ma non per questo paragonabile al confronto, allo scambio che solo il contatto faccia a faccia permette.
Una considerazione pacata perché “non ha senso esecrare questi sviluppi. Ma è necessario comprenderli”. Consolatorio forse, ma inutile – si potrebbe concludere – cimentarsi in critiche sempre più dettagliate e risentite degli errori e delle derive culturali della Sinistra o della malafede cinica della Destra: occorre capire che cosa è successo e soprattutto che cosa succederà, consci tuttavia del fatto che “la prevalenza della politica digitale su quella reale – una prevalenza che fa rima con quella osservabile nell’economia… – non permette di fare previsioni a lungo termine.” Neanche a breve: leggere questo libro prima del voto del 4 marzo poteva essere utile. Ancor più utile è tornarci a riflettere adesso, guadagnando la pratica di un’analisi attenta, sempre aggiornata. Perché “la crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere: in questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati”: Gramsci – non a caso citato in esergo – l’aveva capito.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora
“La gloria o il merito di certi uomini è scrivere bene; di altri, non scrivere affatto.”
(Jean da le Bruyère)

Shi Yang Shi, Cuore di seta. La mia storia italiana made in China, Mondadori 2017 (pp. 166, euro 17)
Made in China, nel titolo in copertina, è scritto come il timbro impresso sui prodotti commerciali: la storia di cui si racconta si svolge in Italia, ma il suo marchio d’origine è là, in Cina.
Perché è quello che è avvenuto là a spiegare le ragioni dell’emigrazione: l’essersi resi conto, al tempo della Rivoluzione culturale, che “la libertà non era qualcosa di cui si potesse disporre in Cina. Ma soprattutto che l’essere umano aveva un lato oscuro che può concretizzarsi in crudeltà” inimmaginabili. E dunque decidere che il destino del proprio figlio è in gioco, anche se ha appena sette anni, e l’unica via, per “garantire alla propria discendenza un’istruzione e una vita migliori” è separarsene, e mandarlo insieme alla madre nel “Bel Paese, l’Yìdàlì”.
Di qui comincia la “storia italiana” di Shi, il cui primo impatto è con “stranieri” che gli “occhi grandi e i nasi grossi” rendono del tutto simili, indistinguibili: un po’ come i cinesi per noi…

Il fatto è che, una volta partito, non potrai decidere che era meglio prima, e tornare a casa, perché “quando lasci il tuo villaggio per emigrare, ci ritorni solo con l’abito di seta. In altre parole: se non ce l’hai fatta, ti conviene restare dove te ne sei andato. Finisci incastrato in un meccanismo”, fatto di lavori dequalificati, pesanti, sottopagati, di sistemazioni al limite della vivibilità, di rapporti difficili anche con i connazionali. Quelli che Shi e la madre incontrano sono infatti i cosiddetti “ebrei della Cina”, “dediti al commercio e dotati di un sistema creditizio basato sull’etica del lavoro”, chiusi in “una comunità a sé”, che parla un dialetto incomprensibile.
Né cinese né italiano”, finisce per diventare il protagonista, lontano da una “Cina che continuava a cambiare velocissimamente, senza di noi”, ma straniero anche in Cina quando vi farà ritorno e sarà considerato un “banana: giallo fuori e bianco dentro”.
Eppure, è una storia di emancipazione – umana, culturale, sociale – quella che si racconta in questo libro. Un libro che fa un po’ di luce su donne e uomini che incontriamo ogni giorno, e abbiamo l’impressione di non conoscere.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora
“Lo scrivere è un ozio affaccendato.”
(Johann Wolfgang Goethe)

Ilaria Tuti, Fiori sopra l’inferno, Longanesi 2018 (pp. 366, euro 16,90)
Nella migrazione del giallo verso la montagna, fra l’agente Vogel di Donato Carrisi (La ragazza nella nebbia, Longanesi 2917) e il Jeremiah Salinger di Luca D’Andrea (La sostanza del male, Einaudi 2016, seguito l’anno scorso da Lissy) fa la sua apparizione Teresa Battaglia, un commissario che anche con il Rocco Schiavone di Manzini ha parecchio in comune.
Ruvida, burbera ai limiti della decenza con i suoi, ma capace di muoversi in un ambiente che pure non è il suo, e di cogliere, “nonostante i panorami annichilenti, l’aspetto fiabesco e i silenzi delle vette”, i “segreti inconfessabili” che si nascondono nelle case di quelli che lì hanno sempre vissuto, “uniti contro il mondo esterno e ciechi, per comodità, verso le proprie colpe”. Perché lei – malata nel corpo, e dunque fragile e sempre in bilico, ma anche nell’anima, di un dolore che non sa passare – non ha molto da perdere: in questo, paradossalmente vicina al serial killer, di cui sa cogliere la destrezza e insieme la ferocia (“ma c’è davvero differenza fra le due cose? E’ forse bravo il lupo che divora la preda o è semplicemente se stesso?”). Ma non si ferma qui: il mostro è stato un bambino, ha una storia (e che storia…), per cui è uno di quelli che “vedono l’inferno che abbiamo sotto i piedi, mentre noi contempliamo i fiori che crescono sul terreno”.

Marini, il suo collaboratore nelle indagini, la segue sollecito, ne sopporta i modi rudi e i sarcasmi senza smettere di cercarne l’approvazione. Ottenendola, di fatto, quando intuisce la cifra che contraddistingue l’assassino, il quale mutila le sue vittime perché “ruba i sensi”, cavando gli occhi per appropriarsi della vista, o dell’olfatto e dell’udito privandole di naso e orecchie (secondo procedure che non possono non evocare Hannibal the cannibal).
Il montaggio dei piani temporali (le due vicende, passata e presente, che crescono in parallelo per poi convergere), ma soprattutto la velocità dello sviluppo tengono stretto il lettore fino alla fine, lasciandogli un’impressione simile a quella che resta dopo essersi bevuti uno dei molti film ad alto tasso adrenalinico che la TV ci serve ogni sera: che l’immaginario del cinema abbia ormai permeato, dopo esserne stato attraversato, quello letterario è un fatto. Nient’affatto deprecabile. Ma qui, si direbbe che il respiro della storia sia piuttosto quello televisivo, se la distinzione ha un senso: un aspetto su cui riflettere…
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora