“La gloria o il merito di certi uomini è scrivere bene; di altri, non scrivere affatto.”
(Jean da le Bruyère)
“La gloria o il merito di certi uomini è scrivere bene; di altri, non scrivere affatto.”
(Jean da le Bruyère)

Shi Yang Shi, Cuore di seta. La mia storia italiana made in China, Mondadori 2017 (pp. 166, euro 17)
Made in China, nel titolo in copertina, è scritto come il timbro impresso sui prodotti commerciali: la storia di cui si racconta si svolge in Italia, ma il suo marchio d’origine è là, in Cina.
Perché è quello che è avvenuto là a spiegare le ragioni dell’emigrazione: l’essersi resi conto, al tempo della Rivoluzione culturale, che “la libertà non era qualcosa di cui si potesse disporre in Cina. Ma soprattutto che l’essere umano aveva un lato oscuro che può concretizzarsi in crudeltà” inimmaginabili. E dunque decidere che il destino del proprio figlio è in gioco, anche se ha appena sette anni, e l’unica via, per “garantire alla propria discendenza un’istruzione e una vita migliori” è separarsene, e mandarlo insieme alla madre nel “Bel Paese, l’Yìdàlì”.
Di qui comincia la “storia italiana” di Shi, il cui primo impatto è con “stranieri” che gli “occhi grandi e i nasi grossi” rendono del tutto simili, indistinguibili: un po’ come i cinesi per noi…

Il fatto è che, una volta partito, non potrai decidere che era meglio prima, e tornare a casa, perché “quando lasci il tuo villaggio per emigrare, ci ritorni solo con l’abito di seta. In altre parole: se non ce l’hai fatta, ti conviene restare dove te ne sei andato. Finisci incastrato in un meccanismo”, fatto di lavori dequalificati, pesanti, sottopagati, di sistemazioni al limite della vivibilità, di rapporti difficili anche con i connazionali. Quelli che Shi e la madre incontrano sono infatti i cosiddetti “ebrei della Cina”, “dediti al commercio e dotati di un sistema creditizio basato sull’etica del lavoro”, chiusi in “una comunità a sé”, che parla un dialetto incomprensibile.
Né cinese né italiano”, finisce per diventare il protagonista, lontano da una “Cina che continuava a cambiare velocissimamente, senza di noi”, ma straniero anche in Cina quando vi farà ritorno e sarà considerato un “banana: giallo fuori e bianco dentro”.
Eppure, è una storia di emancipazione – umana, culturale, sociale – quella che si racconta in questo libro. Un libro che fa un po’ di luce su donne e uomini che incontriamo ogni giorno, e abbiamo l’impressione di non conoscere.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora
“Lo scrivere è un ozio affaccendato.”
(Johann Wolfgang Goethe)

Ilaria Tuti, Fiori sopra l’inferno, Longanesi 2018 (pp. 366, euro 16,90)
Nella migrazione del giallo verso la montagna, fra l’agente Vogel di Donato Carrisi (La ragazza nella nebbia, Longanesi 2917) e il Jeremiah Salinger di Luca D’Andrea (La sostanza del male, Einaudi 2016, seguito l’anno scorso da Lissy) fa la sua apparizione Teresa Battaglia, un commissario che anche con il Rocco Schiavone di Manzini ha parecchio in comune.
Ruvida, burbera ai limiti della decenza con i suoi, ma capace di muoversi in un ambiente che pure non è il suo, e di cogliere, “nonostante i panorami annichilenti, l’aspetto fiabesco e i silenzi delle vette”, i “segreti inconfessabili” che si nascondono nelle case di quelli che lì hanno sempre vissuto, “uniti contro il mondo esterno e ciechi, per comodità, verso le proprie colpe”. Perché lei – malata nel corpo, e dunque fragile e sempre in bilico, ma anche nell’anima, di un dolore che non sa passare – non ha molto da perdere: in questo, paradossalmente vicina al serial killer, di cui sa cogliere la destrezza e insieme la ferocia (“ma c’è davvero differenza fra le due cose? E’ forse bravo il lupo che divora la preda o è semplicemente se stesso?”). Ma non si ferma qui: il mostro è stato un bambino, ha una storia (e che storia…), per cui è uno di quelli che “vedono l’inferno che abbiamo sotto i piedi, mentre noi contempliamo i fiori che crescono sul terreno”.

Marini, il suo collaboratore nelle indagini, la segue sollecito, ne sopporta i modi rudi e i sarcasmi senza smettere di cercarne l’approvazione. Ottenendola, di fatto, quando intuisce la cifra che contraddistingue l’assassino, il quale mutila le sue vittime perché “ruba i sensi”, cavando gli occhi per appropriarsi della vista, o dell’olfatto e dell’udito privandole di naso e orecchie (secondo procedure che non possono non evocare Hannibal the cannibal).
Il montaggio dei piani temporali (le due vicende, passata e presente, che crescono in parallelo per poi convergere), ma soprattutto la velocità dello sviluppo tengono stretto il lettore fino alla fine, lasciandogli un’impressione simile a quella che resta dopo essersi bevuti uno dei molti film ad alto tasso adrenalinico che la TV ci serve ogni sera: che l’immaginario del cinema abbia ormai permeato, dopo esserne stato attraversato, quello letterario è un fatto. Nient’affatto deprecabile. Ma qui, si direbbe che il respiro della storia sia piuttosto quello televisivo, se la distinzione ha un senso: un aspetto su cui riflettere…
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora
“Bisogna prendere speciali precauzioni contro la malattiia dello scrivere, perché è un male pericoloso e contagioso.”
(Abelardo)
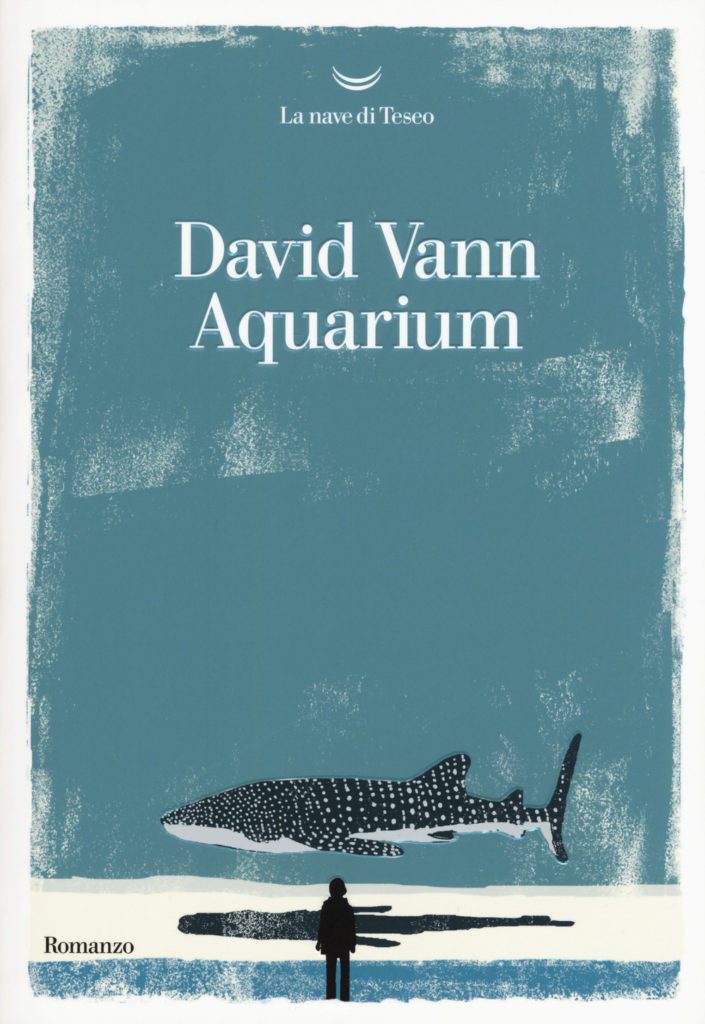
David Vann, Aquarium, La nave di Teseo 2017 (pp. 277, euro 20)
“Non avevano mai sentito il vento. Non avevano mai patito il freddo, né visto la neve. Però dovevano aspettare. E cosa vedevano nel vetro? Vedevano noi, o solo il proprio riflesso, una casa di specchi?”
Caitlin, dodici anni, all’acquario passa ore, aspettando a sua volta: finita la scuola va lì e aspetta. Aspetta che venga a prenderla sua madre, che finisce più tardi la sua giornata di lavoro, operaia a un terminal di container, a Seattle.
La bambina non ha dubbi: “Da grande sarei diventata un’ittiologa. Avrei vissuto in Australia o Indonesia, in Belize o sul Mar Rosso e avrei passato gran parte della giornata immersa in quella stessa acqua tiepida. Una vasca che si estendeva per migliaia di chilometri. Il difetto dell’acquario era che non potevamo nuotare insieme a loro.”
I pesci dei mari tropicali saranno il suo futuro, “emissari mandati da un mondo più vasto. Erano una possibilità, una specie di promessa”. Intanto sono il suo presente, e l’acquario è sinonimo di protezione: “l’appartamento – dove la sera sta con la madre – era il nostro acquario”. Fuori di lì, solo i pesci, e una compagna di scuola che le fa scoprire un genere diverso di amicizia: l’amore.
Un mondo piccolo, armonioso, non fosse per il vecchio che comincia un giorno a incontrare all’acquario. Gentile, curioso: l’unico che sappia guardare i pesci come fa lei.
Chi è? perché sembra aspettare Caitlin come se non desiderasse altro che stare in sua compagnia?
La madre lo sa bene, e quando lo scopre il suo passato irrompe a sconvolgere la sua vita, e la vita di Caitlin, che non sa ma intuisce la presenza del “peso terribile di un debito inestinguibile” e si chiede che cosa dobbiamo a chi è venuto prima di noi”, a chi ci ha messo al mondo e ha a sua volta conti in sospeso con i suoi genitori: “non permetterti mai di darti la colpa per i miei problemi”, la avverte la madre. Ma non basta: “a dodici anni non conoscevo le parole per questo, solo il peso. E ci penso ancora oggi. Quella sensazione che la mia vita sarebbe rimasta in scacco finché mia madre e sua madre non fossero state risarcite.”

A muovere il racconto verso la sua conclusione sono la dolce, ferma determinazione del misterioso anziano amico della bambina a riparare al male fatto; il sofferto cammino della madre per lasciare finalmente che il passato passi e la rabbia lasci spazio al perdono; la conquista del proprio spazio e della libertà di essere chi si sente di essere da parte di Caitlin: “come se da qualche parte ci fosse la forma della mia vita, e avessi avuto la scelta tra alcune variazioni, ma non troppo distanti dal modello”. Perché, lei ne resta convinta, non siamo tanto diversi dai pesci, che lei non si è stancata di osservare ,“ognuno leggermente diverso pur seguendo un qualche modello”.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora
“Uno scrittore è essenzialmente un uomo che non si rassegna alla solitudine.”
(François Mauriac)

André Alexis, Quindici cani. Un apologo, Einaudi 2017 (pp. 201, euro 18,50)
Un “apologo”: è l’autore stesso a definire in questo modo il suo romanzo. Ma Esopo non c’entra, per due ragioni: questi cani non insegnano nulla agli uomini.
Sono loro piuttosto, gli animali, a imparare qualcosa dovendo trarre conclusioni non lusinghiere per gli esseri con cui si trovano a convivere. E poi questi cani restano cani: possono compiacere l’umano guardando con lui un film in televisione, ma non si capacitano della sua soddisfazione: come si può godere di qualcosa che non ha odori?
Neanche Orwell e la sua fattoria sono riferimenti pertinenti, anche se sembrano evocati dalla lotta intestina che divide anche i cani di Alexis. Senonché non si tratta, qui, di una pura lotta di potere: a dividerli in due fazioni è il diverso giudizio sulle conseguenze nate dalla scommessa fatta niente meno che da Apollo ed Ermes (in Alexis il deus ex machina non risolve, non conclude, ma innesca il racconto e lo complica via via). Perché di questo si tratta: i due dei fanno l’esperimento di dare l’intelligenza degli umani – e quindi ciò che la contraddistingue, il linguaggio – ai cani di una clinica veterinaria e, appunto, scommettono: secondo Apollo – che sembra pensarla un po’ come il pastore errante dell’Asia – diventeranno infelici quanto gli uomini; secondo Ermes no: ci guadagneranno. Se uno solo degli animali morirà felice, dunque, il primo sarà smentito e il secondo vincerà.
Ma la faccenda non è così semplice: il pensiero “ci impedisce di essere cani e ci allontana da ciò che è giusto per noi”, pensano alcuni. “Ma sappiamo cose che gli altri non sanno”, pensano altri, primo fra tutti Prince , che si dà alle composizioni poetiche. È la “caninità” a rendere gli uni nemici degli altri: è un conflitto identitario a scatenare la lotta fratricida.

Peripezie e avventure, incontri minacciosi e nuove amicizie: la storia si svolge fra strade e parchi di Toronto, richiamando a volte scenari da Lilli e il vagabondo, soprattutto quando uno dei cani si accasa e stringe amicizia con la padrona. Spaventata dapprima dalle facoltà che scopre nel barbone che ha adottato, e poi via via incuriosita e sempre più amica dell’animale, al punto da porgli domande che non farebbe al marito. Tipo: che cosa pensi dell’amore? E qui la comprensione reciproca si incaglia. Non basta una lingua comune: le visioni del mondo e il modo di starci sono irrimediabilmente diversi. “Se un leone potesse parlare, noi non potremmo capirlo”, diceva Wittgenstein, e difatti al cane non vengono in mente che possibilità canine: fedeltà, sottomissione. E del resto, montare ed esser montati non hanno proprio nulla a che fare con sentimenti reciproci. Ma le tiene per sé queste riflessioni, perché lo sente: la padrona non lo capirebbe…
E dunque? Procedendo, la lettura sembra dare ragione ad Apollo: non appaiono portatori di felicità l’accorgersi che si sta per morire, e l’aver coscienza del passare del tempo anche quando la morte è ancora lontana; lo sperimentare il sentimento della la noia; il rischiare di assumere, insieme al linguaggio, la triste capacità di ferire mentre si intende confortare; l’acquisire quell’altra, pure infida, di comprendere anche chi è folle, col risultato di diventare folli a propria volta. Vincerà Apollo dunque?
Andrebbe a finire così se il rimpianto che la morte della padrona suscita nel suo cane non facesse balenare a quest’ultimo un’idea di che cosa sia l’amore, e l’immortalità della poesia non desse in extremis una speranza all’altro cane, il poeta.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora
“Ho grande stima e ammirazione per gli artigiani, soprattutto di quelli di un tempo, anzi, dirò di più, mi piacerebbe tanto essere artigiano. (…)
Probabilmente si tratta del tipo più sano di processo creativo, che scorre sempre dentro argini ben precisi senza sofferenza, senza ansie, senza romanticismo, senza lacrime e senza estasi, con una tranquilla sicurezza nella propria mano, che sa già da sé che cosa deve fare. E’ geniale, ma senza la minima trepidazione (…). Questa maestria spensierata è lontanissima dallo spirito del nostro tempo, dove tutto è basato sulla sincerità lancinante e sullo sconcerto, oppure sul desiderio di produrre qualcosa di diverso da ciò che è già stato fatto da altri, di vedere, stupire, colpire, e sul terrore di poter andare a finire casualmente su una strada già percorsa da qualche altro.”
(Pavel Florenskij)
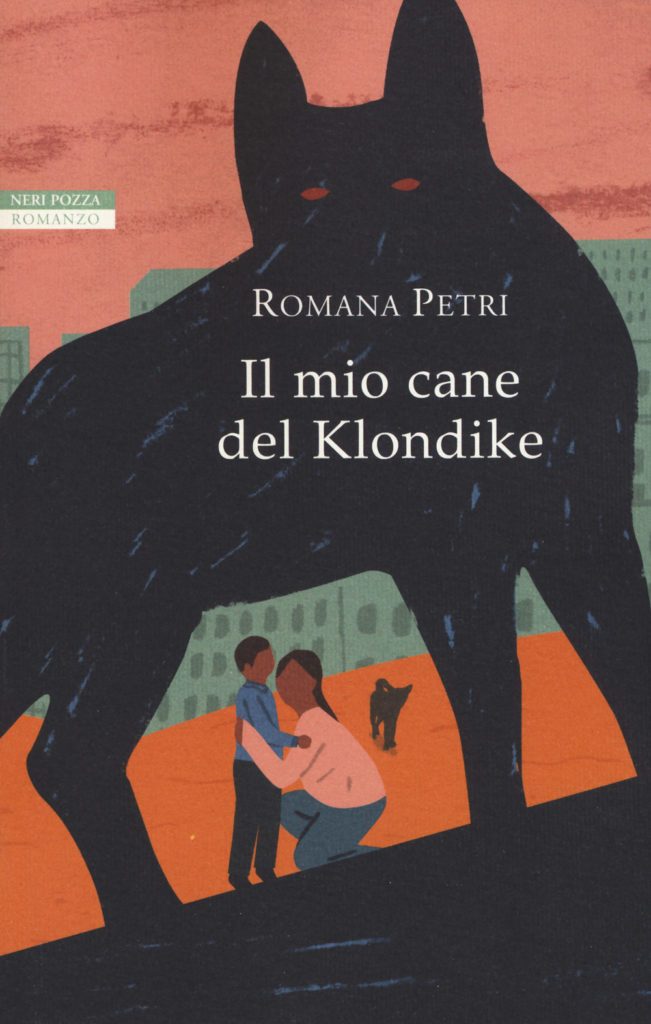
Romana Petri, Il mio cane del Klondike, Neri Pozza 2017 (pp. 205, euro 16)
Umanizzare il proprio cane, o saperne riconoscere l’alterità animale, anche quando è diventato uno di famiglia: chiunque ne abbia o ne abbia avuto uno sa che non è un’alternativa, e la strada che si percorre è sempre oscillante – comunque la si pensi, quali che siano i propositi che si fanno e le convinzioni che si crede di avere.
Abbiamo sotto gli occhi la signora che veste di cappottini colorati la propria bestiola già ai primi freddi ed è fra le prime a portarla alla pasticceria appena aperta per lei (la bestiola), così come conosciamo quello che lui animali in casa non se ne parla e il cane lo lascia fuori anche in inverno che si deve abituare. La padrona del cane di questo romanzo non si può identificare né nell’una né nell’altra posizione: Osac l’ha trovato ferito e moribondo, e non ha avuto cuore di lasciarlo lì, senza sapere che si stava portando in casa un selvaggio che sembra arrivato dal Klondike di Jack London. Eppure fra i due nasce l’amore, un amore esclusivo, per cui, quando nasce un bambino (lei è una ragazza madre, senza rimpianto di mariti, ma quella che racconta è la storia del cane, non la sua, lo ripete ogni volta che rischia digressioni autobiografiche e taglia corto) Osac è geloso, un pericolo per il piccolo. Lo deve lasciare alla madre, in campagna, e lui, il cane, sprofonda nella disperazione dell’abbandono e torna ad essere, dopo la parentesi domestica che è coincisa con l’amore per la padrona, il barbaro che non aveva smesso di essere: non è una selvatichezza ancestrale che torna a imporsi, ma una storia, la sua storia di cane abbandonato, un storia oscura, irraccontabile (solo gli umani raccontano la loro vita, o quella che credono tale).

Dopo pagine divertenti, piene delle bravate di Osac e della cocciuta e sempre ironica sopportazione della sua padrona, arriva la riflessione sulla vicenda, a dirci dell’ambivalenza che ogni rapporto con un animale (come tutti i rapporti importanti?) porta in sé e dei rimorsi che si lascia dietro: “Era un cane turbato”, “nessuno conosceva come me l’animo suo sempre in bilico, lì oscurità che o perseguitava (…) Un cane che viveva per lo più dentro il suo inferno, che lì si dibatteva, che da lì era in parte uscito quando ce ne vivevamo a Roma insieme, quando aveva creduto nelle promesse della vita nuova. E chi gliele aveva fatte ero stata io”.
Pagine che divertono. Commuovono a tratti, e si fanno struggenti, alla fine. Non riservate comunque solo ai cinofili, l’autrice ne è certa: hai probabilmente un cane “se ancora sei qui”, a leggermi – dice verso la fine rivolgendosi al lettore, “ma è altrettanto possibile che possano intenderci anche persone che di cani non ne hanno mai avuti, pur desiderandoli. Quelle persone che non hanno mai trovato le giuste condizioni: genitori compiacenti da piccoli, una moglie o un marito che compensassero da adulti. Anche queste persone, cui l’incontro vero è mancato, proprio per questo (…) dei cani degli altri, che vedono per strada, fanno un po’ di romanzo (…). Ce n’è di gente che sogna come sarebbe la sua vita se avesse un cane. E hanno poco da sognare, perché per quanto un cane la possa peggiorare, con un cane la vita è sempre un po’ meglio di cos’è senza.”
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora
“La letteratura ha questo di bello, che si può stare seduti, con la penna in mano, per giornate intere e non accorgersi del tempo che passa e sentire, nello stesso tempo, qualcosa di simile alla vita”
(A. Čechov)
“La vita cresce dalle parole, la morte dimora nel silenzio. Per questo dobbiamo continuare a scrivere, a raccontare, a mormorare versi di poesie e imprecazioni e così tenere lontana la morte, per un po’.”
(Jón Kalman Stefànsson)
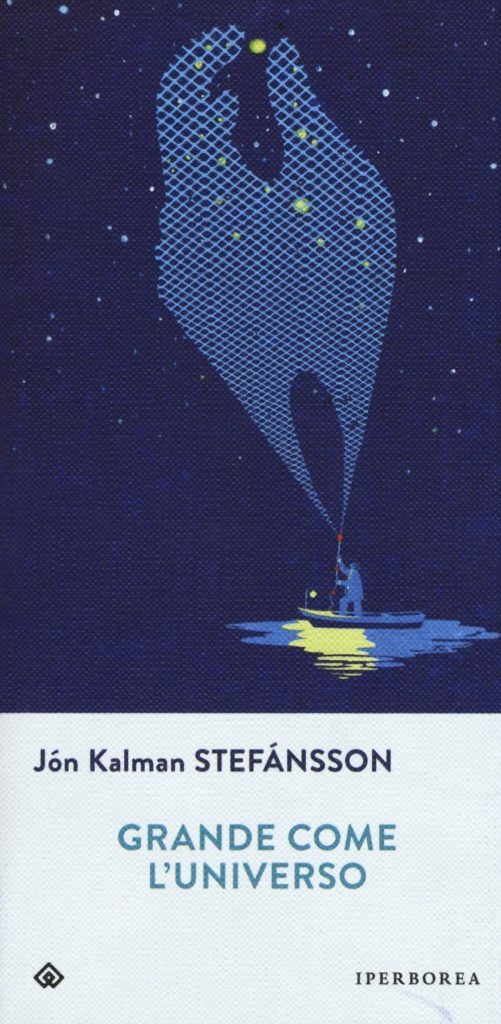
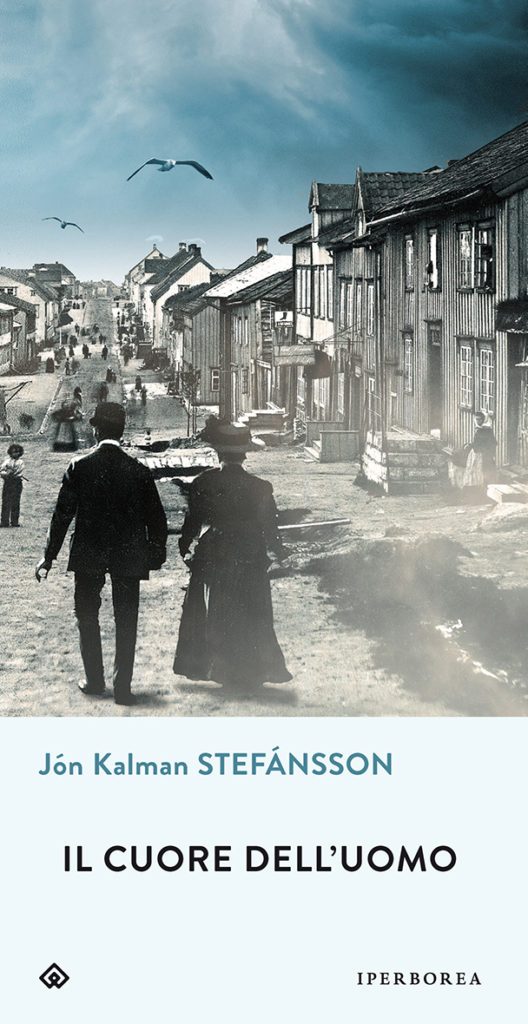
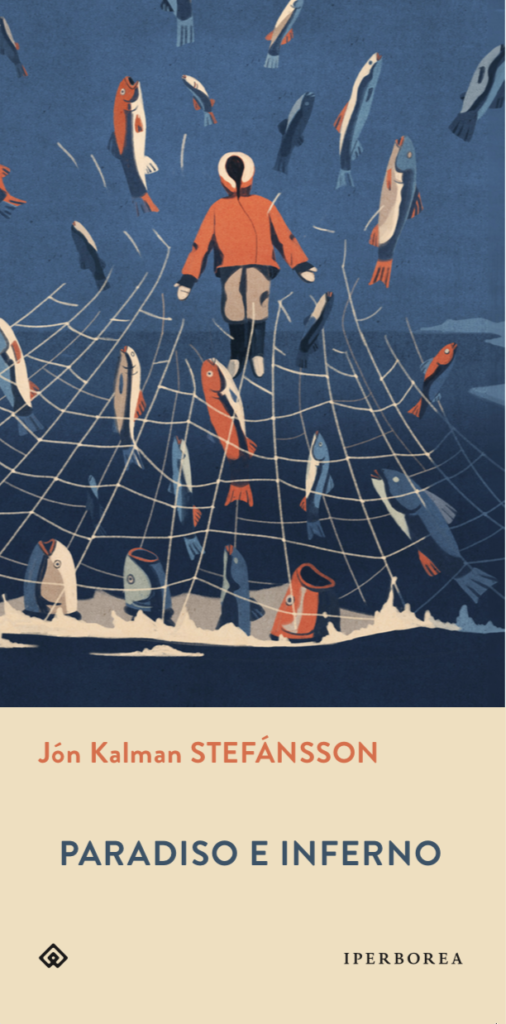
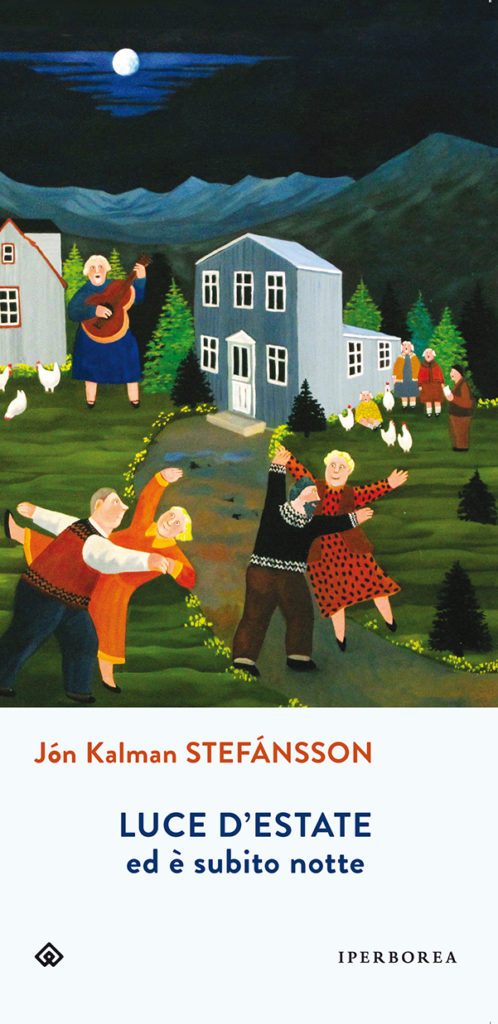
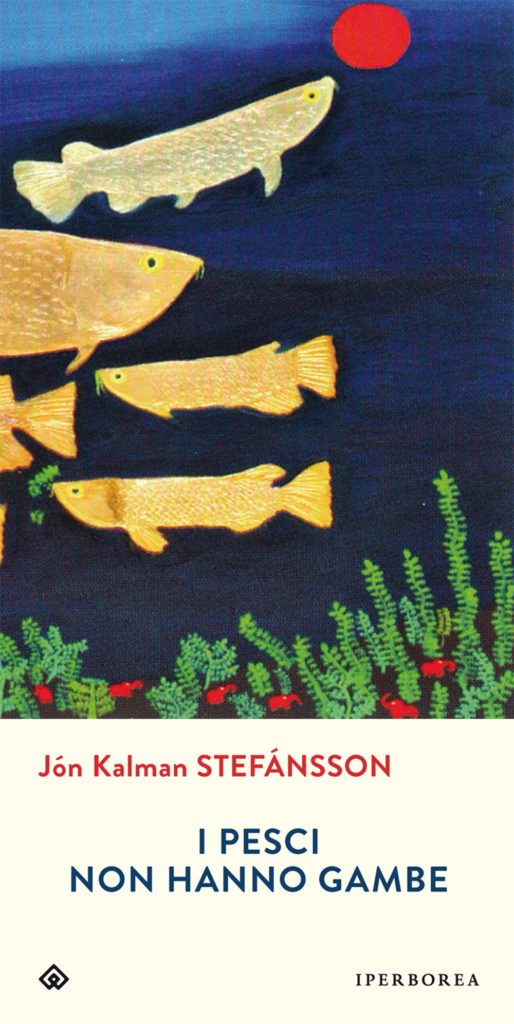

Jón Kalman Stefànsson, Luce d’estate ed è subito notte, Paradiso e inferno, La tristezza degli angeli, Il cuore dell’uomo, I pesci non hanno gambe, Grande come l’universo (Iperborea 2011-2016)
Racconta di donne e uomini comuni, donne che guardano il mare in attesa dei loro uomini, pescatori, e di villaggi sperduti fra ghiacci e nevi, “agli estremi confini del mondo”, in quel “paese inospitale”, in quella “grande isola solitaria” che è l’Islanda.
Eppure, lo sentiamo fin dalle prime pagine: parla anche di noi, Jón Kalman Stefànsson, perché sa, e non smette di dircelo, che le cose della vita, quelle che davvero contano, non sono poi molte e soprattutto non cambiano. Non che la storia non conti – “non siamo indipendenti da ciò che ci circonda e da coloro che in realtà controllano tutto: le forze della finanza, gli interessi delle società, l’incantesimo meraviglioso del capitalismo” – ma alla fin fine le questioni sono quelle: la vita e la morte, così vicine fra loro; la domanda insopprimibile di un senso dell’esistenza, che il “pantano della quotidianità” offusca ma non può cancellare; lo spazio delle donne in un mondo in cui la verità è maschile. E la solitudine, che “è come un uccello che torna sempre a posarsi sul cuore”; il silenzio che erige muri fra padre e figlio, fra marito e moglie; una Natura – non solo l’ambiente, ma anche il corpo, che di colpo invecchia – estranea e impassibile, spesso ostile.
Può accadere, leggendo i romanzi di Stefànsson, di veder poco a poco delinearsi un volto che ci è familiare, quello di Leopardi, e non è solo l’ovvio ricordo dell’Islandese delle Operette morali a richiamarlo, ma anche lo sguardo che lo scrittore posa sugli animali che “non pensano alla morte” perché “credono che la vita sia eterna” e non sono afflitti, come gli uomini, dal sentimento della caducità (“chi piange a un funerale, piange nondimeno la propria morte e quella del mondo, perché tutto muore e alla fine non resta niente”), non soffrono di quell’infelicità che solo la prerogativa dell’essere umano di “illudere se stessi” può alleviare. Ma d’altra parte “chi non sfrutta le proprie capacità non potrà mai essere felice, piuttosto vivrà nell’ombra della persona che non è mai diventato ma sarebbe potuto diventare”: seguire il proprio desiderio dunque, e affidarsi a quella che è la “sostanza della vita”, non temere il rischio dell’amore, “l’unica risposta verosimile alla morte”. Sono pieni di storie d’amore e disamore, di abbracci di corpi e di separazioni laceranti questi romanzi, trascinati da una forza vitale che non risolve mai il fondo di angoscia che abita l’esistenza ma ha guadagnato la consapevolezza che pessimismo e ottimismo non sono poli opposti e irriducibili ma sfumature cangianti di uno stesso sguardo, modi di stare nel mondo che la vita combina incessantemente.

La suggestione e la densità di questi temi non raggiungerebbero il lettore se il racconto non lasciasse continuamente spazio a lampi di riflessione, e la scrittura narrativa non assumesse a volte il passo dell’epica, o ancora più spesso s’aprisse a momenti di liricità che testimoniano della vocazione dello scrittore, autore di raccolte di poesie prima che di romanzi. Da sempre convinto, comunque, che “il potere e la ricchezza non si accompagnano mai alla letteratura e forse è per questo che rimane così incorrotta, a volte l’unica resistenza degna di questo nome”. Anche di fronte al disgregarsi di quella socialità che abbiamo trovato nei romanzi ambientati in un’Islanda di fine ’800, con la trilogia aperta da Paradiso e inferno, e appare invece solo un ricordo nella saga familiare che – con Grande come l’universo – giunge agli anni recenti della crisi, quando “questa nazione che in pochissimo tempo era diventata un modello, un esempio per l’Europa, poco dopo si è rivelata campionessa dello scatto ma un totale fallimento nel fondo”, e nelle piccole comunità in cui, un tempo, “la vita diventa(va) più grande”, manca l’aria, al punto che “chi ama l’Islanda a volte deve allontanarsene”.
Oggi tanto più occorre allora non dimenticare che “la vita cresce dalle parole, la morte dimora nel silenzio. Per questo dobbiamo continuare a scrivere, a raccontare, a mormorare versi di poesie e imprecazioni e così tenere lontana la morte, per un po’.”
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora
Dal Giornale di Brescia del 24 febbraio 2018.
Clicca sull’immagine per visualizzare l’articolo.
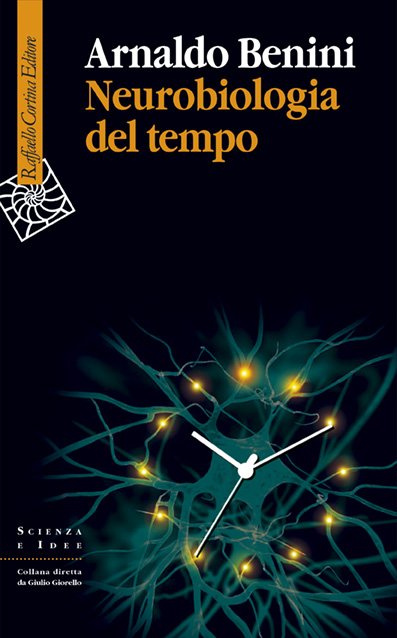
Arnaldo Benini, Neurobiologia del tempo, Raffaello Cortina Editore 2017

Carlo Rovelli, L’ordine del tempo, Adelphi 2017
“Che cos’è dunque il tempo? Se nessuno m’interroga, lo so; se volessi spiegarlo a chi m’interroga, non lo so”.
Il dilemma di Agostino non trova soluzione nei libri degli scienziati che pure si interrogano sul tempo. È se mai la domanda a cambiare: non che cos’è il tempo? ma: esiste, il tempo?
Il neurobiologo ne è convinto, pur ammettendo la dimensione soggettiva del tempo: “ Il tempo non è un attributo dell’Universo che noi percepiamo, ma è in noi”, afferma Benini, fin qui nella scia di Agostino si potrebbe pensare. Senonché, prosegue, “ le neuroscienze lo hanno localizzato nel cervello”, e qui addio Agostino e il suo tempo come estensione dell’anima.
Quel che conta, comunque – sempre secondo il neurobiologo – è che, pur essendo prodotto della manipolazione continua che il cervello ne fa, il tempo “è reale”, non se ne puo’ dubitare: “dal momento che i sistemi nervosi che lo realizzano, nell’uomo e in molte specie animali, sono componenti dell’Universo”, “il tempo è una caratteristica reale dell’Universo”.
Ma ci sono i fisici per i quali, “da Einstein in poi, il tempo è un’illusione ostinata”. È con Rovelli in primo luogo che polemizza Benini, e lo cita esplicitamente: “Il tempo non esiste. È necessario imparare a pensare il mondo in termini non temporali, sebbene questo risulti difficile sul piano dell’intuizione”. Ma è possibile prescindere dall’intuizione? Dalla concreta esperienza vissuta? Il fisico sostiene appunto sia una necessità, se si vuol capire il mondo: “la distinzione fra passato, presente e futuro non è altro che una persistente cocciuta illusione”, affermava già nella sesta delle sue Sette brevi lezioni sulla fisica (Adelphi 2014) lo stesso Rovelli, per ribadire la convinzione, lasciandosi alle spalle anche Einstein, nel libro del 2017: “per descrivere il mondo non serve la variabile tempo”, nelle equazioni delle fisica attuale non compare il tempo. Ma questo, avverte Rovelli, non autorizza a sposare la tesi dei filosofi cosiddetti eternalisti – e viene in mente un celebrato pensatore bresciano – i quali sostengono che “fluire e cambiamento siano illusori”: all’opposto, occorre pensare che “la migliore grammatica per pensare il mondo sia quella del cambiamento, non quella della permanenza. Dell’accadere, non dell’essere”. Eraclito versus Parmenide, insomma (c’è chi, nota di passaggio Rovelli, ha pensato “che sia per sfuggire all’inquietudine che ci causa il tempo che Parmenide ha voluto negarne la realtà”). E dunque – ammette il fisico – “se per tempo intendiamo null’altro che l’accadere, allora ogni cosa è tempo: esiste solo ciò che è nel tempo”.
E qui ci ritroviamo, o almeno sentono di esser tornati a casa quanti non riescono a rinunciare a pensare che “la nostra vita si svolge, nasce e muore, nel tempo, e nulla si può capire della vita se non si abbiano presenti le esperienze del tempo che si snodano in essa senza fine” (Eugenio Borgna, Il tempo e la vita, Feltrinelli 2015). Il tempo come carattere inscindibile della vita dunque, e il fisico sembra convenirne, in fondo: fatti salvi gli assunti della fisica, il tempo “è la sorgente della nostra identità. E del nostro dolore”. Ecco il punto: adeguarsi a pensare che il tempo non esiste ha il sentore di una rimozione, perché “il tempo è il nostro supplizio. L’uomo cerca solo di sfuggirvi, cioè cerca di sfuggire al passato e al futuro sprofondando nel presente, oppure di fabbricarsi un passato e un futuro a modo suo” (Simone Weil, Quaderni IV, Adelphi 1993).

Forse – ma sono gli scrittori, i letterati a dircelo – conviene credere che il tempo può smettere di perseguitarci se ci convinciamo che il tempo siamo noi, il suo trascorrere è il nostro stesso esistere. Si tratta allora, per ognuno di noi, di farcene una ragione: “per fermarmi nel tempo devo muovermi col tempo” (Italo Calvino, Ti con zero), perché “il tempo è la sostanza di cui son fatto. Il tempo è un fiume che mi trascina, ma io sono il fiume; è una tigre che mi sbrana, ma io sono la tigre; è un fuoco che mi divora, ma io sono il fuoco.” (Jorge Luis Borges, Nuova confutazione del tempo, in Altre inquisizioni).
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora
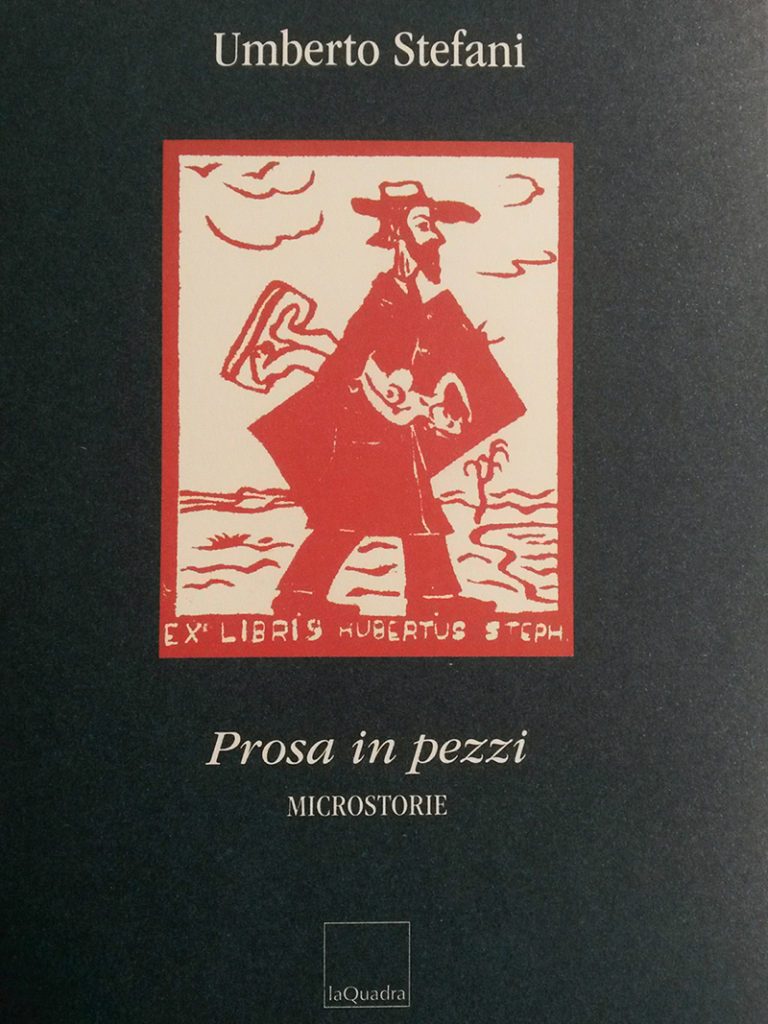
Umberto Stefani, Prosa in pezzi. Microstorie, La Quadra 2017 (pp. 148, euro 15)
Il racconto gode di possibilità infinite, anche della possibilità di configurarsi come “prosa in pezzi”.
Il romanzo invece, nella sua organica continuità, rischia di restare gravato da un approccio ottocentesco, dissonante con le trasformazioni radicali che la nostra vita, il nostro mondo hanno subito.
Questa nota, che l’autore premette ai suoi racconti, torna alla mente a lettura ultimata, ma l’impressione è – nonostante la frammentarietà del discorso – di aver letto un’autobiografia per racconti e, insieme, un’autobiografia preterintenzionale: nonostante Umberto Stefani abbia scritto questi pezzi in un arco di tempo che va dal 1983 alla fine del 2017, è la loro unità a imporsi, la loro sequenzialità: un senso complessivo che emerge solo a cose fatte, come avviene – qualcuno ha detto – per la vita, che lascia trasparire la sua trama solo quando la si è vissuta, e sono allora gli altri a potervela leggere. Ma attenzione, il libro si chiude con un’affermazione inequivocabile: “Ora so di avere cominciato a vivere”. Parole che non smettono di risuonare ora che Umberto ci ha lasciato.
Tanto più leggendoli ora, balza in primo piano la lucidità con la quale l’autore ha raccolto i pezzi che aveva scritto. Lucidità derivante dalla consapevolezza che proprio chi scrive di sé è “costretto a tradire intenzionalmente la veridicità dei fatti”: al di là dei propositi di attenersi alla più assoluta sincerità con cui iniziano autobiografie che hanno creato il genere, il racconto traccia poi la sua strada, non sempre coincidente con quella percorsa davvero. Così in questo libro: non perché l’autore ci racconta frottole, ma perché seleziona – drasticamente: proponendoci poco più di cento pagine – ciò che ha vissuto, come l’ha vissuto, non scegliendo momenti eccezionali, da proporre come memorabili per la loro esemplarità, ma episodi e occasioni in cui sente essersi manifestata la pluralità degli Io che lo hanno abitato, che abitano ognuno di noi, i personaggi di cui siamo fatti, che mettono in scena le attitudini, i desideri che pur senza continuità ci hanno guidato e ci guidano.
Ecco allora il personaggio che guarda: l’eccentricità rivelatrice della vitalità visionaria di un vecchio; la singolarità irripetibile, non omologata e non omologabile, di una commessa di negozio straniera;
oppure le rondini, recuperando, in questo caso soprattutto, lo sguardo penetrante e insieme fantasioso del Palomar calviniano. Il personaggio che guarda non ha dismesso solo i suoi pregiudizi ma anche ogni volontà di spiegare: quello che gli sta a cuore è vedere ciò che la quotidianità piatta, la familiarità che acceca, il modo di pensare diffuso non lasciano distinguere. Non si tratta della rivelazione di significati nascosti tuttavia, ma della possibilità stessa di cogliere significati altri, ulteriori, in ciò che a prima vista sembra del tutto usuale.
Diverso, ma a suo modo legato al personaggio che guarda è quello che dice no, che si oppone, che oppone la propria diversità, e a Santo Domingo – che è come dire: a quel paese – ci manda l’avvocato avido e imbroglione che lo perseguitava e rischiava di costringerlo a una resa avvilente, ma soprattutto sa tenere invita quell’isola di resistenza che può essere (ed è stata) la piccola libreria che nei piccoli libri di piccoli editori sapeva vedere grandi autori: era la libreria del libraio lettore, l’Ulisse di Umberto Stefani, che se non poteva portarli dov’era lui, dov’eravamo noi, aveva il coraggio di andarli a trovare i suoi autori, il coraggio di non temere la delusione sempre possibile dell’incontro: andare da loro intanto che erano vivi, come Bohumil Hrabal nella sua birreria di Praga.
C’è anche il personaggio che non si limita a guardare e a defilarsi , ma passare dalle parole alle cose: sembra, perché i libri che custodisce nella sua casa sono essi stesse cose, con la loro inconfondibile materialità, e le cose via via raccolte – oggetti, immagini – e conservate sugli stessi scaffali su cui sono i libri, non sono a loro volta solo cose, perché sono “cariche di narrazione”: si badi, non narrazione di imprese compiute, ma di momenti di essere; testimoni di piccole epifanie che hanno saputo dare consistenza al presente intanto che era ancora tale, intanto non si era ancora fatto passato. E dunque non sono documenti di una propria eccezionalità da certificare, ma della propria umana unicità: da vivere, da continuare a vivere, appunto, grazie anche a quelle cose che si tengono lì, fra i libri.

Infine, incontriamo in queste pagine il personaggio che, cercando la solitudine non troppo rumorosa nella quale aveva sperimentato – nella prima giovinezza – la propria capacità di pensare, di meditare, come faceva Walser nelle sue passeggiate, adesso, ad anni di distanza, la vuole ritrovare, adesso che non vive più solo ma con una donna, e un bambino, e nel mentre vive lo smacco di non averlo ritrovato, quell’Io che bastava a stesso – o così aveva lasciato credere – scopre che non c’è Io che non sia fatto dell’altro. Sia questo altro la donna con cui si condivide la vita, sia il padre che non c’è più e continua ad esserci, come tutti i padri. Il padre che non sapeva riconoscere i proprio fantasmi ma avrebbe voluto aiutare lui, il figlio, a liberarsi dei suoi. Solo adesso lo si capisce, adesso che lui è morto. Solo adesso ci si può chiede re “perché è così difficile disfarsi della presunzione di credere che siamo noi gli artefici unici della nostra condizione”. Non è, questa, una domanda di quelle che trovano risposta, ma il solo porsela – ci aiuta a capire Umberto – può donare la sensazione di aver finalmente cominciato a vivere. Non a vivere nel senso di saper stare al mondo, come si dice, avendo finalmente dismesso la propria diversità, quella che – anche se è stata fonte di sconfitte e infelicità – ci ha permesso di avere un’idea di chi eravamo: a vivere nel senso di “quel viaggiare alla ricerca di qualcosa di cui non si sappia il segno” ma che si sa coincidere con “la conoscenza di sé e l’incontro con l’altro”; quel vivere che non teme di concentrarsi nello “sguardo lancinante sulla propria nascita e la magica possibilità di morire a se stessi per rinascere continuamente”.
“La libreria è stato il luogo della mia migliore sincerità” diceva Umberto aprendo il suo Dalla Mitteleuropa, pubblicato vent’anni fa: “Da allora – aggiungeva – qualcos’altro ho scritto, con l’unica motivazione della scrittura stessa. Di ciò a suo tempo”, concludeva.
Quel tempo è arrivato, alla fine: il tempo per dire, come leggiamo in uno dei racconti, che “la sincerità – quella con se stessi, in primo luogo, credo si possa aggiungere – è condizione prima i tutti i sentimenti”.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora
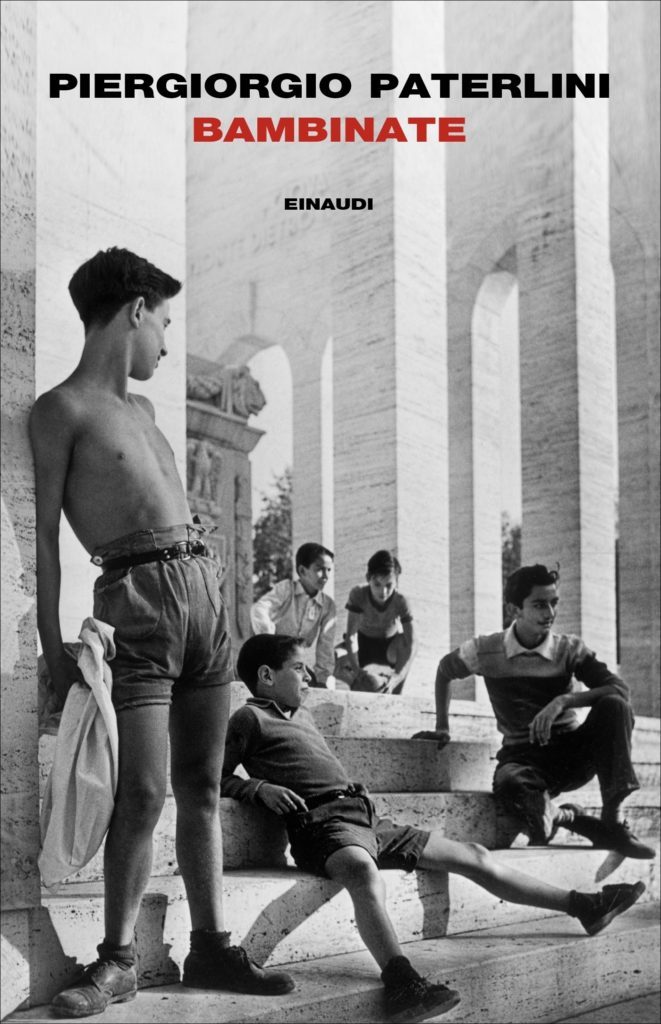
Piergiorgio Paterlini, Bambinate, Einaudi 2017 (pp. 140, euro 16,50)
Una storia di ordinario bullismo? Bambinate – che l’autore presenterà in libreria venerdì prossimo – è qualcosa di più, e di diverso.
Non solo perché la vicenda si svolge in un’epoca in cui il vocabolo bulli esisteva ma i giornali non avevano ancora diffuso il suo derivato, ma anche perché la persecuzione da parte dei compagni delle elementari ai danni del più debole fra loro pone il problema non a caso richiamato dalle citazioni che aprono le parti di cui si compone il romanzo, a partire da quella di S. Agostino che afferma, molto prima di Freud, che l'”innocenza infantile” non esiste. Ma qui non si tratta solo di smentita del mito di quell’innocenza: la storia propone un esempio di cattiveria gratuita, di sadismo di branco. Partendo da quello, il romanzo si sviluppa attorno alla “cicatrice indelebile” che il fatto lascia nell’anima del protagonista. Testimone dell’episodio, non partecipe attivo ma di fatto, nella sua inazione, complice, e per questo gravato da un senso di colpa che a lui, a differenza di quel che accade al più crudele dei compagni, il capobanda, non permette di dimenticare, tanto più di dimenticare di aver dimenticato: “odiavo soprattutto Ermes che ci aveva trascinati in quella ferocia e odiavo me stesso per non essermi ribellato” a quella “vigliaccheria” che “ormai mi aveva sporcato per sempre.”

Veder trasparire nello sguardo del proprio figlioletto lo stesso sguardo, incredulo prima che terrorizzato, della vittima di quel rito persecutorio rende impossibile ogni rimozione. E l’invito a partecipare a una cena di classe, e quindi a tornare al paese dopo cinquant’anni, suona come un richiamo ineludibile ad una resa dei conti troppo a lungo rimandata, e che si risolverà in un modo drastico, imprevedibile.
Non ci sono scorciatoie: né quella del pessimismo antropologico (il male è innato negli uomini, fin dalla più tenera età: che ci vuoi fare?) né quella del sociologismo facile (è la cattiveria della società che si esprime nei comportamenti devianti dei ragazzi). Le scelte, comprese quelle che non si è saputo fare, anche se risalgono all’infanzia impongono un prezzo. Il protagonista di Bambinate decide di pagarlo.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora

Giorgio Montefoschi, Il corpo, Mondadori 2017 (pp. 221, euro 19)
La vita accade mentre si susseguono giorni fatti degli stessi gesti e delle stesse parole, degli stessi tragitti e degli stessi incontri.
Più che la monotonia sembrano essere la continuità, la familiarità dei volti e dei luoghi, il tratto predominante: c’è un che di rassicurante negli elenchi di vie e piazze di Roma che i personaggi percorrono. Una topografia, e una toponomastica, precise, puntigliose, come le puntuali descrizioni di quel che si beve e si mangia. Insieme, o da soli.
La vita accade al di sotto di questa continuità, ed emerge, nella sua realtà, solo quando una malattia seria interviene a turbarne il ritmo. L’imprevisto sembra tuttavia potersi riassorbire, lasciando che l’esistenza riprenda a scorrere come sempre. L’infarto, a Giovanni – avvocato sessantenne, ammogliato, agiato – non cambia la vita. Eppure scava, impercettibilmente: gli sarebbe cresciuto dentro l’innamoramento per la compagna del fratello se non gli fosse capitato quell’accidente?
È Serena, la moglie, ad avvertire i cambiamenti che covano, e a dirne – con un tono che appare coerente al nome che porta – al marito, il quale invece va avanti, adeguandosi al trantran quotidiano come alla fatalità – così sembra volerla interpretare – di un amore che ribalta la sua famiglia e quella del fratello.

È tutta qui la storia. Un adulterio. Come in tanti romanzi. Ma più della vicenda, è lo sguardo del narratore a farci proseguire nella lettura: non giudicante, descrittivo, divagante spesso, e pure capace di far risaltare il vuoto che si annida, e cresce, nelle vite. Non enunciandolo, ma rendendolo percepibile nel fare di personaggi che sembrano sfuggire a se stessi, che sanno e non vogliono sapere, che agiscono come non sapessero.
Non c’è angoscia, ma un rattenuto – e non sappiamo fino a che punto consapevole – senso di liberazione nella constatazione che alla fine il protagonista – dopo un altro malore, in convalescenza nella località di montagna da sempre frequentata – non può non fare: “Si sta bene qui al Rid, mormora Giovanni. Ma lo sa che il tempo è finito”.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora

Trascrizione dell’intervento pronunciato nel corso della XVI edizione di Dies fasti, giornate organizzate dagli studenti del Liceo Calini di Brescia il 15 e 16 novembre 2017. Tema prescelto quest’anno, “Il domani”.
Mi trovo a parlare di domani a chi ha cinquant’anni meno di me, e immagino che cinquant’anni vi sembrino un periodo lunghissimo: un’epoca storica più che un arco di vita. Si tratta in effetti di un intervallo di tempo in cui sono successe molte cose, il mondo è cambiato, e sta cambiando (in modo ancor più radicale, probabilmente, di come è avvenuto nella prima e nella seconda rivoluzione industriale).
Non è facile pensare che cinquant’anni siano un’entità temporale che possa riguardare se stessi, se si ha meno di vent’anni. Eppure, posso dire che non è molto diverso neanche per me che ne ho quasi settanta: anche a me pare irreale che sia passato mezzo secolo da quando avevo la vostra età (e anche da quando, di poco superati i vent’anni, da precario, per un paio d’anni ho insegnato in questa scuola storia e filosofia.
Dal Corriere della Sera (Brescia) del 10 gennaio 2018

«Io, bambino, accolto nel gruppo dei suonatori. Io, piccolo, in mezzo a loro, avvolto nel suono del bassetto, delle chitarre e dei violini. Ero troppo piccolo per suonare, e sentivo di essere privilegiato rispetto gli altri bambini nel poter stare lì, ai piedi di mio papà che suonava. Il violino».
Nel primo ricordo che Daniele Richiedei ha del Carnevale del suo paese, Bagolino, a occupare la scena è la musica, l’esperienza dell’essere immersi nella musica: un po’ come accade a chi, come lui oggi, suona in complessi musicali e in orchestre.
Continua a leggere Figure e paesaggi / Da «sonadùr» al Carnevale a concertista

David Szalay, Tutto quello che è un uomo, Adelphi 2017 (pp. 402, euro 22)
Che siano giovani turisti o maturi professionisti, uomini affermati o pensionati più o meno agiati, i protagonisti delle nove storie che fanno questo libro non hanno comunque, o non vogliono, un luogo stabile nel quale stare.
Una condizione, la loro – non esclusi quelli che pure si trovano dalla parte dei “vincenti” – che appare metafora di una pervicace incapacità di stare nella vita. Che cerchino rifugio nella cultura, nel successo professionale, nel potere e nella ricchezza, o che vivano invece in posizioni marginali – per età, vicenda biografica, scelta deliberata – appaiono tutti afflitti da una sorta di inettitudine alla vita, e all’amore inteso come incontro che dia significato all’esistenza. Il loro desiderio è il desiderio maschile per vie diverse vocato al fallimento e, sempre preoccupato di sfuggire a un vero coinvolgimento, alla frustrazione. Ma è la loro stessa vita, più in generale, a rivelarsi priva di senso quando all’improvviso si rendono possibili “passeggere immersioni nella trama dell’esistenza”, sporadici, folgoranti ma effimeri momenti di lucidità. Insensata o comunque sfuggente sempre, o sprecata addirittura, secondo l’età: vicina eppure come al di là di un vetro resistente, e sporco, reso opaco da giorni e anni passati in una non innocente e ostinata inconsapevolezza (“non capiamo la vita mentre accade”) e, ad un tempo, in un ininterrotto sforzo di fuggirne, come non fosse, quella che si è vissuta, che si vive, la vita vera. Hanno un bel dirsi, questi uomini, che “è tutto qui. Non c’è nient’altro”, e “la vita non è un gioco”: è fatta delle cose che succedono qui, adesso”, e di quel che si sta vedendo, e può donare, sia pure fuggevolmente, il “piacere di percepire le cose”. Non basta: anche quando la loro corsa lascia ormai intravedere l’approdo per tutti inevitabile non riescono a credere alla propria morte: scoprire di essere invecchiati è uno choc, fonte di rimpianto bruciante, di depressione, di un’esperienza vertiginosa di isolamento.
Dopo aver stentato, renitenti, a crescere, a diventare adulti, subito si ritrovano vecchi. E soli.
Affrontare la realtà del trascorrere del tempo e della caducità può tutt’al più suscitare il pensiero che proprio la transitorietà, di tutti e di tutto, l’impermanenza, sia l’unica realtà eterna. Non fosse che, anche questa intuizione, all’ultimo dei personaggi che incontriamo, il settantatreenne protagonista del nono racconto, non appare in fin dei conti niente di più che “qualcosa con cui alleviare l’incubo dell’invecchiamento e della morte”. Un espediente, dispensatore di un certo conforto magari, ma incapace di nascondere, in fondo, la propria strumentalità.
Non viene esplicitato un nesso causale fra la dimensione esistenziale dei personaggi e il tramonto di un’Europa che, al di là della diversità dei luoghi in cui le storie sono ambientate, lascia trasparire l’inconsistenza di un esteso e pervasivo non luogo, ma alla fine si ha la sensazione che le storie che abbiamo letto – come fossero le varianti possibili ma sostanzialmente conseguenti dell’itinerario di un solo uomo – non potrebbero collocarsi che in una situazione qual è quella contemporanea del continente in cui viviamo.

Sensazione, niente di più. Perché Szalay non inclina all’argomentazione. Ha l’aria di raccontare quel che ha visto, che vede. Con una scrittura che dimostra di sapere il limite delle parole, e dunque rifugge da sottolineature e tentazioni di spiegazione, e per dire il di più per cui le parole appunto non basterebbero ricorre piuttosto, pur senza mai eccedere, ad espedienti visivi (a capo senza punteggiatura e disallineati, o addirittura pagine bianche).
Una scrittura facile verrebbe da dire, perché non sembra il frutto di successive reiterate limature e sottrazioni. Si direbbe nata così: da uno sguardo possibile solo da una posizione che sembra collocarsi al di là del disincanto, o della disperazione. Uno sguardo che ci si stupisce di dover attribuire a un quarantenne.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora

Eshkol Nevo, Tre piani, Neri Pozza 2017 (pp. 255, euro 17)
Tre piani, tre racconti. Uno per ciascuna delle famiglie che abitano la palazzina. Ma Perec e il condominio del suo La vita, istruzioni per l’uso non c’entra.
Niente giochi combinatori qui, ma tre storie che si tengono fra loro. Grazie innanzitutto al fatto che il loro protagonista le racconta a un tu di cui non sentiamo la voce, perché i suoi interventi vengono tralasciati, o perché è il destinatario di una lettera che non avrà risposta, o perché è morto e la moglie gli si rivolge attraverso una segreteria telefonica che sa bene resterà per forza di cose inascoltata. Sta di fatto che – un po’ questo espediente, un po’ la lingua di tutti i giorni cui lo scrittore si attiene – chi legge si lascia prendere e passa di racconto in racconto ritrovando, in vicende diverse, il contesto e il tema che stanno a cuore all’autore: il primo è quello della famiglia, del rapporto fra padre e figli; il secondo è rappresentato dal non detto che è presente in tutte le relazioni. Padri che non sono o si sospettano inadeguati, o incapaci di entrare in rapporto col figlio; segreti che resistono per decenni in un mondo, come il nostro, nel quale “non esistono più segreti” e “tutto è scoperto, fotografato, condiviso, tutto trapela, passa, è su Facebook, tutto è sbandierato, spudorato, niente più è misterioso al tuo moroso”. Ma non solo le ombre che hanno segnato la vita delle famiglie compaiono in questi racconti. Ce ne sono anche nell’intimo di ciascuno, ed è quando il personaggio se ne accorge che il racconto prende quota: quando l’inquilino del primo piano si trova a dover ammettere che anche lui, come tutti, cova dentro di sé un “piccolo criminale”, o l’inquilina del secondo sente sbriciolarsi “la fiducia nel fatto che un se stessi esiste, che esiste qualcosa di stabile in mezzo a tutto questo casino dell’essere una persona”, mentre la vedova del terzo non ha remore nel riconoscere che “il più grande segreto che possiamo nascondere al mondo” altro non è che quello della “nostra vulnerabilità”. E non si tratta né di giudicare né di essere giudicati, perché – occorre ammetterlo, ed esserne consapevoli – “la nostra anima non procede in avanti, solo in cerchi. E ci condanna a cadere e ricadere nelle stesse buche”.

Non c’è che un rimedio, allora: raccontare, raccontare tutto a qualcuno di cui ci si può fidare perché sai che ti vuole bene e ti prende per quello che sei: “se non c’è nessuno ad ascoltare, allora non c’è nemmeno la storia”. “L’importante è parlare con qualcuno. Altrimenti, tutti soli non sappiamo nemmeno a che piano ci troviamo, siamo condannati a brancolare disperati nel buio, nell’atrio, in cerca del pulsante della luce.”
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora