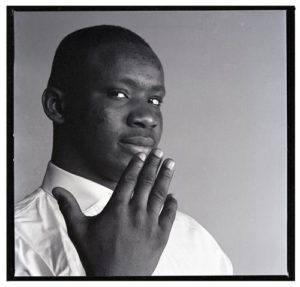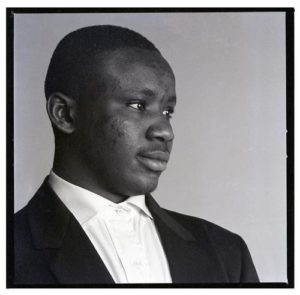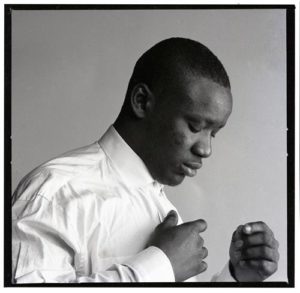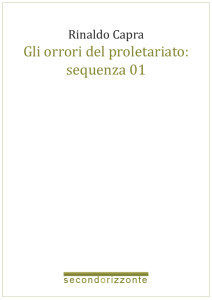Mi piace guardare i libri, averli vicino. Lo sguardo scorre sugli scaffali come su un paesaggio lontano, l’occhio si rilassa, si cheta. Li sento dentro i libri, e ho l’impressione che la loro semplice presenza mi arricchisca comunque, come per osmosi, compresi quelli che non ho mai letto, ma che sono lì e mi guardano, mi aspettano e un giorno leggerò spero. Alcuni sono veramente vecchi, al punto che le copertine delle edizioni lussuose hanno ormai perso l’odore di pelle e l’oro dei caratteri è diventato color rame. Quando li prendo in mano cavandoli dallo scaffale osservo lo stato di consunzione delle confezioni, i piccoli segni di biro, le macchie di chissà che cosa, le piccole notazioni a matita. Le pagine non sono tutte intonse, c’è qualche piccola orecchia o piegatura accidentale, ma in sostanza tutto denuncia una cura attenta dei volumi, anche se non maniacale. L’Ulisse, pressato dagli altri volumi della mia libreria, che ho letto alla carlona, spesso senza finirli, denuncia un’usura particolare, che evoca ricordi, che racconta quanto è stato stretto dalle mie mani e quanto ha viaggiato nella mia borsa. Lo prendo e ora che ce l’ho in mano, vedo che ha gli angoli della copertina di pelle scoloriti e piegati verso l’interno del volume, come le valve di un’ostrica che non vuole aprirsi. E invece è stato aperto moltissimo, e letto e riletto. Da quell’estate del ’71 me lo porto dappertutto; è un rituale, apro il libro, dove capita e leggo, rileggo, penso, guardo il soffitto e torno a leggere l’Ulisse. E’ domenica pomeriggio, nella vivida luce del sole d’inverno che entra dalla finestra, apro il libro a caso, a pagina 35 e leggo:
– non pianger più, dolente pastore,non pianger più
Ché Lycidas, tuo duolo, non è morto,
Benchè sia sprofondato sotto l’equoreo piano…. –
Mi accorgo che ci sono dei piccoli rigonfiamenti su tutta la pagina. Non delle pieghe, ma dei rigonfiamenti grinzosi, circolari, di vari diametri. Ne scorro con le dita la superficie e sento distintamente queste vascolarizzazioni anomale della carta, che osservate in controluce, descrivono una serie di bugne come dune, con piccole grinze a raggiera e sotto i polpastrelli diventano un Braille che racconta solo per me. Solo delle gocce d’acqua abbattutesi sulla pagina, possono produrre questo effetto. E’ indiscutibile: la pagina si è bagnata. Guardo anche le pagine successive e ci sono sempre gli stessi segni, via via meno evidenti che scompaiono del tutto a pagina trentanove, dove la carta ha di nuovo la sua perfetta planarietà e leggo:
– Amor matris: genitivo soggettivo e oggettivo. Col suo sangue debole e il suo latte sieroso l’aveva nutrito e aveva nascosto agli altri le sue facce. –
L’acqua è penetrata per alcune pagine, ma non ha rovinato il testo e pur rimanendo compresse tra gli altri libri, esse non sono tornate perfettamente lisce, ma conservano queste cicatrici. La pagina trentacinque parla di un annegato e la trentanove di latte, sangue e inquietante amore materno, e queste pagine, proprio queste, si sono bagnate.
Ora ricordo.
Era il settembre ’71, eravamo in vacanza a Idro, un piccolo lago alpino, freddo e tetro, meta di villeggiatura di olandesi e tedeschi, per loro quello era già un paesaggio mediterraneo. Mio padre si era invaghito di una signora olandese che qui gestiva una locanda e così aveva temerariamente portato tutta la famiglia, moglie compresa, in vacanza su questo lago. Lui scompariva continuamente, – Va dalla vacca olandese – diceva mia madre schiumando rabbia. Aspettavamo tutti in questo piccolo paesino, senza auto, né telefono, né una bicicletta, il ritorno di mio padre dalle sue escursioni erotiche. Gironzolando per i vicoli e prendendo il sole sull’unico pontile del paese, conobbi dei ragazzi, un olandese, due tedesche, un’italiana figlia del barista e una ragazza inglese lentigginosa e in sovrappeso. Facevamo il bagno e poi sul pontile stesi sugli asciugamani a fantasticare e tentare i primi approcci amorosi. L’inglese era la più disinvolta, ma non mi piaceva, troppo in carne, mentre la figlia della barista, era carina e minuta, era italiana e amava la poesia. Le ragazze tedesche, spilungone e bionde, avevano occhi solo per l’olandese, anche lui sedicenne, ma molto più alto di me e con quell’aria vissuta di chi ha già provato gli eccessi della beat-generation, il che mi annichiliva. Unica consolazione: io mi tuffavo e nuotavo meglio di lui.
Quasi tutti i giorni, istigato da mia madre, passavo davanti alla locanda della signora olandese per sbirciare dentro il suo ufficio e vedere se ci fosse mio padre, ma non lo beccai mai da quella “puttana“, e poi giù al pontile con gli altri. Lui, l’olandese, ostentava il vinile di “In a gadda da vida degli Iron Butterfly “, riviste beat olandesi, illeggibili per me, e misteriosi rotolini di stagnola che promettevano viaggi allucinogeni, scatenando i lascivi gridolini delle ragazze. Volevo che mi notassero e tentai l’ostensione del quotidiano “Lotta continua” e dell’Ulisse di Joyce, che suscitarono la morbosa e pressante curiosità solo della grassottella inglese e la completa indifferenza delle ragazze, ma anche uno sguardo di riprovazione della figlia del barista: da quelle parti i comunisti non sono mai stati popolari. L’olandese stava sdraiato sulla schiena, gli occhi piantati sulle tette della tedesca inginocchiata al suo fianco che si spazzolava i capelli, l’inglese mi sorrideva ammiccante, mentre l’unica che volevo mi guardasse se ne stava lontano a leggere “Ciao 2001”. Dovevo fare qualcosa per attirare la sua attenzione, quindi saltai in piedi e con un balzo, arrivai al bordo del pontile esibendomi nel tuffo più plastico di cui ero capace. L’entrata in acqua perfetta; mentre riemergevo, mi aspettavo di vedere tutte le ragazze sporgersi dal pontile per sorridere al miglior tuffatore del paese, ne ero certo, invece solo l’olandese si sporse per lamentarsi che gli schizzi d’acqua l’avevano molestato mentre rollava la sua canna. Risalito, grondante e deluso, sul pontile mi gettai sul mio asciugamano, sul quale era appoggiato l’Ulisse aperto a pagina 35. Ero talmente avvilito che non mi curai delle gocce che colavano dai miei capelli sulla pagina. Pagina 34 si salvò perché protetta da un volantino di Lotta continua piegato in due che usavo come qualificante segnalibro. Subito asciugai l’acqua tra mille imprecazioni e l’indifferenza di tutti, tranne che dell’inglese che mi offrì un “ kleenex” come disse lei. L’acqua però aveva già fatto il suo percorso ed era penetrata fino a pagina trentanove.
Il giorno dopo l’olandese, che parlava un italiano discreto, veniva a Idro fin da bambino, mi disse: – Che ne dici se dopo la nuotata andiamo a casa mia, ti voglio far vedere i miei dischi, così ci togliamo dalle palle ‘ste befane. – M’invitava a sentire i suoi dischi, il tuffo aveva avuto un esito, anche se non quello sperato.
Con Joyce avvolto nell’asciugamano, lo seguii fino a casa sua: era la locanda della signora olandese. Entrai con meraviglia e un fondo di vergogna e il senso di colpa per tutte le volte che avevo sbirciato dentro. La signora olandese mi venne incontro sorridente, radiosa, il mio nuovo amico era suo figlio e mi vergognai ancora di più. Era molto gentile e feci la fantasia che lo fosse perché sapeva che ero il figlio del suo amante. Mi guardava con dolcezza, mi mise la sua lunga e morbida mano sulla guancia per una carezza leggera, sorrise con i suoi grandi occhi azzurri e m’indicò la scala per salire di sopra, nel loro appartamento, dove il mio amico teneva lo stereo e i dischi. Frastornato, mi guardavo attorno, ero imbarazzato e spaventato, temevo che mio padre potesse sbucare da qualche angolo riempiendomi di ceffoni per essermi intrufolato lì. Certamente avrebbe pensato che mi fossi messo a disposizione di mia madre per pedinarlo e che avessi fatto amicizia col figlio della sua amante solo per stanarlo. Ero terrorizzato. Entrai in camera, avevo di fronte un poster del Festival dell’Isola di Wight e sulla parete di lato un altro, con una ragazza a gambe incrociate che si accendeva una canna. I dischi sparsi sul letto e impilati sulla scrivania, e uno stereo bellissimo mi fecero morire d’invidia. Chiuse la porta, si rollò una sigaretta e senza guardarmi chiese:
-Tu conosci I Doors?- e senza aspettare risposta, era scontata, e sempre senza guardarmi – Ho il disco, me l’ha portato mio padre da Amsterdam. E tre mesi fa ho visto il loro concerto, una bomba.- E mise il disco a volume folle, si lasciò cadere in estasi sul tappeto fumando a occhi chiusi.
– Ma tua madre ti lascia fumare e tenere la musica a questo volume senza incazzarsi? non ci posso credere. –
– Mia madre si fa le sue cose, io non le rompo le palle e lei non le rompe a me, in Olanda è così. Tieni, vuoi un tiro? –
Mi porse la sigaretta, era umida della sua saliva ed io avevo un po‘ schifo, inoltre non fumavo ma, quel giorno, cominciai. Ero felice, musica da sballo, il brivido della prima sigaretta e stare lì, con l’amico così sicuro di sé e disinvolto come avrei voluto essere io, ma allo stesso tempo non vedevo l’ora di andarmene.
Tornato a casa ripensai a mio padre, alla signora olandese e a mia madre che bruciava di gelosia. Erano due donne così diverse, da tutti i punti di vista, che mi piacevano e inquietavano, e per un attimo l’immagine di quei due universi femminili si sovrappose nella mia mente in un’unica immagine confusa e nebulosa. Ero disorientato, mamma era così poco attraente, mentre la signora olandese lo era, mi piaceva molto, anche fisicamente. Pensai come sarebbe stato averla come madre e senza accorgermene giustificai papà. Subito mi vergognai molto di quella fantasia.
Le mie sorelle giocavano sul balcone di casa, i pochi pescatori attraccavano le barche al pontile e mio padre uscì dal bar del paese barcollando, vistosamente ubriaco, tirando voluttuose boccate di fumo che poi faceva uscire dalle narici, con gli occhi arrossati e umidi, sembrava un drago. Lo vedevo venire verso casa, era stato al bar a giocarsi lo stipendio a carte e si era ubriacato: allora non era dall’olandese. Del resto, pensai, la signora olandese era troppo alta, lo sovrastava e lui, orgoglioso attaccabrighe proletario, non ci sarebbe mai stato con una così alta. Sorrisi e pensai che mamma forse sbagliava e con sollievo mi sentii esonerato dal compito di pedinatore, di delatore, di spia.
La mia famiglia aveva rotto tutte le relazioni con gli amici in modo turbolento per le scenate di gelosia di mia madre, o per quelle di qualche marito che accusava la propria moglie di farsela con mio padre.
Come mio papà mise piede in casa e si scatenò l’inferno. Mia madre l’aggredì e tentò di colpirlo con la paletta di ferro del camino, lui nonostante la sbronza schivò il colpo, aveva ancora tutti gli automatismi attivi, ma indietreggiando inciampò in uno sgabello e cadde a terra bestemmiando come solo lui sapeva. Mia madre imprecava pur senza bestemmiare, ma cominciava a comparire quel rantolo che sapevo, l’avrebbe portata a uno dei suoi svenimenti. Al culmine della rabbia impallidiva e uno spettrale suono gutturale le usciva dalle labbra e dalle narici, e poi grondando sudore gelido, stramazzava a terra, immobile, occhi chiusi, improvvisamente silente. Credevo sempre che fosse morta e mi disperavo. Poi, di solito dopo qualche minuto e con mio padre che le teneva la testa, intonava una nenia sommessa e malinconica, incomprensibile, così penosa che mi angosciava ancor più della paura che potesse essere morta. Non volevo godermi di nuovo quello spettacolo. Mi caricai in spalla la sorella piccola, presi per mano la grande e li lasciai ai loro rituali perversi, seguito dalle urla etiliche di mio padre e dai tetri rantoli di mia madre.
Girai un po’ per i vicoli, lungo la spiaggia e senza accorgermene mi trovai, con le mie sorelle, davanti alla locanda della signora olandese. Ci vide, si affacciò alla porta e c’invitò a entrare, diede delle bibite alle bambine e una sigaretta a me.
– Non fumo signora- ma lei, spingendo ancora di più il pacchetto aperto verso di me, insistette:- Ma va là, se sei amico di mio figlio fumi e non solo sigarette. Comunque qui puoi e rimarrà un segreto tra noi.-
Accendendo la sigaretta, guardai i suoi tratti signorili e gentili: provai un affetto intenso e languido, quasi filiale. Per un attimo dimenticai i due disperati che avevo lasciato a casa. Le mie sorelle giocavano con la signora olandese come fossero sempre state lì, sembrava tutto così normale. Tornai a casa e mia madre distrutta, piena di lacrime, mi disse: – Ti sembra questa l’ora di tornare? Cretino! Le tue sorelle non hanno ancora mangiato. –
Mio padre si era chiuso in bagno. Apparecchiai un tavolo striminzito, mia madre riempì tre piatti di minestra per noi e se ne andò sul balcone a piangere silenziosa. La guardai e non capii. Sapevo solo che non volevo essere lì, con quei due che avevo amato alla follia: lui con le sue auto sportive, gli amici piloti e play-boy, e lei con le sue storie di partigiani, di sindacalisti e di lotta contro la “razza padrona”. Volevo solo essere da un’altra parte, qualsiasi altra parte, purché non ci fossero loro.
Misi a letto le mie sorelle, tentai di leggere ma non ce la feci. Ero esausto, chiusi gli occhi e fantasticai di baciare la figlia del barista, era un desiderio dolcissimo e mi addormentai.
Nel cuore della notte, saranno state le tre del mattino, mia madre mi svegliò scrollandomi una spalla:
– Alzati e vieni in cucina, tuo padre deve parlarti. –
– Cazzo – pensai – neanche di notte questi due la piantano. Fanculo. – e mi alzai. In cucina sotto la fredda luce del neon, mio padre era seduto sulla sedia, vestito come se stesse per uscire, e fissava le due valigie posate davanti ai suoi piedi. Il viso contratto in uno spasmo di rabbia, non era più ubriaco ma rabbioso e affranto, impotente e sconsolato, incazzato e pieno di rancore, come fosse vittima di un grande torto. Mia madre aveva riacquistato energia e colore, gli occhi determinati e l’espressione altera di chi pensa di aver fatto suo il punto partita. Fu lei che parlò, non lui:
– Tuo padre voleva dirti che se ne va, perché non sa rinunciare alle sue puttane. Del resto se sta qui, rischia che una di queste notti io gli pianti un coltello in gola, per cui è meglio così.- Poi gli si avvicinò, guardandolo dall’alto in basso e spingendo col piede una valigia verso la scala continuò: – Le tue sorelle sono piccole, ma tu devi vedere e sapere perché io non lo voglio più. Deve andarsene! è un puttaniere drogato, non gliene frega niente della famiglia e preferisce scoparsi le altre donne, che comunque sono tutte puttane!- un’ultima spinta col piede e la valigia precipitò giù dalle scale, poi raccolse l’altra e la lanciò direttamente in strada. Mio padre si alzò, mi guardò con un’espressione mista di rabbia e di ricerca di compassione e sospirò: – Di a tua madre che da qui non me ne vado! Voi siete la mia famiglia e senza di voi muoio, mi ammazzo!-
Cristo, che pensare? Che fare? Cazzo stavolta facevano sul serio, lui se ne andava ed io che potevo fare? Mi sentii schiacciato, la gola secca e non riuscii a dire nemmeno una parola ma mia madre m’incalzò: – Diglielo che anche tu non lo vuoi più in casa un padre come lui, un traditore, un giocatore che si è fatto persino la moglie di suo fratello. Un pervertito, sporcaccione. Nemmeno i fratelli rispetta. Diglielo di andarsene. – Non sapevo più che fare, a sedici anni che cavolo c’entravo io: volevo solo essere un artista e un intellettuale, leggere Joyce e ascoltare i Doors. Dentro di me si affacciavano tutti i sentimenti, dalla codardia all’opportunismo, dalla rabbia al dolore, dalla paura alla disperazione e alla fine cedetti. Guardai mio padre che ormai piangeva a dirotto e lo implorai: – Per favore vattene papà, la mamma ha ragione. – Mi guardò stupito, pianse e sconsolato mi disse con enfasi: – Tu hai il coraggio di dire questo a tuo padre? Sei uno stronzo che non capisce niente. – Si alzò, gli occhi rossi e gonfi, varcò la porta e scomparve.
Mia madre si affacciò alla scala per essere sicura che se ne fosse andato, si girò verso di me e scoppiò in un pianto nervoso irrefrenabile, che aveva poco di liberatorio.
– Che fai ancora qui? Vai a letto.-
Mi sentii un vigliacco e pensai:-… forse sarà un bene tutto questo, avrò forse anche dei vantaggi materiali, magari un giorno potrò confessare che in quello schifoso giorno avevo cominciato a fumare e mia madre forse sarà comprensiva e, come la signora olandese, mi offrirà delle sigarette.-
Di mattino fui svegliato dai rumori della colazione in cucina e vidi mia madre radiosa che serviva il caffè a mio padre, suo marito. Le sorelle giocavano sul balcone ed io capii che la mia giornata sarebbe stata complicata, dolorosa e che mi avrebbe procurato comunque guai e sensi di colpa. Entrai in cucina, mi fissarono tutti e due e mia madre sorridendo disse:- Papà ha deciso di restare, non può rimanere senza di me e i suoi figli, ha capito quello che è giusto. Vieni che facciamo colazione.- Mi sedetti, lui sorrise nervoso senza guardarmi negli occhi, e lei, mia madre, si girò di scatto verso di me e mi fulminò: – E tu… che volevi cacciare tuo padre per fare i tuoi porci comodi signorino, ma stavolta ti è andata male e farai bene a rigare dritto, perché ormai ti ho sgamato.- Presi il caffè a testa bassa, più in fretta possibile e scappai al pontile, ma a quell’ora c’è solo qualche pescatore: ero solo.
Dopo alcuni giorni arrivò il fratello di mio padre, il professore, confabularono sul balcone, lo zio gli diede un plico, salutò frettolosamente noi figli, salutò freddamente, molto freddamente mia madre e con aria di sconsolato rimprovero suo fratello, mio padre.
Gli incontri per sentire i Doors e i Led Zeppelin a casa dell’olandese erano diventati un’abitudine quotidiana, ma quel pomeriggio non ci andai, dovetti stare con mio padre, era molto agitato, il plico conteneva una convocazione in Questura per il giorno dopo e lui era spaventato. Mia madre pretese che stessi con lui e che il giorno dopo lo accompagnassi perché non facesse il viaggio da solo in quelle condizioni di nervosismo. Tutto sommato mi faceva comodo, mentre lui era in Questura potevo andare in libreria e all’edicola a comprare Lotta Continua che a Idro non arrivava. Il viaggio fu silenzioso. Mio padre guidava con lo sguardo fisso e perso davanti a sé, senza guardarmi in silenzio, quando si accorse che lo stavo osservando si infilò gli occhiali da sole e accelerò. Arrivati in Questura mi chiese di rimanere in macchina e di non andare nemmeno in edicola. Attesi più di un’ora e quando uscì ripartimmo a tutta velocità per Idro. Era allucinato, livido, non parlava, gli chiesi di fermarci a prendere il giornale, ma non rispose e si continuò a guidare come un pazzo. Prima di Idro c’è una località con un nome che mi ha sempre colpito: Ponte Re. Ecco proprio al cartello Ponte Re la strada fa una curva secca, a novanta gradi, s’infila nel ponte che attraversa il Chiese. Ebbene, mentre ci avvicinavamo ad alta velocità alla curva, osservavo mio padre e capii che non stava guardando la strada, era totalmente assente e non avrebbe frenato, non avrebbe fatto la curva e ci saremmo schiantati contro le rocce del greto del fiume. Lo guardavo e nulla faceva trasparire un briciolo di consapevolezza. Cosa aveva in mente? La curva era ormai vicina, puntai i piedi, mi aggrappai alla maniglia della portiera e urlai: – Papà la curva!- si scosse dal suo torpore, per fortuna guidava da dio, frenò, scalò le marce, il motore s’imballò, lo stridere delle gomme bloccate divenne assordante, ma la curva era ormai troppo vicina, impossibile percorrerla. Con sangue freddo e mia meraviglia, non fece la curva, ma riuscì ad imboccare il viottolo di campagna davanti a noi, ad evitare le rocce del greto e in una nuvola di polvere e un gran fragore la macchina si fermò. Eravamo in un prato, sul limitare del fiume, il cielo terso e le nuvole bianche e due mucche pascolavano davanti a noi, mentre un contadino ci guardava toccandosi ripetutamente la tempia con l’indice a significare:- Siete matti!- Mio padre impassibile si girò verso di me come non fosse successo nulla:
Grazie, non avevo visto la curva. Ti sei spaventato?- Feci di no col capo e tornammo a casa, era ormai la fine di Settembre. Mia madre, alcuni mesi dopo, mi confidò che era stato convocato in Questura perché un suo caro amico aveva fatto un esposto contro di lui, per avergli molestato la figlia diciottenne. Ma allora la maggiore età era ad anni ventuno.
Il primo di Ottobre, eravamo da poco tornati in città, il padre di mio padre, mio nonno, era venuto a trovarci. Stavamo pranzando ed ecco che scoppia una nuova violentissima lite che durò tutto il pomeriggio e alla fine, ormai a sera, papà uscì da casa sbattendo ancora una volta la porta, per andare a schiantarsi a tutta velocità contro il pilone di sostegno di un sottopassaggio ferroviario e morendo sul colpo.
La salma fu composta all’obitorio dell’ospedale, in un piccolo locale con una finestra che dava nel giardino interno al pianterreno. Parenti e amici, silenti e con aria di circostanza, stavano ammassati alle pareti dell’obitorio. Faceva caldo, aprii un po’ la finestra della camera ardente. Alcuni andavano fuori a fumare ed io li seguivo per chiedere una sigaretta. Mia madre piangeva disperata tenendosi alla bara. Ogni tanto alzava il capo e guardava fuori dalla finestra verso il giardino. Vidi un’ombra passare ripetutamente davanti alla finestra, esitante. Poi, come sorpresa del suo coraggio inaspettato, si affacciò per guardare dentro. Era una donna giovane, molto giovane, con gli occhi gonfi di pianto, le labbra tremanti. Appoggiò la mano allo stipite della finestra e si sporse verso la bara, sgranando gli occhi e singhiozzando pianissimo. Mia madre non se n’era neppure accorta, era a capo chino su mio padre, dai suoi occhi cadevano lacrime sul raso del sudario, mentre lo scrutava senza sosta. Le vedevo tutte e due, mentre piangevano, vedove dello stesso uomo, ma con un dolore così diverso, per quanto profondo e sconfinato, ed ero incantato da quella diversità così forte e così complementare, ma riconoscevo uguali diritti a tutti e due quei dolori disperati. Le guardavo in silenzio, stregato da quello strazio così intenso, come se tutto tutti fossero svaniti e dal fumoso nulla emergessero solo loro: mia madre, la ragazza, la bara con dentro mio padre. Amore, dolore, rabbia, rancore, impotenza, si mescolavano nei pianti di quelle due donne in un unica vasta lacrima. Guardai ancora una volta il volto di mio padre, mi sembrava sereno, imperturbabile, persino bello, e il pianto disperato di quelle due donne era per lui, solo per lui. Rimasi zitto, quasi senza respirare per continuare a guardarle senza che nessuno se ne accorgesse, ma tra i parenti si levò un lieve brusio e via via si fece più intenso:- Chi è quella lì? Sarà una di quelle che si faceva, una puttana. Come osa venire qui è roba da matti.-
Un cugino della mia stessa età, con una smorfia maligna e voce stridula urlò:- Zia zia, c’è quella di Fornaci alla finestra!-
Mia madre sollevò il capo dalla bara e urlò:- Nooo! anche qui mi tormenti, puttana rovinafamiglie, sei contenta adesso che è morto?-
Si scagliò verso la finestra, la ragazza terrorizzata scappò inforcando la sua bicicletta. Tutti inveendo si precipitarono fuori per vedere chi fosse quella donna e la insultarono e mio cugino la rincorse, raccolse un sasso e glielo tirò, colpendo però solo il parafango della bicicletta, urlando:- Troia! Puttana! Vacca!-
La ragazza accelerò la pedalata e si girò indietro per guardarci solo quando fu lontana, ma senza rallentare.
Le donne si strinsero attorno a mia madre, la fecero sedere, la consolarono. Mi sentii estraneo all’agitazione generale, al clamore di quell’episodio per tutti scandaloso, ma rimasi in disparte a cercare di misurare l’amarezza e la desolazione che mi assaliva, e mentre tutti rientravano nella camera ardente scuotendo la testa sconcertati, vedevo la ragazza in bicicletta sempre più lontana. Avrei voluto conoscere quella ragazza, capire cosa l’aveva affascinata di mio padre. Mi fece tenerezza.
Comunque di una cosa ero certo: mio cugino era proprio uno stronzo ed ero sicuro che non sarebbe mai migliorato.
Degli amici di quella vacanza non seppi più nulla, ma la figlia del barista mi scrisse una lettera molto commovente per la morte di papà. Le risposi, convinto che mi avrebbe dato il suo amore, ma lei si sottrasse, non rispose più e tornò nel nulla. Dopo qualche giorno mi ritirai da scuola e mi presentai in fonderia a fare l’operaio per mantenere la famiglia di cui ero diventato, mio malgrado, il capo.
E ho continuato a fumare.