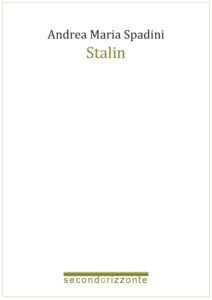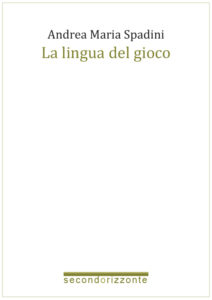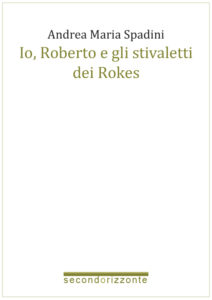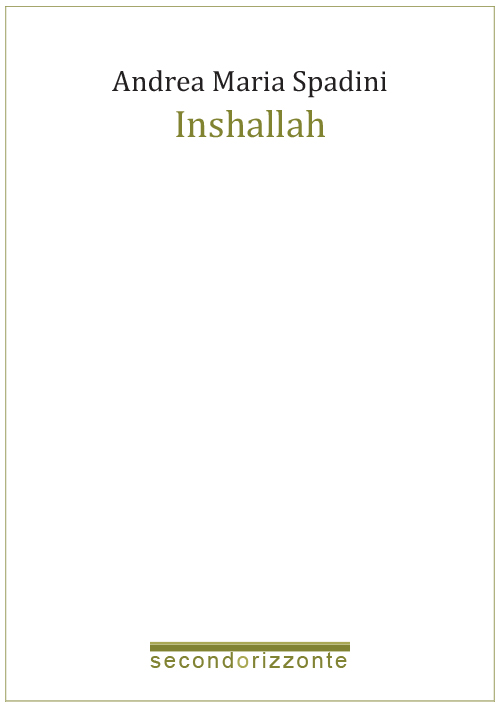
“Cosa ti porto da bere, cecchino?” gli aveva chiesto l’uomo dietro il bancone, con un cenno di saluto.
“Dammi una birra. Ghiacciata, però, non come il piscio che mi hai rifilato l’ultima volta. Una birra ghiacciata. E’ forse una richiesta troppo complicata per uno che una volta si vantava di essere il miglior barman della città?”
“Oggi dev’essere la tua giornata fortunata. Abbiamo avuto solo un paio di interruzioni nella fornitura elettrica e da qualche ora il frigo ronza che è un piacere, sembra un gatto che fa le fusa…”.
“Allora che aspetti, vecchio chiacchierone? Portami quella stramaledetta birra prima che io muoia di sete.”.
Si era accasciato sull’unico sgabello libero, lo sguardo come al solito rivolto verso il grande specchio che, incorniciato di legno dorato, correva alle spalle del bancone per la sua intera lunghezza. La sua innegabile imponenza riportava alla memoria la passata grandezza di quel luogo. Malgrado i bombardamenti che si susseguivano ad ogni ora del giorno e della notte e che avevano ridotto la città a un cumulo di macerie, lo specchio si era mantenuto miracolosamente intatto. I calcinacci, i vetri rotti e i muri traballanti che lo attorniavano accentuavano la straordinarietà della sua condizione. Grazie a questa apparente invulnerabilità, il grande specchio dorato, con la sua altera indifferenza, si era trasformato in uno dei più popolari emblemi della resistenza cittadina.
Prima della guerra civile quello era il bar di un hotel di lusso. L’albergo ora ospitava il comando dell’armata di straccioni che, contro tutte le previsioni, ancora difendeva ostinatamente la città dalla furibonda offensiva dell’esercito sovranista. Al bar si dava convegno ogni sera una moltitudine di combattenti sfiniti, oltre che il variegato mondo di faccendieri e trafficanti che ruotava loro intorno. Al piano inferiore, nelle grandi cantine, il quartier generale: ingresso strettamente sorvegliato, accesso consentito solo ai comandanti eletti dalle compagnie.
Lui non ci aveva mai messo piede: poco gli importava di ciò che si decideva là sotto. Condivideva con altri miliziani una delle stanze dei piani superiori. Ci aveva traslocato il giorno in cui un violento bombardamento gli aveva raso al suolo la casa, compagna e figlio di tre anni inclusi.
Era stato allora che aveva chiesto di essere trasferito in un’unità di tiratori scelti. Aveva sempre avuto una buona mira, anche nel mondo di prima. La prova a cui lo avevano sottoposto prima di accogliere la sua domanda consisteva nello sparare a un bersaglio mobile da distanze e angolature diverse. Erano bastati tre colpi. Quel giorno stesso aveva ricevuto il suo primo incarico.
Un mondo molto particolare, quello dei cecchini. Anche la guerra che combattevano era diversa da quella degli altri: prima le lunghe, estenuanti attese con l’occhio fisso nel cannocchiale del fucile di precisione, così immobili nel proprio nascondiglio da pisciarsi nei pantaloni se necessario, poi le fughe rapide e silenziose prima che il nemico potesse scoprire l’origine dei colpi. A separare le une dalle altre, il rumore degli spari e la morte dell’obiettivo assegnato, se eri stato bravo. Una guerra per solitari. Gli altri combattenti, un po’ per invidia, un po’ per ammirazione, li chiamavano i liberi professionisti della milizia: senza orari, senza ordini urlati nelle orecchie, senza turni di guardia o di corvée. Solo un incarico. Assoluta autonomia su come e dove assolverlo. Una definizione, tutto sommato, azzeccata.
Non provava alcun piacere nell’infliggere la morte, ma non sentiva nessuna pietà per i sovranisti che avevano la sfortuna di incrociare la traiettoria di qualche suo proiettile. Sapeva di cosa erano capaci quando catturavano qualcuno dei suoi. Aveva sentito l’odio fanatico nelle loro voci e visto la ferocia nei loro sguardi e nelle loro azioni, il sadico piacere che provavano mentre torturavano e violentavano le prigioniere delle unità femminili. No, nessuna pietà per quegli animali quando li uccideva. Erano state le loro fottute bombe a strappargli via la vita…
“Ehi, guarda chi si rivede, il mio viso pallido preferito. Dove ti eri cacciato?” gli aveva urlato un uomo grande quanto un armadio a quattro ante, interrompendo così bruscamente il filo ingarbugliato dei suoi pensieri.
“Un po’ qua un po’ là, sai com’è…” gli aveva risposto evasivo, mentre cercava di riprendersi dalla violenta manata che l’amico gli aveva rifilato sulla spalla, facendogli versare buona parte della birra sul bancone. Dopo averlo salutato con un abbraccio, gli aveva quindi proposto con espressione ironica: “Bevi qualcosa con me, Mamadou. Che ne dici di una birretta analcolica? O il solito tè alla menta, se preferisci.”.
“Arriverà mai il giorno in cui la smetterai di prenderti gioco di questo povero, piccolo, innocente musulmano?” gli aveva risposto Mamadou, con un sorriso di un candore abbacinante stampato sul viso dalla pelle scura, mentre con una spallata si ricavava un comodo spazio proprio al suo fianco.
“Inshallah, vecchio mio” aveva replicato lui beffardo, mentre sollevava il bicchiere in un accenno di brindisi. Poi, con espressione fattasi più seria, gli aveva chiesto: “Che novità dal fronte?”.
Si conoscevano dai tempi dell’insurrezione del Carmine, quando Mamadou lo aveva letteralmente strappato dalle mani dei paramilitari che lo stavano per catturare. Ora faceva parte di un’unità di ricognitori. Agivano sul terreno, spesso al di là delle linee nemiche, per acquisire informazioni sui loro spostamenti. Nonostante la mole, aveva una capacità mimetica fuori dal comune, che gli aveva consentito fino ad allora di sfuggire alle pattuglie e ai droni sovranisti.
“Bah, che ti devo dire, è un periodo di calma piatta, il fronte non si muove da settimane. Io e i miei ragazzi non siamo riusciti a scoprire nessun movimento anomalo tra le file dei porci. Questa tranquillità è strana e preoccupante. Non sarei autorizzato a dirtelo, ma forse è per questo che ci hanno ordinato di uscire domani in ricognizione oltre la ferrovia. Dovremo attraversare un terreno che offre pochi nascondigli, difficile passare inosservati.”
“Segreto per segreto, sarà la mia unità a fornirvi copertura, ce lo hanno comunicato poco fa. E’ una delle zone meglio controllate dalle pattuglie dei porci, come li chiami tu.”. Conosceva quella spianata e sapeva che sarebbe stato impossibile proteggere il ripiegamento dei ricognitori nel caso fossero stati scoperti. Anche Mamadou lo sapeva.
“Già, chissà che pensano di scoprire laggiù i nostri capi… Comunque mi conforta sapere che ci sarai tu a tenermi d’occhio. Sai cosa fare nel caso la faccenda prenda una brutta piega.” Dopo un lungo momento di silenzio, aveva aggiunto: “Dai viso pallido, ora beviamoci su, sarà ciò che Dio vorrà.”.
Alle loro spalle, all’improvviso, una voce femminile: “Ma cos’è quest’aria da funerale? Con tutto questo parlare di Dio, poi… Non sarai per caso diventato imam a nostra insaputa, Mamadou?”.
Non si erano accorti dell’arrivo di Rasheeda e Viktor. Li conosceva da prima dello scoppio della guerra civile. Una coppia inseparabile. Nel mondo di prima lei era stata la migliore amica della sua compagna. Ora era la miglior tiratrice, oltre che la comandante, della sua unità.
“Che ne dite di una partita a carte? Fabio e il Tedesco stanno tenendo occupato un tavolo nella sala grande, ma non resisteranno a lungo. Dai, diamoci una mossa, forza” aveva concluso mentre già se li stava trascinando dietro, senza attendere la loro risposta.
Era ancora notte quando aveva scelto la sua postazione. Si era sistemato sul tetto di un palazzo di tre piani relativamente intatto, nei pressi di quello che una volta era il cavalcavia Kennedy. Rasheeda si era piazzata all’estremità opposta della terrazza. Da lì la visuale sulla terra di nessuno che li separava dalle linee sovraniste era perfetta. Malgrado il buio, riusciva a indovinare i resti del tribunale alla sua sinistra. Proprio di fronte a lui, oltre la distesa desolata del parco Tarello, si stagliava il grottesco ammasso di vetro fuso e metallo contorto in cui si era trasformato il Crystal Palace.
Anche Mamadou e i suoi compagni si erano mossi prima del sorgere del sole, così silenziosi e circospetti che a stento riusciva a distinguerli. Arrivati a metà della spianata, dalle linee nemiche si era scatenato un inferno di fuoco. I sovranisti li stavano aspettando, forse imbeccati da una soffiata.
“Dammi qualcosa di forte, muoviti!” aveva ringhiato al vecchio dietro il bancone. Senza aprire bocca, quello gli aveva riempito fino all’orlo il bicchiere di un torcibudella vagamente simile alla grappa.
“Lascia qui la bottiglia e vattene!” aveva aggiunto afferrandogli il polso che la sorreggeva, con un tono rabbioso che non ammetteva repliche. Intanto, mentre il suo sguardo fissava lo specchio senza vederlo, la sua mente ripercorreva tumultuosamente gli eventi delle ore precedenti.
Mamadou ferito e il cenno d’intesa che gli aveva rivolto prima di essere sopraffatto… quel lungo momento di indecisione con il dito paralizzato sul grilletto… il dolore straziante che aveva provato quando si era infine costretto a premerlo per sparare quell’ultimo colpo… lo schiocco del proiettile arrivato a destinazione che, come un eco infinita, ancora gli rimbombava nelle orecchie…
No, non avrebbe mai potuto dimenticare, no. Un nuovo conto da far pagare a caro prezzo a quei maiali…
Si sentiva quasi soffocare dall’ondata di odio che gli era montata dentro, incontenibile. Quanto rancore aveva accumulato in quei… mesi? anni? Non riusciva più nemmeno a rammentare quando quella carneficina era iniziata. Il ricordo era svanito dalla memoria, trascinato via dalla stessa mano pietosa che aveva cancellato quelli del mondo di prima, troppo dolorosi per consentirseli. Ma sarebbe mai finita? La verità era che aveva smesso di sperarci. Una volta sì, quando lei e il bambino erano ancora al suo fianco. Ora no, non più. Sentiva passato, presente e futuro come intrappolati tra le macerie della città assediata.
D’improvviso gli erano tornate in mente le ultime parole che Mamadou gli aveva rivolto la sera precedente. Erano proprio lì, appoggiati al bancone del bar: “Prima o poi questa guerra finirà, amico mio e, stanne pur certo, l’avremo vinta noi. I loro muri e le loro paure ci potranno fermare ancora per un po’, forse, ma non per sempre. Guarda bene, viso pallido, perché quella che ora vedi riflessa di fronte a te è l’immagine del mondo che verrà, ricordatelo…”.
“Inshallah, Mamadou, inshallah” si era sentito rispondere, mentre scagliava la bottiglia ormai vuota contro lo specchio.
Rasheeda era arrivata al bar con il capo chino e il cuore pesante: mandare una delle migliori unità della milizia allo sbaraglio su un terreno del genere… A quale sciagurato poteva essere venuta in mente un’idea così assurda?
Immersa nei suoi pensieri, non si era accorta del cecchino, seduto all’altro capo del bancone. Poi il suono familiare della voce, anzi del ringhio con cui ordinava da bere. Sì, sarebbe stata una di quelle serate, quelle che aveva sperato di non dover vedere più. Lo sguardo torvo e la rapidità con cui tracannava quel liquore puzzolente erano segnali inequivocabili: la tempesta stava arrivando. Del resto, i guai non erano certo merce rara in quel periodo e il cecchino sembrava avere un gran desiderio di scovarli…
Lo avevo conosciuto ai tempi dell’università. Un biondino piccolo e secco, di poche parole, che se ne andava in giro con Viktor e gli altri come se fossero stati i padroni della facoltà. In verità era un ragazzo timido, sensibile e intelligente. Di lui colpiva soprattutto la capacità di offrire la propria attenzione agli altri, di coglierne e comprenderne le emozioni e i sentimenti. Certo, quella sua passione per la caccia proprio non la sopportavo, per quanto fosse abile a giustificarla. Un tipo interessante, comunque. Ero sicura che sarebbe piaciuto anche a Marta, la mia più cara amica dai tempi delle elementari. Il nostro rapporto si era mantenuto solido anche quando Marta aveva deciso di continuare l’università in un’altra città. Certo, mi mancava molto… Il giorno del suo rientro per la pausa estiva ero elettrizzata. Erano almeno tre mesi che non ci vedevamo e avevo una gran voglia di trascorrere un po’ di tempo con lei a chiacchierare. Con tutto quello che avevo da raccontarle… Ci eravamo date appuntamento nel tardo pomeriggio in piazza Loggia, al nostro solito bar. Ero così impaziente di vederla che ero arrivata con dieci minuti di anticipo. Ricordo bene l’emozione provata quando avevo riconosciuto la sua inconfondibile matassa di capelli neri spuntare da via S. Faustino. I suoi occhi azzurri scintillavano di gioia quando ci eravamo finalmente abbracciate. Poi, appena sedute, ci eravamo subito lanciate in una fitta chiacchierata. Perse nel nostro mondo, non avevamo notato l’arrivo di Viktor e dell’amico che, nel frattempo, si erano accomodati al nostro tavolo. Nonostante il nostro inziale disappunto, la serata aveva rapidamente preso una piega inattesa. La conversazione tra Marta e il nuovo venuto aveva subito ingranato benissimo, come se si conoscessero da sempre. Ma era soprattutto lo sguardo a parlare per lei, pendeva letteralmente dalle sue labbra. E che dire di lui… Non gli avevo mai sentito pronunciare così tante parole in fila. Bè, era cominciata così tra quei due.
Quando la bottiglia era partita in direzione dello specchio, Rasheeda aveva capito di dover agire in fretta per tentare di metterlo in salvo. Approfittò dello sconcerto e della confusione in cui era piombata l’intera sala per tentare di raggiungerlo e trascinarlo via prima che lo stupore incredulo dei presenti si tramutasse in furia cieca. Per tutti quei combattenti stremati il grande specchio dorato era il simbolo stesso della resistenza. Non sarebbero stati teneri con lui.
Quell’anno l’avanzata elettorale del Partito Sovranista non era arrivata inattesa, ma chi avrebbe previsto che i suoi voti sarebbero addirittura raddoppiati, facendolo diventare il partito di maggioranza? Restava però una formazione estremista e politicamente isolata, e nessuno davvero credeva che potesse trovare alleati per costituire un governo. Quando il Partito Populista aveva accettato di sostenerli in cambio di qualche vaga promessa, era scattato il primo campanello d’allarme. Seduti ai tavolini dei salotti e dei bar, tra un caffè e un aperitivo, si discuteva e si delineavano scenari alternativi. “Vedrete che il Presidente costringerà le altre forze politiche a coalizzarsi in un governo anti sovranista”, oppure “No, il Presidente scioglierà le Camere e convocherà nuove elezioni”. Quando il leader del Partito Sovranista aveva assunto la carica di primo ministro, la preoccupazione si era accentuata, anche se pochi dubitavano della tenuta dell’assetto democratico del paese. “In fondo facciamo parte dell’Unione Europea, le istituzioni comunitarie e gli altri paesi aderenti non consentiranno ai sovranisti di fare tutto ciò che vogliono”, oppure “La nostra economia è ormai ancorata a quella comunitaria. Con la moneta comune non si scherza, dovranno farsene presto una ragione”, si sosteneva con veemente determinazione seduti ai soliti tavolini. Ricordavo bene com’era andata, poi: il colpo di stato, la proclamazione dello stato d’emergenza, il ripristino della moneta nazionale. Quando erano arrivate le leggi razziali e le prime deportazioni, i quartieri delle grandi città abitati dai migranti erano stati i primi ad insorgere. Così era iniziata la guerra civile.
Difficile muoversi in quella sala troppo affollata che cominciava ad agitarsi sempre più violentemente. Prima che Rasheeda potesse raggiungerlo, il cecchino era scomparso, sepolto sotto un mucchio di combattenti inferociti. D’improvviso Lupo, uno dei comandanti più amati e rispettati dell’intera milizia, aveva esploso una raffica di mitra verso il soffitto e, nel disorientamento generale, con l’aiuto dei suoi uomini aveva posto al sicuro entrambi, dietro la massiccia porta del comando generale.
Era stato dopo la ferita rimediata in un conflitto a fuoco che Marta mi aveva fatto quella richiesta. Voleva a tutti i costi che le promettessi di prendermi cura del figlio e del compagno, nel caso le fosse successo qualcosa. Avevo acconsentito subito, senza discussioni che sapevo inutili, nella speranza che quella circostanza non si dovesse mai verificare.
Pochi mesi dopo Marta e il bambino erano scomparsi sotto quel maledetto bombardamento. Ero rimasta stordita dal dolore per giorni. Ne ero riemersa solo in occasione del funerale. Ancora oggi provo vergogna per non aver capito, fino a quel momento, in quale abisso di disperazione lui fosse sprofondato. Era arrivato in ritardo, sporco, trasandato ed evidentemente ubriaco. Chiuso in un ostinato mutismo per l’intera cerimonia, se n’era poi andato senza nemmeno un cenno di saluto. Insieme a Viktor e Mamadou avevo passato le ore successive a cercarlo. Lo avevamo ritrovato la mattina dopo in una bettola, talmente sbronzo da sembrare morto.
Anche nei giorni seguenti non ci era certo andato leggero, con sbornie e risse che si susseguivano senza soluzione di continuità. Poi, all’improvviso, di lui non avevamo saputo più nulla: sembrava scomparso, come evaporato.
Per questo ero rimasta sorpresa quando mi avevano riferito del suo trasferimento nelle unità di tiratori scelti, dove io già militavo da tempo. Mi era sembrata una buona notizia: di certo aveva almeno smesso di bere.
Anche all’interno della mia unità, a cui era stato assegnato, era rimasto un solitario. Preferiva gli incarichi da realizzare in autonomia ed era preciso e meticoloso nello svolgere le proprie missioni, che preparava con cura maniacale in ogni singolo dettaglio. Con la fredda cortesia che riservava agli altri membri della squadra, limitava i rapporti allo stretto indispensabile. Grazie alla sua professionalità e all’elevatissima percentuale di obiettivi raggiunti, aveva comunque guadagnato la stima e il rispetto di tutti i nostri compagni. Anche con me si manteneva distante e impersonale, sempre però con inappuntabile gentilezza. Stentavo ormai a riconoscere in quell’uomo così distaccato il ragazzo di una volta. Sembrava aver eretto tra sé e il resto del mondo, me compresa, un muro invalicabile.
L’eco del catenaccio sprangato alle loro spalle non si era ancora spento quando Lupo, agguantato il cecchino per il bavero del giubbotto, gli aveva urlato con quanto fiato aveva in gola: “Cosa ti dice la testa, razza di idiota! Volevi farti ammazzare, per caso? Se è questo quello che vuoi, non hai che l’imbarazzo della scelta. Ci sono centinaia di sovranisti là fuori che aspettano solo l’occasione di sventolare il tuo scalpo.”. Quindi, dopo averlo scaraventato lontano, senza attendere risposta si era rivolto a Rasheeda: “Levami questo imbecille dagli occhi alla svelta, prima che cambi idea e lo deferisca alla corte marziale. Vedi di occupartene, perché la prossima volta giuro che lascio che lo facciano a brandelli. Sei o non sei la sua comandante?”. Poi, con tono più pacato, aveva aggiunto: “Portalo alla stanza del cambio turno, laggiù in fondo. Ci troverete un paio di brandine che potete usare. Vi conviene fermarvi qui per un paio d’ore, in attesa che la situazione si tranquillizzi. Intanto cerca di rimetterlo in sesto meglio che puoi. Da tanto non lo vedevo conciato così…”.
Era già addormentato quando la sua testa aveva toccato il cuscino della branda. Lei allora si era versata un caffè riscaldato e aveva lasciato la mente libera di tornare alle ore precedenti.
Un’operazione pensata male e finita peggio, ecco cos’era stata… Quando era scattata l’imboscata dei sovranisti era stato subito chiaro quale sarebbe stato l’epilogo di quella faccenda. Eppure Mamadou e la sua squadra si erano battuti come leoni e le unità di copertura avevano sparato fino ad arroventare le canne dei propri fucili. Ad uno ad uno i ricognitori erano caduti sotto i colpi nemici, ma da come si muovevano i sovranisti, incuranti delle molte perdite che stavano subendo, era apparso evidente che il loro obiettivo era quello di catturare Mamadou vivo. Sapevo del patto esistente tra lui e il cecchino: avevo ascoltato i loro discorsi della sera precedente al bancone del bar. E aveva visto il cenno che Mamadou, ormai circondato, gli aveva rivolto. Cosa aspettava a sparare? Poi avevo visto la canna del suo fucile tremare. Era sdraiato, l’occhio fisso nel mirino telescopico, in perfetta posizione di tiro, ma la canna del suo fucile continuava a tremare. Allora gli avevo gridato: “Spara, maledizione! Spara!”. Nessuna reazione. Intanto la canna del suo fucile non la smetteva di tremare. Lo lasciai perdere e mi volsi nuovamente verso la sagoma di Mamadou. Dopo averla messa a fuoco nel cannocchiale di precisione, fissai la testa nel centro del mirino e, con un groppo alla gola, sparai. Nello stesso istante anche il cecchino si era finalmente deciso a fare fuoco. Avevo visto il suo proiettile sollevare uno sbuffo di polvere a una spanna dal capo di Mamadou. Non penso che lui si sia accorto dell’errore e nemmeno del secondo colpo, quello sparato da me. Meglio così, sarei stata l’unica a saperlo.
Superato lo stupore per l’intervento di Lupo e dei suoi uomini, la rabbia della folla assiepata nel bar si era indirizzata verso l’ingresso del quartier generale. D’improvviso, un grido: “Lo specchio è salvo! Fermatevi ora, mandria di coglioni!”. Il vecchio barman era in piedi sul bancone e si sorreggeva il polso destro, malamente piegato ad angolo retto. Alle sue spalle, il grande specchio dorato, intatto, li guardava con la solita altera indifferenza. Ai suoi piedi, dietro il bancone, una distesa di bicchieri infranti. I miliziani, ammutoliti, faticarono a riconoscersi in quei visi lividi e distorti dalla collera che il riflesso, impietosamente, restituiva. Poi, finalmente, un fragoroso sospiro di sollievo.
Il miracolo dello specchio stava già correndo di bocca in bocca, così come l’ironica sorte di uno dei migliori cecchini della resistenza, che non era riuscito a centrare quella superficie enorme a meno di tre metri di distanza…
Si era finalmente svegliato, forse per le urla di giubilo che provenivano dalla sala del bar, lì disopra. Mi aveva guardata come se non mi vedesse da molto tempo, negli occhi un lampo di luce che non credevo avrei mai più visto risplendere. Poi era scoppiato a piangere.