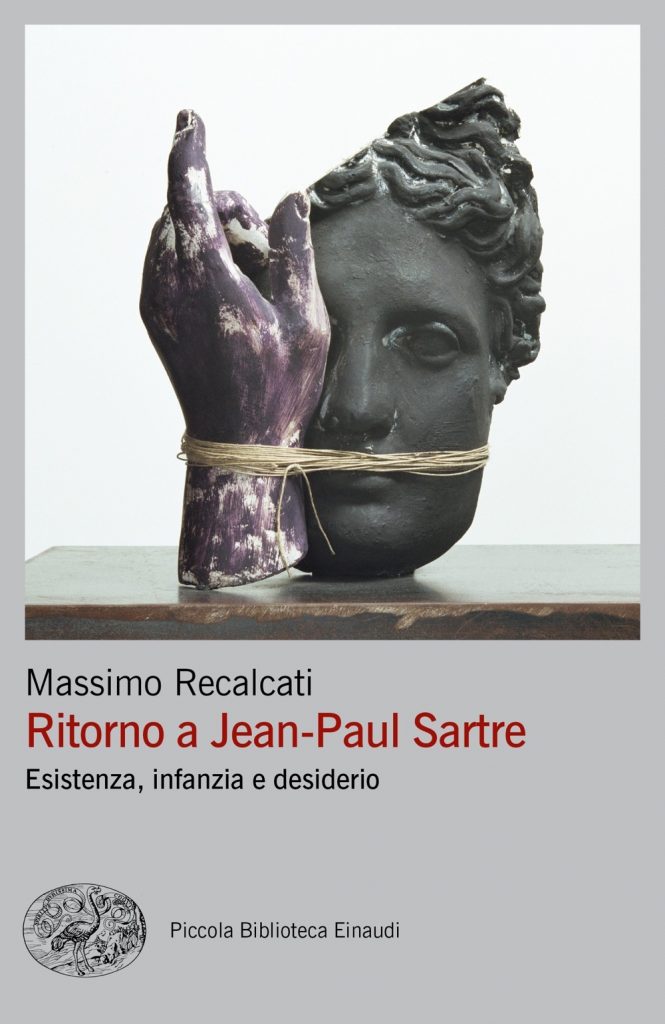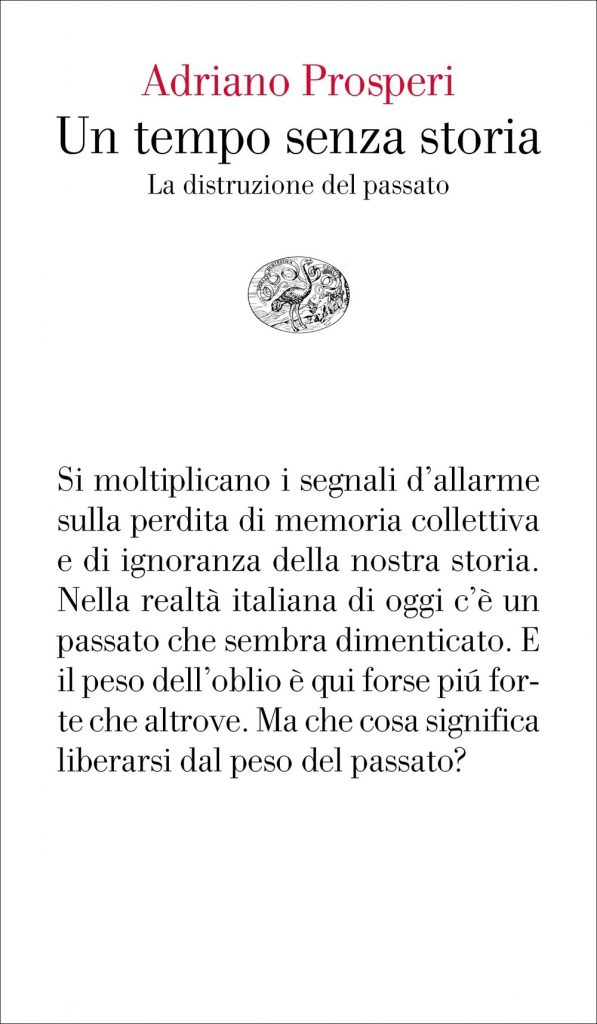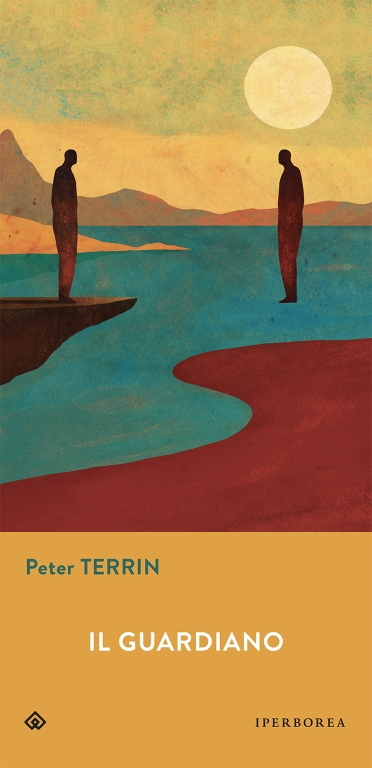Marco Balzano, Quando tornerò, Einaudi 2021 (pp. 202, euro 18,50)
Il titolo sembra richiamare quello del romanzo precedente, Resto qui*, ma non è così. La vicenda è tutt’altra, ma l’andare e lo stare, il partire e il rimanere tornano a proporsi come alternativa che genera e sta al centro della narrazione. Là si trattava della divisione degli abitanti del Sud Tirolo sotto il fascismo fra “optanti” e “restanti”, fra chi si sentiva di accettare di trasferirsi in Germania con la speranza di farsi una nuova vita e chi invece decideva di restare perché il posto in cui era nato aveva un significato imperdibile, perché – nel caso del protagonista – le strade e le montagne gli appartenevano come lui apparteneva ad esse.
Ma anche in Il figlio del figlio, di due anni prima, il perno della narrazione era un viaggio, il viaggio di ritorno al paese del sud di un emigrato, con il figlio e il nipote.
In Quando tornerò l’allontanamento è quello di una donna rumena che lascia marito e due figli per venire in Italia, a Milano, a fare la badante, unico mezzo per racimolare i soldi necessari alla famiglia, della quale il coniuge, beone e inaffidabile come tanti maschi di quelle parti – stando al racconto che probabilmente molti di noi hanno ascoltato da badanti e colf slave – non si sa occupare.
Continua a leggere Migrante donna