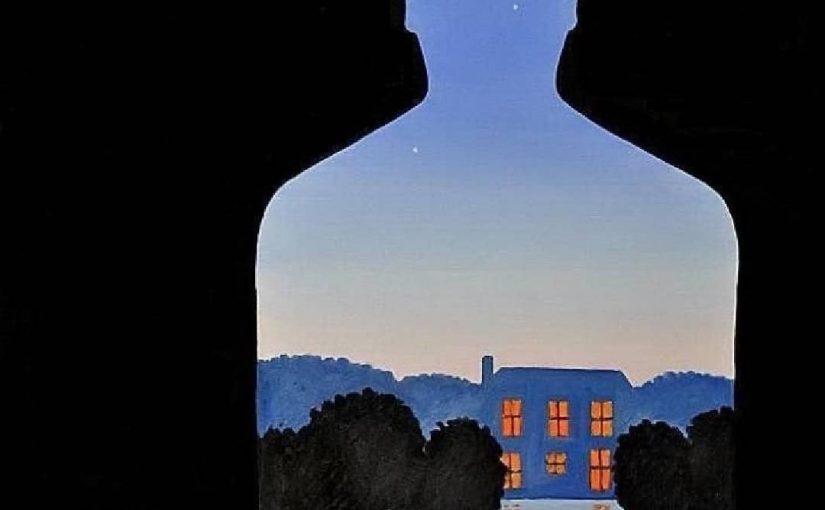“Le ferite dell’esistenza sono inguaribili, e ne scrivi e riscrivi, sperando di essere capace presto o tardi di costruire una storia che ne dia definitivamente conto”. (Elena Ferrante)
Carlo Simoni
Sulle tracce di Simenon

Jean-Luc Bannalec, Intrigo Bretone. Omicidio a Pont-Aven, Superbeat 2020 (pp. 233, euro 18)
“Spostati, Maigret. È arrivato il commissario Dupin”: esagera la fascetta di cui il libro si fregia, ma un che di Simenon lo ritroviamo in questo romanzo, non fosse che per l’atmosfera tutta francese che lo pervade. Dupin infatti, dalla sua Parigi, ha dovuto spostarsi in Bretagna, a Concarneau e, contro ogni sua previsione, se ne innamora, di un amore che dura anche dopo che ha risolto il caso: l’omicidio di un albergatore novantunenne seguito da quello dell’erede, nella vicina Pont-Aven. Un luogo leggendario, sede della mitica Scuola artistica dominata dalla figura di Gauguin, meta di pittori che cercavano “il primitivo, il semplice, l’incontaminato e lì trovavano il mondo rurale”, la tradizione: “In fin dei conti, la Bretagna – sostengono i suoi quattro milioni di orgogliosi abitanti – apparteneva alla Francia solo dal 1522, ‘da cinquecento ridicoli anni’.”
Paesaggio e contesto culturale sono dunque assicurati ed è su questo sfondo – qualcosa di più di un sfondo, in vero – si muove il nostro commissario, che quell’ambiente assimila, sì, come un Maigret, che arriva a conclusioni decisive presentando un’attenzione ai dettagli che non saprebbe giustificare, e prende nota anche dei “rituali che la gente s’(inventa) per il corso della giornata” essendo che “in nient’altro – ne era convinto – si (rivela) più chiaramente l’essenza di una persona”. Un Maigret tuttavia che pur amando cibo e vini buoni si scorda a volta di mangiare e s’ingozza di caffè, un uomo nervoso, spigoloso e reticente con i suoi sottoposti, che reprime a fatica reazioni o addirittura espressioni offensive come quelle che a Parigi l’avevano messo in cattiva luce presso i superiori. Non è però un ruvido e trasgressivo Rocco Schiavone, tutt’altro: “gli mancavano quegli eccessi che sembravano essere un requisito, o quanto meno una costante, della sua categoria professionale: consumo di alcol o droga, nevrosi o depressione a livelli clinici, qualche eclatante passato criminale, corruzione di alto livello, o un paio di matrimoni drammaticamente falliti. Lui non vantava nulla di tutto ciò”. E con brevi digressioni come questa, l’autore ci dà la misura di quanto sia consapevole che nei polizieschi quel che si cerca, più dell’intreccio, è ormai una figura originale di investigatore. Quante siano le varianti ancora a disposizione è problema degli scrittori che si provano nel genere.

Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.
“Raccontare storie significa occuparsi del tempo, ed esperire la nostra vita come tempo ha a che vedere…”
“Raccontare storie significa occuparsi del tempo, ed esperire la nostra vita come tempo ha a che vedere col fatto che la nostra vita ha un termine, e che la vita dei nostri amici [e di quelli cui vogliamo bene] ne ha pure uno. L’angoscia di fronte a questo dover finire può naturalmente essere tenuta a bada (…). Ciò che però non scompare è la tristezza per questa finitudine. La tristezza non la si può vincere, può soltanto essere rifiutata o accettata. Il raccontare storie ha a che fare con il fatto di accettarla. La tendenza degli uomini alla tristezza li fa diventare narratori di storie”. (Peter Bichsel)
Il confuso desiderio di non sapere troppo
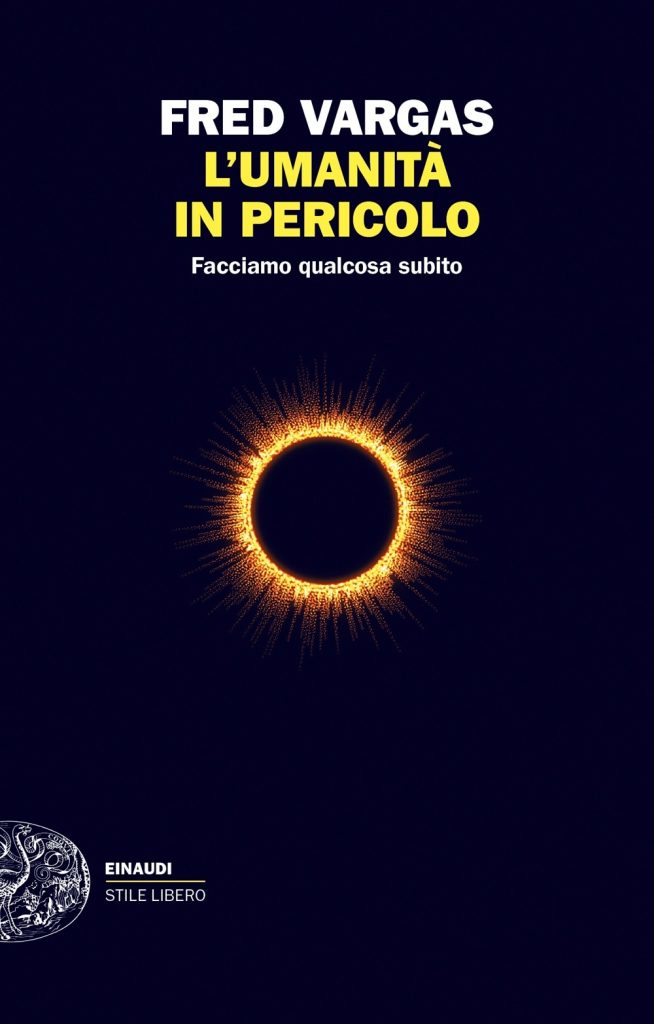
Fred Vargas, L’umanità in pericolo. Facciamo qualcosa subito, Einaudi 2020 (pp. 216, euro 17)
Se non “prima di cena” – come proponeva Safran Foer (Possiamo salvare il mondo, prima di cena. Perché il clima siamo noi, Guanda 2019, in queste note all’inizio dello scorso dicembre) – comunque “subito”. Perché, confessa l’autrice, anche se “ho il fondato sospetto che avreste preferito vedermi sfoderare un bel poliziesco di pura evasione (…) adesso no, non posso. Una specie di implacabile necessità mi incalza a scrivere freneticamente questo libro”, riprendendo un testo scritto nel 2008 che nel frattempo non ha smesso di essere letto: addirittura, alla Cop24, la Conferenza sul Clima del 2018. E, “visto come stanno andando le Cop” – vedi il fallimento della Cop25 a Madrid, nello scorso dicembre (e per il futuro, il futuro del dopo Covid c’è da sperare?) –, conviene rileggerlo anche noi quel testo, purtroppo attualissimo: “Madre Natura, stremata, contaminata, esangue, ci chiude i rubinetti. (…) Il suo ultimatum è chiaro e spietato: Salvatemi, oppure crepate insieme a me”. E così scopriamo che di problemi ambientali Vargas si preoccupa “da quando (aveva) vent’anni”. Lo stesso anno, il 1997, in cui diventa ricercatrice presso il Centro nazionale francese per le ricerche scientifiche, scrive il suo primo polar, come dicono i francesi (polar: policier + noir). E allora perché non scrivere un altro “agile libretto dello stesso genere”? Questo che leggiamo ora, appunto. Non semplicemente la riflessione di una scrittrice – che pure non guasterebbe: si veda Amitav Ghosh (La grande cecità. Il cambiamento climatico e l’impensabile, Neri Pozza 2017, in queste note il 17 settembre 2017) sul silenzio assordante della letteratura – e neanche “cazzate da militante esaltata”, ma i risultati di una indagine approfondita, condotta essenzialmente su dati e testi scientifici ricavati dal web. Il che non esclude prese di posizione esplicite e inequivocabili: i Soldi e la Crescita sono i due pilastri di un sistema fatto di multinazionali che comandano e politici che obbediscono. E della Gente naturalmente, di noi insomma, “massa anonima” richiesta di comprare e consumare mentre viene tenuta all’oscuro di quel che dovrebbe sapere. Certo, siamo a conoscenza del fatto che “la Terra sta male”, ma in modo tanto generico e vago da poter continuare a “vivere spensierati”, “come se alla fine tutto potesse sistemarsi”, senza contare il nostro “confuso desiderio di non sapere troppo”. È questo vuoto di sapere – di cui siamo dunque in parte responsabili –, questa sostanziale incoscienza che il libro vuole contrastare. Senza aggirare il senso di impotenza diffuso: “Mi direte: Ma a parte firmare petizioni, non si può fare niente!” Non è così: le azioni possibili, a portata di noi tutti sono l’altro versante del discorso. Ma “per agire dobbiamo sapere”. E allora via con i dati, ma sempre, programmaticamente, “senza abuso di termini tecnici” e con “un lessico colloquiale standard”.
Senonché i dati citati sono davvero una valanga, e non giova che il discorso non conosca pause e gerarchie, capitoli e paragrafi. Aiutano i corsivi che qua e là punteggiano il testo: “Chiedo scusa, sul serio, per questo lungo elenco. Che però ci permette di capire che lo sconvolgimento di tutti i nostri sistemi di produzione è inevitabile già nella prima parte del secolo!” Le soluzioni, dunque, non sembrano – almeno fino a questo punto – di quelle che ciascuno può tentare: è di riassetti e mutamenti tecnologici che si parla, anche se riserve sostanziali sulla “geo-ingegneria” sono ben evidenziate.
Ma ecco un rimedio, parziale certo ma efficace: usare il meno possibile l’auto (e l’aereo), in attesa di veicoli elettrici (ma se per fabbricarli si usa energia prodotta con fonti non rinnovabili il beneficio è relativo, senza contare il problema dello smaltimento del litio delle batterie). E via con informazioni e numeri e controindicazioni: è una scelta di cui l’autrice non sottovaluta i rischi: “Vi annoiate? È normale. (…) Ma non abbandonatemi proprio adesso…”. Gli ammiccamenti al lettore accompagnano la trattazione di ogni nuovo argomento con relative elencazioni (“Senza insistere troppo a lungo, altrimenti questo libro vi cadrà presto di mano…”), così come gli incoraggiamenti: “Aspettate, non lasciatevi abbattere [dai dati sulla deforestazione], noi possiamo fare qualcosa, e lo faremo”. Visto, per esempio, che “l’Europa è la regione del mondo che, con le sue importazioni, genera più deforestazione in altre aree del globo”, dopo l’olio di palma, mettiamo al bando anche la soia, “primo responsabile della nostra forest footprint”, non acquistiamo legnami tropicali o esotici, non usiamo biocarburanti (ricavati da vegetali la cui coltivazione danneggia l’ambiente di altre parti del mondo).
Ma soprattutto – e qui Vargas è d’accordo con Foer – dobbiamo mangiare meno carne, addirittura il 90% in meno, perché l’allevamento e l’agricoltura che lo consente sono “la prima causa di riscaldamento” e di distruzione di risorse, acqua in primo luogo. E dunque basta con la carne: “senza aspettare un’iniziativa delle autorità. E perché? Perché non ci sarà”, e allora non tanto a un libro come questo –ammette l’autrice – ma ai social occorre far ricorso per divulgare la notizia. Non tacendo gli effetti del consumo di carni (rosse soprattutto) sulla salute: “Ci hanno avvertiti, i ministri della Sanità? No, hanno lasciato che ci ingozzassimo di carni e salumi senza fornirci la minima informazione”. E il pesce, “un tempo considerato, con i suoi omega 3, il più sano degli alimenti”? Anche qui, la disinformazione: si acquista pesce senza essere a conoscenza dei metodi devastanti con cui li si pesca e dell’inquinamento da mercurio degli oceani, sicché “tocca ancora a noi arrangiarci, se vogliamo capire”. Né carne né pesce, dunque? Tutti vegetariani? “Sul fronte della frutta e della verdura – e del vino, ammonisce implacabile l’autrice – c’è poco da stare allegri”, visto l’uso dei pesticidi. E allora ecco le liste dei vegetali che conviene mangiare: “vi serviranno a scegliere meglio frutta e verdura”. Ma la via è un’altra: quella di rivolgersi esclusivamente a prodotti bio, di stagione, a chilometro zero, più cari, come si sa, ma “tocca ai governanti pensarci e sovvenzionarli” in modo da calmierarne i costi. Insomma, sul fronte dell’alimentazione, a conti fatti “noi, la Gente, abbiamo in mano una potentissima leva in grado di modificare le pratiche agricole” e “la presa di coscienza”, almeno su alcuni fronti come quello della proliferazione della plastica, “è in corso e azioni per il futuro sono già quasi operative”. La denuncia circostanziata si coniuga dunque a un moderato ottimismo e, fra una lista e l’altra – c’è anche quella degli alimenti di cui fare proprio a meno –, lo scopo del libro si fa sempre più chiaro: non un’informazione persuasiva, ma un vero e proprio vademecum del consumatore responsabile e, soprattutto, aggiornato.

Senonché il discorso torna poi alle questioni a scala planetaria, ma anche qui qualcosa da fare c’è. Si tratta di ricorrere alle energie alternative, alle fonti rinnovabili: l’importante è non opporre al cambiamento drammatico in corso “il diniego, la rimozione, il rifiuto di sapere, il desiderio di ignoranza”; non assecondare la tendenza della “nostra psiche (a) proteggersi dall’angoscia che suscita un futuro tanto minaccioso”; non iscriversi al partito dei “collassologi” – il termine non richiede spiegazioni – o a quello più estremista dei “survivalisti”, profeti di “un’imminente catastrofe totale” di fronte alla quale non ci sarebbe che “immergersi nella natura” e “sopravvivere senza comfort” (o costruendosi bunker pieni di scorte, se si è ricchi): “progetti semplicemente idioti, e di una crassa ignoranza”. Ma anche degli “speranzisti” conviene diffidare, non essendo altro che parenti stretti dei collassologi (il sistema è prossimo al collasso, però… chissà…). Eppure – ammette l’autrice – degli speranzisti, in fondo, fa parte anche lei. Lei e i giovani, indisponibili ad accettare l’interessato immobilismo dei governanti. Segue elenco finale – l’ultimo di molti – di quel che tocca fare ai governanti e di quello che possiamo invece fare noi, gente comune, a partire dalla scelta di eleggere solo rappresentanti politici che “presentino un autentico programma ecologico”, di votare “per rappresentanti consapevoli, attivi, sinceri”.
Con il che si ha la prova che la conoscenza più dettagliata può accompagnarsi a un candore disarmante.
Forse, quello che ci si può aspettare da un scrittore è altro: che usi gli strumenti di cui dispone – la letteratura – per intaccare la nostra resistenza a credere davvero a quel che sta accadendo, o quantomeno a cessare di comportarci come se non ci credessimo.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.
Disordine e dolore tardivo
▸ dai giorni del coronavirus
Noi diciamo la morte per semplificare, ma ce ne
sono quasi quante le persone.
(Marcel Proust)
La morte è questo: la completa uguaglianza
degli ineguali.
(Vladimir Jankélévitch)
L’importante è che sei qui.
Ogni volta che ha provato a raccontare qualcosa dei giorni passati, Elisa gli ha ripetuto che contava solo questo: era di nuovo a casa. E lui ha lasciato perdere: cosa vuoi stare a raccontare di cose che se uno non le ha viste non riesce neanche a immaginare.
Lo stesso al telefono, con quei due o tre amici avvertiti dalla moglie che stavano per dimetterlo: be’, adesso sei di nuovo nella tua casa, con tua moglie. Non pensarci più, cose passate.
Sei nella tua casa, con tua moglie: come prima, aggiungono. Il resto è andato, perché parlarne?
Già. Perché parlare se nessuno ha voglia di ascoltarlo. E allora non ha più detto niente, sta zitto, li lascia dire. Cosa vuoi: metterti a discutere con uno che ti ha telefonato per felicitarsi che ce l’hai fatta? O anche: hai vinto la battaglia, gli ha detto – passando per la prima volta al tu – il vicino che sta sul loro stesso pianerottolo e che è venuto fuori a salutarlo quando è tornato.
Ma cosa ho fatto, cosa ho vinto? si chiede.
“La letteratura è una cosa così forte, che non ha bisogno di fare niente…”
“La letteratura è una cosa così forte, che non ha bisogno di fare niente. La letteratura è la mano su questa terra di un Dio che non esiste. Ha un potere imparagonabile. Le cose della vita, le stesse tragedie, sono momentanee. La letteratura non lo è. Il tempo è il peggior nemico delle persone. E l’arma migliore che la gente ha per combattere il tempo, per superarlo, è la letteratura. Di Omero non ti ricordi i politici, i soldati, i combattenti, ma ricordi Omero. Ricordi loro solo perché lui li ha raccontati. Un essere umano creato da Dio può vivere per circa 80 anni. Ma un personaggio creato dalla letteratura vive per sempre. Shakespeare, creato da Dio, non ha vissuto a lungo. Però Amleto creato da Shakespeare vivrà per sempre. Per questa ragione penso che Dio sia geloso degli scrittori”. (Ahmet Altan)
Il coraggio di non dimenticare

Romina Casagrande, I bambini di Svevia, Garzanti 2020 (pp. 400, euro 18,60)
“Migliaia di bambini (quattro mila all’anno nei periodi più duri, ma troppi di contrabbando per sapere con esattezza quanti) dai cinque ai quindici anni, per tre secoli – dal Settecento a metà del Novecento –, hanno attraversato le montagne. Soli, con uno zaino sulle spalle, dall’Italia, dal Ticino, dal Sud dell’Austria, lasciando paesi poverissimi e famiglie che li avevano venduti, per lavorare nelle ricche fattorie dell’Alta Svevia”.
Questo il fatto che la Storia, una Storia poco nota, ci consegna. Come farne un romanzo? Ripercorrendo la Storia in una storia, ovviamente: quella di delineare una vicenda coi suoi tempi e i suoi personaggi sullo sfondo di un’epoca e degli avvenimenti in essa accaduti è la ragion d’essere stessa del romanzo, la sua missione. Coniugare l’universale e il singolare in modo che ne escano reciprocamente illuminati. E dunque, fra quelle migliaia di bambini zumare su Edna e Jacob, delinearne i caratteri, raccontarne la relazione che li terrà in qualche modo uniti anche dopo che un drammatico tentativo di fuga dalla fattoria in cui si erano incontrati li separerà.

Ma c’è di più, in questo romanzo. La narrazione marcia sui due piani del passato e del presente, la cronaca e i flash back si alternano fino alla fine delle sue quasi quattrocento pagine, senonché questo modo di procedere, di costruire l’intreccio, non deriva semplicemente da un espediente narrativo collaudato: il fatto è che se Edna, ormai vecchia, ripercorre il cammino fatto da bambina per andare a trovare Jacob, una volta che ne ha inaspettatamente rintracciato notizie, è perché “il passato, anche quello più lontano, si può aggiustare purché lo si voglia”, purché si conservi – come Edna – la capacità di credere che “le persone non (scompaiono) mai completamente. A meno che non (sia) tu a volerlo”. E allora si tratta di scegliere, per esempio se accettare le cure affettuose di una vicina e sistemarsi in una casa di riposo o invece eluderle e fuggire, di nuovo, per tornare là dove tutto era cominciato. I due piani temporali su cui corre il racconto si articolano così ulteriormente: mentre quello della vita dei due bambini e dei loro compagni nella fattoria sveva evoca l’atmosfera dei lager che romanzi e film sulla Shoa hanno reso efficacemente, spesso crudamente, il racconto del viaggio di Edna e delle figure con cui viene in contatto si risolve in una successione di episodi e colpi di scena che richiamano la narrativa nord europea, da Paasilinna allo Jonasson del Centenario che saltò dalla finestra e scomparve. Il destino drammatico dei bambini di Svevia non cessa tuttavia di rappresentare il motore della narrazione, anche quando le avventure della vecchia Edna e del suo inseparabile, e altrettanto attempato, pappagallo Emil catturano l’attenzione del lettore. Un destino che, non si fosse complicato nelle loro vicissitudini presenti, nell’incontro con la generosità svagata di giovani marginali e nelle riflessioni che ne conseguono, sarebbe rimasto solo un documento del passato, un’ulteriore testimonianza delle innumerevoli ingiustizie della Storia e della violenza cieca degli uomini, senza saper raggiungere la forza di un’evocazione vivida e allo stesso tempo capace di aprirsi – attraverso l’indimenticabile protagonista – al sorriso e alla speranza, con il coraggio che solo “tener fede a ciò che si è” può dare.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.
Pensiero del Presente / Una cronaca che si fa Storia
Dieci buone ragioni per leggere un “minidiario” dai giorni della reclusione
▸ dai giorni del coronavirus
Esco alle otto e mezza di sera, perché non ho voglia di rifare la coda fuori dal supermercato, a un metro da quello prima e da quello dopo, che ci si guarda in tralice di continuo per far mantenere la distanza, con il serpentone che si allunga finché il supermercato non lo vedi nemmeno. Fuori, vuoto.
Ma vuoto vuoto. Che ho un primo attimo in cui dico ah, però, bello, mai visto così e poi mi scopro inquieto, perché le montagne, le vallate, il mare sono belli quando non ci sono le persone, le città no: se sono vuote sono città morte.
Comincia così il “minidiario dei giorni di reclusione”, scritto a partire dal 13 marzo, pochi giorni dopo l’inizio del “lockdown”, ma “scritto un po’ così”:
Sto scrivendo di getto, rileggendo a malapena quanto scrivo (è una delle regole che mi sono dato per questo diario, lo dichiaro fin dal titolo).
Ma scritto da chi? Da Trivigante, stando al nome del sito – trivigante e le cose – che evoca un personaggio dei poemi quattrocenteschi di Pulci, Boiardo e Ariosto.
E perché leggerlo, di questi tempi, intasati di commenti punti di vista critiche eccetera?
Per dieci buone ragioni. Che ti si fanno chiare man mano leggi il già scritto e si confermano poi di giorni in giorno (sperando che Trivigante tenga duro).
1.
Condizioni di vita comuni, o molto simili – anche se la barca un cui ci troviamo non è mai stata la stessa, e tanto meno lo è stata via via che la Fase Uno procedeva fino a sfociare, si fa per dire, nella Due – non hanno sgombrato la scrittura da una sua abituale e radicata postura: molte delle cose che abbiamo letto e leggiamo in questi giorni portano in sé l’ambizione, più o meno dissimulata, di alzarsi una spanna sopra gli altri, di distinguersene. Come se scrivendo, appunto, si potesse guardare quello che sta intorno da una posizione privilegiata, tirandosene fuori nella sostanza. O immaginando di farlo, comunque.
Continua a leggere Pensiero del Presente / Una cronaca che si fa StoriaPasqua. Duemilaventi
▸ dai giorni del coronavirus
Uno
Gli occhi sono rimasti sbarrati, anche quando il petto ha ripreso – irregolarmente, quasi impercettibilmente – ad alzarsi e abbassarsi. È restato anche il terrore, in questi occhi.
Un terrore da cui non è scomparsa del tutto l’espressione che doveva averlo preceduto: di incredulità – sta succedendo a me? è così che accade, è così che si muore?
Domande che lo sguardo, non la voce, non ha cessato di fare.
Non esce suono dalla bocca aperta quanto può a gridare la sua fame d’aria.
È muto l’urlo che la vita oppone alla morte, fino all’ultimo, quando ha sconfinato ormai nel silenzio definitivo.
Mi guardano senza vedermi, i suoi occhi. Si aggrappano a me, perché le mani non possono smettere di annaspare, come a ghermirla quell’aria che incredibilmente si è fatta più in là, oltre un muro che nessuno vede. Là, dove stanno gli altri, che non sanno di respirare.
Solo un gorgoglio profondo si intende ancora, a tratti. È liquido, non aereo, il fluido che non ha abbandonato i recessi di questi polmoni che non vogliono interrompere il movimento imparato dall’aria nel primo incontro con il mondo di fuori, in un tempo che la memoria non sa.
Un ritmo che il corpo non aveva mai più dimenticato e credeva suo per sempre. E dunque non ha potuto, non può immaginare di restarne privo.
Non sa nulla del cadavere, il corpo.
“Una volta i protagonisti dei libri più importanti erano dèi…”
“Una volta i protagonisti dei libri più importanti erano dèi, poi diventarono semidei, poi eroi, poi nobili, poi borghesi, poi uomini comuni, poi emarginati e infine scrittori”. (Vanni Santoni)
Imparare a vivere nel tempo

Mauro Bonazzi, Creature di un sol giorno. I Greci e il mistero dell’esistenza, Einaudi 2020 (pp. 160, euro 12.50)
“Siamo soggetti temporalmente determinati, e dobbiamo imparare a vivere nel tempo”: tutto qui. Proprio tutto. E i Greci ne erano ben consapevoli, anche se sul modo in cui imparare non erano sempre d’accordo. Quanto all’autore, che ci accompagna in un viaggio che va da Omero a Platone, Aristotele ed Epicuro, ci fa fin dall’inizio una raccomandazione precisa: “riconoscersi nella propria incompletezza, senza però arrendersi, continuando piuttosto a farsi domande”. Come i Greci, appunto.
E dunque, prendiamo atto che oltre che mortali siamo “esseri desideranti”, animati dalla mancanza di unità che sentiamo in noi e da cui deriva “un desiderio che non può mai essere soddisfatto”: questa “una delle scoperte più originali e affascinanti di Platone”, di cui Freud è debitore: prima di lui, è stata la Diotima del Simposio a mettere in chiaro che “la forza che (ci) spinge a fare in modo di riprodursi” combatte contro un nemico ben individuato. La morte. E allora, dal momento che “La natura mortale cerca per quanto le è possibile di essere sempre e di essere immortale (così Platone), “produrre un altro individuo simile a sé” è il modo dei viventi – non solo degli uomini, anche degli animali e delle piante – di “partecipare, nella misura del possibile, dell’eterno” (così Aristotele): “individualmente siamo destinati a scomparire, ma possiamo prendere parte alla sopravvivenza della nostra specie, contribuendo alla sua immortalità”. Ossia: “conserviamo la vita – più o meno, visti i trend demografici attuali… –, ma quanto di noi stessi, di ciò che realmente siamo, dei nostri pensieri, dei nostri desideri e delle nostre azioni, rimane?” Siamo daccapo, senza poi contare che nell’unione sessuale si gioca anche altro che con la vita a poco a che fare, anzi: quel che sotto sotto agisce è “una sorta di nostalgia per la condizione di indeterminatezza primordiale”, per cui, indistintamente, si persegue “una specie di estinzione di sé nell’inorganico”. Anche qui Freud, certo – quello di eros e thanatos –, ma prima di lui i Greci. I filosofi, ma anche i poeti, come Pindaro: “Creature di un solo giorno – eccolo, il titolo –: che cos’è mai qualcuno che è mai nessuno? Sogno di un’ombra è l’uomo”. Il problema è quello, e resta. L’ha detto bene Hannah Arendt: “Questo è l’essere mortale: muoversi in linea retta in un universo dove tutto ciò che si muove segue semmai un moto ciclico”. Non restano che espedienti perciò, come la gloria che gli eroi di Omero non fanno che cercar di assicurarsi, assillati dall’oblio incombente, dalla prospettiva della “caduta nel nulla, nell’insignificanza”. “La conquista della gloria è la prova che non si è passati invano”, che si è stati “unici”.
Questo è Omero, ma dal campo di battaglia si passa poi alla polis, da Achille a Pericle: il riconoscimento cui si punta non è più individuale ma collettivo, perché questo vuole essere per l’appunto la polis, un “individuo collettivo”. Dalla vita eroica alla vita politica, quindi. Ma a ben vedere qualcosa in comune caratterizza i due campi: la forza, l’impulso a dominare, in nome di una legge che “non abbiamo stabilito noi”, avverte uno storico questa volta, Tucidide: “l’abbiamo ricevuta che già c’era e a nostra volta la consegneremo a chi verrà dopo”. “Il nazismo – conclude senza mezzi termini l’autore – è uno sviluppo possibile di un percorso che è iniziato nella Grecia antica”. Una tragedia, in definitiva: l’azione, che sia militare o politica, partita dal desiderio di combattere la morte finisce col produrre morte. E allora meglio la vita contemplativa, l’unica vita felice, afferma Aristotele, perché l’unica che realizza la nostra “semenza”. E così siamo a Dante, che pure fa finire in un naufragio il desiderio di conoscere del suo Ulisse. Il naufragio cui sono destinati gli uomini se contano solo sulle loro forze intellettuali, se non riconoscono il loro limite (il limite della scienza e delle sue applicazioni, per gli uomini di oggi…).

Si ha l’impressione che dopo tanto arrabattarsi, sia Epicuro a dare la soluzione. Ne sembrava convinta persino un’intelligenza implacabile come quella di Wittgenstein: “La morte non è evento della vita. La morte non si vive. Se, per eternità, s’intende non infinita durata del tempo, ma intemporalità, vive eterno colui che vive nel presente”. Se siamo i nostri corpi, di cosa ci dobbiamo preoccupare? La loro fine è la fine di tutto. Senonché – ecco il punto – si può non aver paura della morte, ma averne del dover morire, del dover abbandonare tutto quello che siamo stati e siamo, tutte le nostre speranze, i nostri desideri. Desideri immaginari, e proprio per questo inestinguibili, ammonisce Epicuro: desiderare di lasciar traccia di sé avvelena la vita, si tratta di “rifiutare la schiavitù del tempo futuro” e vivere il momento presente, riconoscere – consapevoli che si è nati per caso – il sentimento dell’“esistenza pura”, un’esistenza attenta solo a bisogni reali. Il cui soddisfacimento non aumenta con la durata della vita: per questo si può dire che “il tempo per chi è felice non conta”. Però. Però noi siamo nel tempo e siamo i nostri progetti, non rinuncia a sostenere l’autore. E dunque: non ha senso rifiutare la paura della morte. Perché siamo mortali. È la nostra condizione. Una felicità inevitabilmente venata di malinconia, sembra potersi alla fine ricavare da queste pagine, ed è quello cui realisticamente possiamo aspirare.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.
“Scrivere romanzi è come andare a funghi…”
“Scrivere romanzi è come andare a funghi, quando ne trovi uno poi lo cucini. A volte basta proprio poco…”. (Andrea Vitali)
Vite disincantate e appassionate

Tracy Chevalier, La ricamatrice di Winchester, Neri Pozza 2020 (pp. 287, euro 18)
“Le ricamatrici di Winchester sono state così gentili da mostrarmi i loro modo di lavorare, spiegandomi i punti che adoperano”, “I campanari della Cattedrale di Winchester mi hanno consentito di assistere alle loro sonate”: potrebbe essere la protagonista a esprimere questi ringraziamenti e invece è l’autrice, nella nota che conclude il romanzo. Per scriverlo, Chevalier ha dovuto impratichirsi in campi a lei prima estranei, gli stessi nei quali si avventura Violet, la protagonista di una storia leggendo la quale si ha spesso l’impressione di aggirarsi nel mondo di Jane Austen. Impressione che la stessa Violet prova, a un certo punto, e che ha comunque presentito fin dal momento in cui, visitando la Cattedrale di Winchester si è imbattuta nella tomba della Austen e non ha potuto non notare che “la nuda lapide sul pavimento non citava neppure la sua attività di scrittrice”. Una comune sorte sembra avvicinare donne tra loro distanti come la grande romanziera e la dattilografa ormai trentottenne, come tale destinata a ingrossare le file delle “donne in eccedenza”, rimaste senza possibilità di accasarsi in un’Inghilterra da poco più di un decennio uscita dalla Grande guerra dalla quale molti uomini – fra cui il fratello e il promesso sposo della protagonista – non hanno fatto ritorno. È tutta qui la storia di Violet: nella sua volontà di lasciare un segno della propria esistenza, una determinazione pacata che non ha nulla di eroico se non nell’accettare la vita toccata in sorte e nel vivere orgogliosamente la propria solitudine. Con consapevolezza e realismo, ma senza ombra di rancore, senza l’impressione di aver subito ingiustamente torti irrimediabili, restando aperti al mondo quindi, e agli altri. Sapendo perciò cogliere un’identica disposizione nel campanaro che coltiva un proposito analogo: imparare a far bene qualche cosa che abbia senso e non soccomba alla futilità dei gesti e alla labilità delle intenzioni. Come Violet nutre “il desiderio di ricamare il meglio possibile, pur sapendo che forse nessuno se ne accorgerà”, così Arthur è appagato dalla coscienza di suonare meglio che può, “anche se pochi sono in grado di distinguere una buona suonata da una mediocre”. Perché se il suono delle campane non dura nel tempo, dura nella memoria.
E così, questi due personaggi, sommessi e per nulla eccezionali, restano nella memoria a lettura finita, emblemi di un saper vivere disincantato ma affatto privo di passione.

Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.
Crescere nell’epoca della grande trasformazione

Gian Arturo Ferrari, Ragazzo italiano, Feltrinelli 2020 (pp. 311, euro 18)
Ci si entra da subito in questo romanzo, soprattutto se l’età è quella. Quella di chi ricorda bene l’Italia prima del boom economico, l’Italia degli anni Cinquanta. Ma non si tratta solo di una memoria comune, nella quale il lettore attempato, diciamo, si appaesa. Anche chi, più giovane, di quegli anni serba solo ricordi di seconda mano, per sentito dire, si sente fin dalle prime pagine accompagnato da una narrazione in cui il punto di vista del bambino, che quell’epoca ha vissuto, sa virtuosamente contaminarsi con quello dell’adulto che ricorda: è quello che accade nelle autobiografie riuscite, anche se, come questa, scritte in terza persona. Così come raggiunto è l’obiettivo di farsi seguire dal lettore in un andirivieni continuo fra la storia di Ninni e la Storia collettiva. Obiettivo del resto evidente sin da titolo, in cui il ragazzo di cui si racconta è esemplarmente un ragazzo italiano, personaggio la cui formazione è tutt’uno con quella del Paese uscito dalla guerra. L’inevitabile singolarità della costellazione familiare (la nonna maestra, la madre apprensiva e amorevole, il padre ombroso e distante) si coniuga con la modernizzazione che investe la società e ridefinisce mentalità e aspirazioni, traducendosi in un nuovo modo di abitare e gestire la vita quotidiana, e nella comparsa di oggetti che chi è venuto dopo ritiene presenti da sempre nelle case, naturali, e invece segnarono il cambiamento: gli elettrodomestici e un arredamento nel quale “tutti volevano dimenticare al più presto le loro origini e le loro fatiche” per “installarsi in quella nuova immagine di sé di cui l’arredamento era l’immagine visibile”, mentre, fuori casa, il paesaggio urbano stava mutando, con i grandi magazzini e, soprattutto, con le automobili. La “piccola carriera” del padre permette alla famiglia di “pagare il debito” contratto per trasferirsi a Milano “all’incirca quando l’Italia (finisce) di pagare il suo”, con la ricostruzione e poi con gli anni dello sviluppo. Partecipe della grande trasformazione, non sfugge tuttavia, al protagonista, il successivo diffondersi di una diversa “atmosfera generale”, in cui le persone sembrano aver smesso di cercare, “disperatamente, di andare avanti”: “Si erano calmati, cominciavano a essere soddisfatti. Dei loro controbuffet, dei loro lampadari di Boemia. Ce l’avevano fatta e adesso che avevano perso lo spirito eroico si capiva che quello per cui avevano lottato era in realtà ben poca cosa. E persino la pur legittima soddisfazione si colorava di angustia. Ingrigivano. Anche il babbo, che a casa non lavorava più [anche a casa, portandosi il lavoro dall’ufficio], ingrassava, aveva perso lo scatto”. La scoperta della città, dalla periferia al centro, la colonia estiva, la scuola, la politica studentesca e, finalmente, il superamento della balbuzie che da sempre aveva afflitto Ninni… Come in quasi tutte le autobiografie, l’aura di cui il racconto degli anni dell’infanzia era pervaso, e che si era solo stemperata in quello dell’adolescenza, va perdendosi nella cronaca della prima giovinezza: il bambino e il ragazzino – cui sono intitolate la prima e la seconda parte – ci resteranno nella memoria più del ragazzo della terza.

Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.
“Penso a volte che il vero scopo dello scrivere sia trovare parole definitive, oggettive…”
“Penso a volte che il vero scopo dello scrivere sia trovare parole definitive, oggettive, e so che questo non è possibile. (…) trovare una frase che racchiuda un sentimento, che lo incarceri una volta per tutte in una forma assoluta, che impedisca a chi legge di raccontare quello stesso sentimento con parole diverse da quelle che trova scritte. Questo è il sogno della scrittura. Ma è anche la sua chimera”. (Andrea Tarabbia)
“Il mio solo strumento di indagine è la scrittura…”
“Il mio solo strumento di indagine è la scrittura. Nel costruire un personaggio, nel farlo pensare, agire e relazionarsi con gli altri, quasi sempre guadagno una posizione sulla via della consapevolezza, mi libero di uno stereotipo, mi metto alla prova”. (Lidia Ravera)
Una civiltà planetaria

Mauro Ceruti, Evoluzione senza fondamenti. Soglie di un’età nuova, Meltemi 2019 (pp. 102, euro 11)
“Sentiamo il peso di una storia senza fondamenti. Viviamo in un groviglio di storie nella cui stessa trama si sono diffusi e dispersi l’ordine e il senso complessivo di quella che è stata definita come la Storia. (…) La nostra esperienza del tempo e della storia si è frammentata, infrangendo l’eterno presente in cui il sogno del calcolo – ossia della scienza moderna, quantificatrice e sempre alla ricerca di leggi costanti – avrebbe voluto comprimere il passato e il futuro”.
Affermazioni che non sembrano lasciare dubbi. La situazione è irrecuperabile, nessuno spazio alla fiducia in sorti migliori.
Senonché: non un progresso sicuro e inevitabile, ma l’emergere di nuove realtà, situazioni, scoperte e modi di concepire la conoscenza imprevisti e imprevedibili, in una sequenza non assimilabile a un progresso lineare e irreversibile, appunto, apre la possibilità di un’inedita “civiltà planetaria”, a misura di pianeta e di umanità tutta, non di antropo- ed etno- centrismi.
Le avvisaglie si fanno sentire da tempo: nel neoevoluzionismo come nella fisica contemporanea.

Si è compreso che l’evoluzione può essere paragonata a un film che però “ad ogni eventuale proiezione avrebbe un finale diverso”. Oggi possiamo pensare che la chiave per comprendere e per generare la condizione umana è la sua incompiutezza. E incompiutezza significa che gli esiti futuri non sono inscritti di necessità in qualche fondamento, in qualche essenza della natura umana”. L’universo vivente non è dato in anticipo e l’evoluzione non rivela un piano dotato di senso quanto piuttosto i modi di procedere di un bricoleur.
Non diversamente, la fisica permette di prospettare sia un’espansione ininterrotta dell’universo che lo porterà a dissolversi che un suo riconcentrarsi (Big crunch) che lo faccia tornare a una condizione simile a quella precedente il Big bang, il che non vieta di pensare che un’altra esplosione creatrice ne possa seguire… Ma, al fondo, che si parli di fine del mondo o di suoi possibili nuovi inizi, non ci si sta comunque muovendo – e non potrebbe essere diversamente – entro l’orizzonte determinato dagli strumenti cognitivi umani? Da dubbi come questo nasce l’interesse attuale per altre concezioni cosmologiche, come quelle che miti e concezioni filosofico-religiose di matrice extra occidentale hanno prodotto. L’idea di una “Terra madre” pare fattore indispensabile di un ecologismo all’altezza dei tempi… Ed ecco allora che una civiltà planetaria in grado di integrare visioni – da accogliere nella loro diversità, non da gerarchizzare – appare la via del futuro, dell’unico futuro possibile, ma emergerà davvero un orientamento a “favore della sperimentazione e della diversificazione piuttosto che della standardizzazione?” È una domanda a concludere il discorso. Un discorso nel quale comunque il tono prevalente è stato quello della speranza, addirittura dell’ottimismo a tratti. Una posizione, quella di Ceruti, che ricorda per molti versi l’ultimo libro di Ulrich Beck (La metamorfosi del mondo, Laterza 2017), secondo il quale nella trasformazione in corso “le vecchie certezze della società moderna vengono meno e nasce qualcosa di totalmente nuovo” e dobbiamo perciò saper vedere anche possibili, positivi “nuovi inizi”.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.
“Qualunque racconto implica anche un intento vendicativo…”
“Qualunque racconto implica anche un intento vendicativo di qualche tipo o almeno risarcitorio”. (Tommaso Pincio)
Quando lo scrittore si fa critico
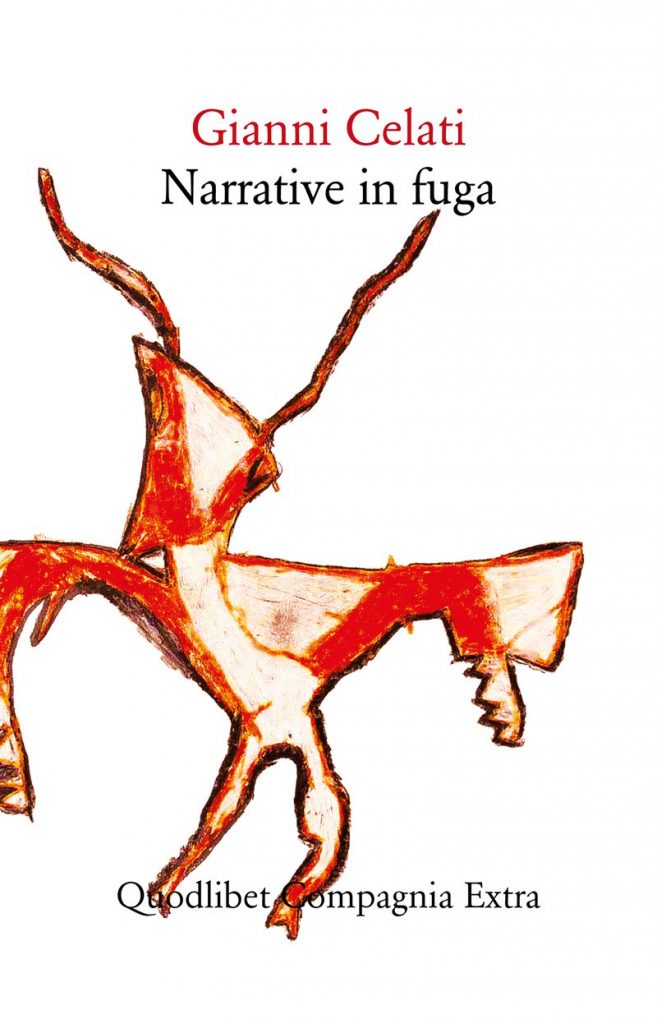
Gianni Celati, Narrative in fuga, Quodlibet Compagnia Extra 2019 (pp. 342, euro 18)
Testi critici che assumono a tratti l’andamento del racconto, una saggistica che si fa narrativa senza mancare il suo obiettivo critico: solo uno scrittore come Celati, traduttore oltretutto (di Céline come di Joyce, di Swift e di tanti altri), può scrivere in questo modo dei suoi autori. Una scrittura che appare il seguito naturale di un incontro con gli autori maturato nella lettura e nella rilettura. Più giovane di Calvino, Celati ne riprende il modo di parlare delle opere lette, e rilette. Forse anche in forza del legane intellettuale e umano che li legava (ampiamente documentato nelle note contenute nel Meridiano che raccoglie gli scritti di Celati, pubblicato nel 2016).
Scorriamo alcuni passi nei quali appare evidente quel di più che uno scrittore sa mettere nei suoi commenti, riuscendo ad arrivare fulmineamente, con pochi tratti, sintetici ed esatti, a delineare personaggi e autori: prerogativa del Tom Sawyer di Mark Twain non è una generica arte di arrangiarsi, ma una vera e propria “alleanza con il mondo”; il narrare di Jack London ha “la fluidità del racconto panoramico – il racconto immerso in un tempo vago e dilatato, che attraversa rapidamente gli eventi. È il modo più semplice di narrare: quello dell’epica e delle fiabe, senza elaborate costruzioni, senza presentazioni psicologiche”; “L’improvvisazione è il metodo compositivo adottato da Stendhal in tutti i suoi libri, senza piani di lavoro preordinati (…) Si tratta di affidarsi a un estro estemporaneo, irriflesso e non programmabile, in cui la rapidità di scrittura serve ad evitare quel congelamento delle parole che nasce da una dissociazione tra il pensiero e la cosa che si sta scrivendo”, e si cita a conferma lo stesso Stendhal: “Non riesco a fare piani di lavoro se non dopo, analizzando quello che ho trovato. Il piano di lavoro fatto in anticipo mi agghiaccia. (…) Io ho sempre scritto come Rossini scrive la sua musica…”; “La cura céliniana consiste nel rompere la concatenazione scontata tra le frasi, attraverso l’uso dei tre puntini che indicano le pause ritmiche in cui la voce rimane sospesa. (…) Céline elabora un modo di scrivere dove la scrittura diventa una specie di spartito, capace di notare ritmi e tonalità delle parole. (…) Se confrontiamo questa lingua con quella standard dei libri di successo, viene da pensare che gli attuali libri di successo corrispondano ai cosiddetti non luoghi (luoghi uguali in qualsiasi parte del mondo si trovino), mentre quelli di Céline corrispondono a un’isola oceanica poco accessibile, quasi disabitata”; “Swift scrive come un alieno che vede l’umanità come una specie votata al falso, presa all’amo da tutti gli inganni. Il suo è un tono così innaturalmente distante che lascia di stucco; ma anche con improvvise invettive o sarcasmi che mettono a disagio il lettore in cerca di conforti nella carta stampata”; il modo di narrare di Flann O’Brien, Joyce, Beckett non è “più consacrato alle rappresentazioni della coscienza, ma a qualcosa che le perturba e le disperde nel silenzio; ed è un modo di narrare che si rivolge a lettori che non credono più alla falsa concretezza dei fatti, del fattibile, del verosimile, dell’attualità…”. E su Joyce, in particolare, e il suo Ulisse: “Il punto focale della peregrinazione di Mr Bloom è la vita qualsiasi, la vita senza niente di speciale, la vita come un sogno o un lungo chiacchierare con se stessi.”
È tuttavia nei due saggi che aprono e chiudono la sezione dedicata agli americani che la lettura di Celati si fa scrittura che coinvolge, quanto le opere di quelli.
Bartleby innanzitutto, e il suo “avrei preferenza di no”: perché “questa vicenda ci lascia più pensosi di ogni altro racconto moderno?” Per via dei caratteri del personaggio: “imperturbabile e laconico, sordo ad ogni ragionevole persuasione” ma anche, si badi, “inespugnabilmente mite”, e “figura di ciò che non può essere salvato” e allo stesso tempo “di chi non ha nessuna voglia di farsi salvare”, chiuso in “austero riserbo” venato di una “sbiadita altezzosità”. E via di questo passo: lo conoscevamo, lo scrivano di Melville, ma è come se lo incontrassimo solo adesso, riportandone una lezione che va al di là del personaggio e dalla sua ritrosia a parlare trascorre al significato dello scrivere: “La potenza della scrittura non sta in questa o in quella cosa da dire, ma nel poco o nel niente da dire, in una condizione dove si annulla il dovere di scrivere. Ogni voler dire e dover scrivere è la patetica vittima delle proprie aspettative. La potenza della scrittura sta nella rinuncia al dovere di scrivere, nella sospensione delle aspettative…”.
La centralità di Bartleby nell’esperienza – non solo letteraria e culturale, ma anche umana e professionale – di Celati trova conferma nella sua presenza del personaggio anche nel saggio più ampio del libro, le Storie di solitari americani”, in cui non un singolo autore ma il filo che li lega costituisce il tema di fondo: la solitudine. La solitudine, il suo dilagare, il suo assumere forme diverse nel XIX e XX secolo, in America ma non solo.
In Hawthorne – nel suo inimitabile racconto Wakefield, in particolare –, in Poe, in Melville, appunto, “si profila uno stretto legame tra la solitudine in cui [i personaggi di questi autori] si sono smarriti e l’inevitabile caduta cui tutti siamo destinati. Quello è il legame che i linguaggi consolatori debbono spezzare, per nascondere l’angoscia che produce; ma per farlo debbono stimolare una perpetua fuga dal pensiero della nostra caduta. Il laconismo di Bartleby è invece un modo per aderire alla caduta, allo smarrimento dei traffici quotidiani, al destino di alienazione da se stessi, e infine alla propria morte” e rappresenta così una “figura non mitica ma fraterna, che riporta la vita alla sua insignificanza naturale, perché la fa coincidere col semplice scorrere del tempo ed esaurirsi delle forze.”

Dopo i racconti di Hawthorne, Poe e Melville, che “trascinano verso una riflessione sull’ordine sociale, sui suoi limiti, sui suoi margini di estraneità e pericolo”, in cui “la solitudine prende un senso nuovo”, si diffondono le short stories, nelle quali tutto è “casalingo, familiare” e l’umanità che vi compare “facilmente comprensibile”: è “l’invenzione della normalità”, l’affermarsi di una narrativa rassicurante. Unico a non piegarsi al nuovo corso, Henry James, che continua la riflessione sulla solitudine moderna e “non (cede) alla tentazione di spiegare che cosa c’è nella testa degli altri”. La sua reticenza è una forma di resistenza alla “volgarizzazione moderna (che) fa tutt’uno col mito della comunicazione sociale, che seppellisce l’incomprensibile della vita sotto strati di parole morte” e ridefinisce la solitudine, la quale “non sta più nell’essere soli, ma nel non poter evadere dalla sterilità dei copioni che dovunque si recitano per dovere” tornando “sempre agli stessi incastri nevrotici che coincidono con i costumi delle società civili.”
Jack London, consapevole di questa involuzione, crea storie ambientate nei “deserti artici come esperimenti mentali per immaginare cosa può essere la vita fuori dagli schemi immunitari delle società moderne che la riducono a un insieme di meccanismi previsti”, quando invece è una “radicale incertezza sulla propria morte che segna tutta la vita dell’animale umano.”
L’eredità di London sarà raccolta da scrittori come Hemingway, caratterizzati da “un laconismo che indica una solitudine di fondo, ma anche (da) un riserbo dettato dalla difficile condizione dell’esperienza individuale”, destinata a una sostanziale cancellazione non colmata da “mitologie della libertà interiore”, ma piuttosto – come in uno dei primi racconti di Gertrude Stein – da un’identificazione con una socialità in cui ciò che avviene è “l’annientamento dell’individuo”. Come in Stein, così in Sherwood Anderson e in Hemingway “troviamo personaggi che sembrano estranei a tutto, con cui non possiamo identificarci; ma personaggi che lasciano il segno del loro laconismo e della loro solitudine nella forma narrativa, nel tono delle parole che parlano di loro; per cui quei racconti diventano come verbali della loro estraneità e assenza d’espressione”. E insieme denuncia della “chiacchiera” che serve “ad abolire i silenzi mascherando la solitudine con una parvenza di integrazione in un gruppo; e siccome è un parlare che ripete ciò che è stato già detto da altri, come se tutto fosse sicuro e scontato, la chiacchiera estende ad ogni incontro un’idea di normalità come regola di vita”, una vita “ovvia, prevista o prevedibile, risolta o risolvibile nel migliore dei modi”, in ogni caso obbediente all’”imperativo categorico di mostrarsi agli altri sempre felici della propria situazione”, all’“imperativo ‘Smile!’”, “segno d’un’integrazione sociale di rappresentanza”.
Celati parla di autori del passato, ma è il nostro mondo a emergere dalle sue parole.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.
“Il periodo in cui si è più vivi e consapevoli è l’infanzia…”
“Il periodo in cui si è più vivi e consapevoli è l’infanzia, e perciò si cerca di recuperare quell’acutezza di percezione. (…) Io conoscevo intimamente il mondo che mi circondava, ero al corrente della piccola storia di ciascuno, la materia di cui sono fatti i racconti e i romanzi. (…) Tutte queste cose si sono sommate rendendomi quella che sono”. (Edna O’Brien)
L’enigma di una vita anonima
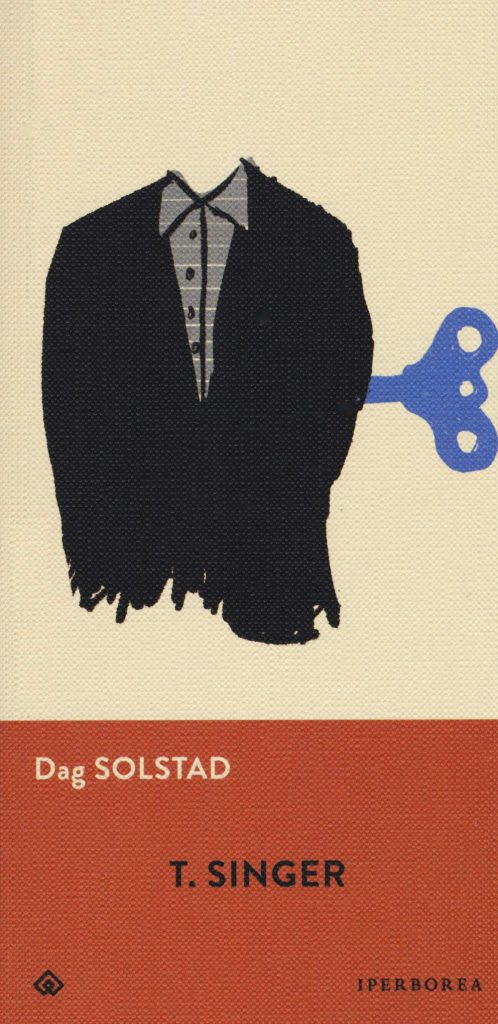
Dag Solstad, T. Singer, Ipeborea 2019 (pp. 249, euro 17)
Questo romanzo – ci avverte l’autore quando ne abbiano letto più o meno la metà – “è l’unica descrizione esistente della vita di Singer, e probabilmente anche l’unica possibile. Perché bisognerà ammettere che a questo punto della storia potrebbe sembrare un enigma che Singer stesso sia il protagonista di un qualsivoglia romanzo, di qualunque livello; tuttavia possiamo svelare che questo enigma è precisamente il tema del romanzo che stiamo cercando di costruire”.
Enigma: la parola ricorre in queste pagine. Perché il protagonista stesso deve riconoscere di essere un enigma ai suoi propri occhi. Lo era da giovane, quando di frequente veniva preso da una vergogna insopportabile per un episodio insignificante del proprio passato, e tale resta da adulto. Se qualcosa risulta chiaro è che quel senso di imbarazzo che più di tutto paventa lo assale quando l’immagine – neutra, indefinibile – che di sé tiene a dare rischia di essere contraddetta da un comportamento, da un discorso. Singer è pirandellianamente angosciato dal fatto che siamo tanti quante sono le maschere che indossiamo, o ci vengono strappate, in pubblico. Schivo e desideroso di anonimato, come un Bartleby; indifferente a quel che gli accade e, si direbbe, privo di veri e propri desideri, come il Meursault di Camus, “(vaga) solo sulla faccia della terra”. Il rapporto con la moglie è naufragato, ancora prima che lei morisse, in questo suo distaccato quanto inattaccabile riserbo, in questa distanza dal mondo e da sé che si frappone anche tra lui e la figlia acquisita.
Non mancano eventi, nella storia della sua vita, ma sono soprattutto i suoi rimuginii a tenere il campo, raccontati con una meticolosità ossessiva che può ricordare Bernhard, salvo cedere poi a digressioni, a pagine e pagine in cui la narrazione sembra impaludarsi, mettendo alla prova il lettore, c’è da dire. Eppure si va avanti, in qualche modo coinvolti dalla sorte di quest’uomo che desidera scomparire senza andarsene, vivere in incognito in mezzo agli altri: “L’introverso Singer che sta sempre un po’ in disparte, taciturno e modesto, col suo umorismo garbato e quei modi schivi fino all’annullamento di sé (…). Dev’esserci una crepa indecifrabile nella sua personalità”, pensa chi lo conosce, o crede di conoscerlo. Il che non rappresenta un problema, per lui: “immaginava di apparire ai loro occhi un enigma. E l’idea gli piaceva. L’enigma Singer. La sua disperazione di non avere il controllo di se stesso, e di andare alla deriva, mentre osserva tutto dall’esterno – perché è questo che lui in fondo sente, pur senza farne mai una tragedia – è trasformata in un’espressione di rispettosa meraviglia negli occhi degli altri. Niente male. Niente affatto male, (pensa) Singer”, anche se un’inquietudine sottile si fa sempre più pervasiva: il sollievo di non essere trasparente, altro da quel che è, sa che è passeggero, perché la morte arriverà anche per lui. E allora, “a cosa mai mi servirà essere stato un enigma per me stesso e per gli altri?”
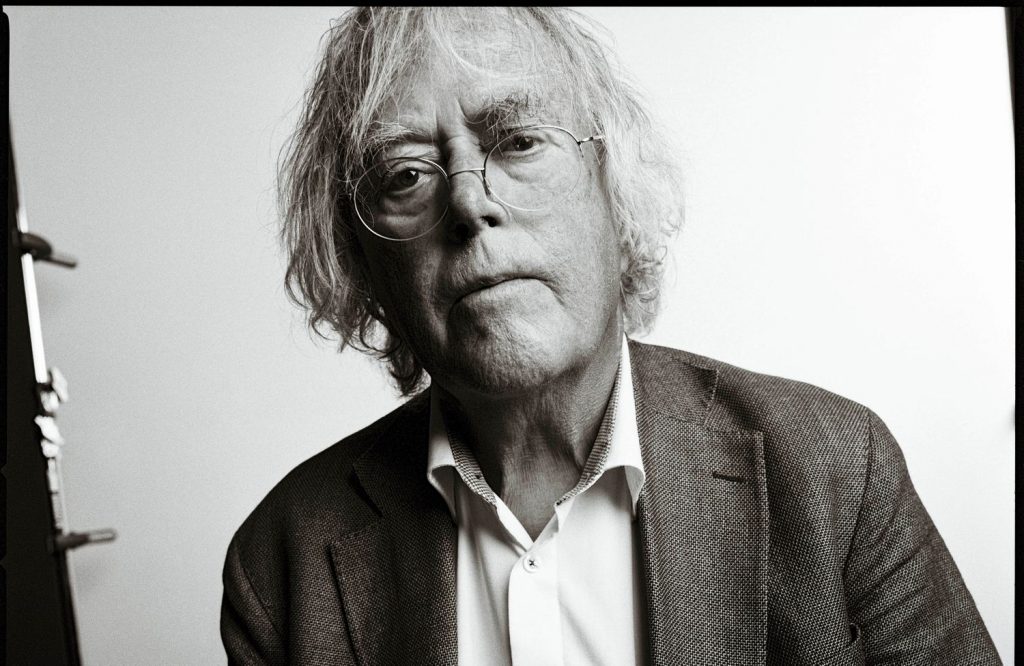
Se, leggendo, si è conservata la speranza che alla fine Singer si riveli, o che accada qualcosa che sciolga l’”enigma”, si resterà delusi. Solstad ama lasciare in una sostanziale opacità le scelte dei suoi personaggi (così anche in altri suoi romanzi, come Romanzo 11, libro 18, Iperborea 2017), convinto com’è che “In ogni romanzo c’è un grande buco nero, universale nella sua nerezza”, “e questo romanzo è appena arrivato a quel punto”, informa a poche pagine dalla fine, riproponendo la domanda che già aveva posto: “Perché Singer è il protagonista di questo romanzo? (…) Vorrei essere stato capace di dire qualcosa che Singer non fosse in grado di pensare (…), ma le parole non sono sufficienti. Il mio linguaggio finisce dove finiscono le riflessioni di Singer. Non per questo siamo identici”. Un’ implicita ammissione di autobiografismo, attenuata però da un’avvertenza di metodo: autore e personaggio non coincidono mai…
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.