Dal Corriere della Sera Brescia del 12 novembre 2015.
Clicca sull’immagine per visualizzare l’articolo.

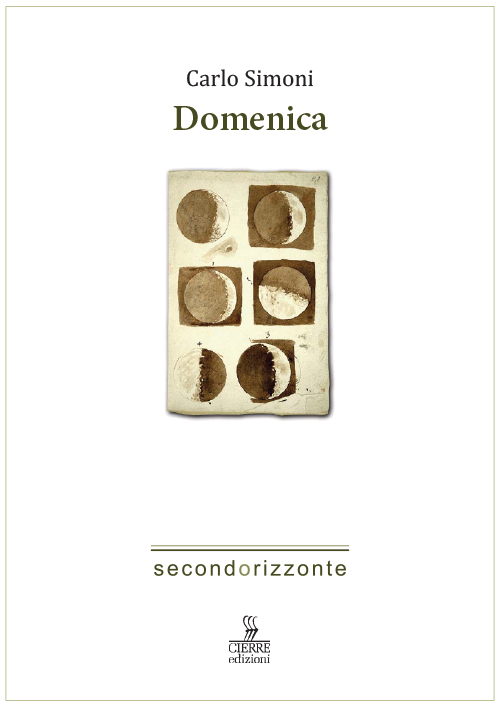
È domenica, ma si sveglia prima dell’alba: non un incubo o l’insonnia, ma un’indistinta voglia di fare spinge Ezio ad alzarsi nella casa ancora buia, dove la moglie e la figlia dormono. Si limita a sfogliare qualcuno dei volumi che ha tolto dalla sua libreria e accatastato sul tavolo, per riordinarli e soprattutto per disfarsi di quelli che da anni non prende in mano.
È una di quelle domeniche destinate alla visita ai suoceri che abitano sul lago: un breve viaggio in treno, il pranzo, i soliti discorsi e poi il ritorno. Ma non sarà come le altre: Giacomo, il padre di sua moglie, che col tempo gli è divenuto amico, è malato. Sta vivendo i suoi ultimi giorni.
Non eventi imprevisti, ma riflessioni, ricordi, intuizioni che attraversano la mente di Ezio fanno di questa domenica una sorta di spartiacque nella sua vita. Ed è nella scrittura, nella decisione di scrivere della giornata appena vissuta, che il protagonista individua una via per introdurre un cambiamento decisivo nella propria vita. Una vita segnata dalla riluttanza a coincidere pienamente con la propria condizione, dalla tendenza a immaginare altri destini sull’onda di un desiderio sempre proiettato in un indefinito domani.
Quelle che seguono sono alcune pagine nelle quali compaiono temi ricorrenti nel romanzo: il destino dei libri accumulati per decenni, il rapporto con la dimensione pubblica e la politica, ma soprattutto il pensiero della morte, e del proprio rapporto con il Tempo.
[…]
Comprava uno due libri quasi ogni settimana.
Tornare a casa con un paio di libri nuovi da spiluccare prima di andare a letto lo faceva star bene. Tanto sapeva che avrebbe letto tutto.
Non riusciva a tener dietro ai suoi acquisti. Ma avrebbe letto tutto.
È difficile però leggere un libro dopo tanto tempo che lo si è comprato. Averlo tenuto in casa per anni, al suo posto, insieme agli altri dello steso autore o che trattano della stessa materia, ti dà l’impressione di averlo letto. Forse, gli viene da pensare adesso, ma senza far sul serio, potrebbe eliminare tutti i libri che non ha mai letto. Ma allora perché non quelli che ha letto? Come quel tale, che all’idraulico che gli era venuto per casa e guardando la libreria stracolma gli aveva chiesto se aveva letto tutto, aveva risposto: no no, quelli che ho letto li ho buttati nel cassonetto della carta, questi sono quelli che devo ancora leggere. Bella riposta. Un po’ stronza a voler vedere. Da intellettuale che tira per il culo quelli che non leggono, quelli che gli unici libri che hanno in casa sono i testi scolastici dei figli e l’enciclopedia della salute. O degli animali.
No. Lui libri nel cassonetto non ne ha mai buttati e non ne butterà mai, figuriamoci. Anche se ormai lo sa che non li leggerà tutti. L’ha capito di colpo, un giorno, come per caso. È così che ci si accorge, quando ci se n’accorge, delle cose importanti che succedono nella vita.
Ce ne sono lì decine che non leggerà mai. E non è solo perché il tempo che ha davanti è meno, molto meno, di quello che ha dietro, già vissuto. No. Non è solo per questo che si lascerà dietro libri comprati e neanche aperti, se non al momento dell’acquisto, in libreria.
La questione è un’altra. Ha capito che ha sempre letto non solo per il proprio piacere o interesse o curiosità, ma anche per gli altri: non è mai stato uno di quelli che sfoggiano le loro letture, però, nel momento stesso in cui leggeva aveva l’impressione, piacevole, di acquisire un credito nei confronti degli altri. Anche se magari non avrebbe mai avuto occasione di parlare con nessuno di quello che aveva letto. Gli bastava poter pensare, anche solo in teoria, che quel che leggeva andava ad aggiungersi a quello che aveva già letto e tutto questo gli sarebbe venuto buono una volta o l’altra: per parlarne con qualcuno che avesse letto le stesse cose, quantomeno. A ben vedere non avrebbe mai saputo dire di preciso perché si sentisse incoraggiato a leggere da questa specie di fiducia. Forse la ragione doveva proprio restare poco definita. Come l’identità di quei lettori paralleli. Quello che invece da qualche tempo sente è che non gli riesce più di leggere come se leggesse per gli altri, o con altri. Non ha altra possibilità che quella di leggere per se stesso. Come sempre è stato, di fatto: ha sempre letto per sé, certo. Ma è diverso adesso. Sente che non ci sono altri a cui potrebbe dire di quello che ha letto: si sono dissolti. Non li sa più immaginare. E dunque ha pensato di dover leggere, o rileggere, solo quello che lo interessa davvero, che in qualche modo serve a lui. Anche se ne avesse il tempo, perciò, probabilmente molti dei libri che ha accumulato non li leggerebbe mai. Anche da lì è venuta quest’idea di eliminarne buona parte. Ma è difficile: l’unico criterio dovrebbe essere quello di tenere solo i libri che hanno davvero contato per lui. I molti che ritiene importante aver letto, e i pochi che forse potrebbe aver senso leggere d’ora in poi.
E gli altri? regalarli? e a chi?
No, niente regali. A meno che… a meno che dei destinatari non si sappia nulla. Sì, però di lasciare in giro un po’ alla volta, uno qui uno là, i suoi libri, metti uno su una panchina dei giardini, un altro nella sala d’aspetto del dentista, un altro ancora sulla reticella di un vagone del treno, questo no. L’aveva colpito l’idea quando un’amica francese di Valeria, passata a trovarli di ritorno da qualche giorno di vacanza a Venezia, aveva detto che proprio quel giorno aveva finito di leggere un bel romanzo, in cui entrava anche Vivaldi, e quando Valeria le aveva chiesto di prestarglielo s’era dispiaciuta. Non poteva: una volta girata l’ultima pagina l’aveva lasciato sul tavolino del bar davanti a Santa Maria dei Miracoli. Per un momento gli era sembrato un gesto poetico, e divertente, molto francese insomma. Poi si era limitato a riconoscere che non era stato come buttarlo, quel libro, in un cestino dei rifiuti alla stazione. Ma era stato pur sempre un abbandono, un lasciarlo lì e andarsene sapendo che non ti può seguire, solo come un cane. Ecco, come un cane.
E anche portare i propri libri sul tavolo di qualche biblioteca di quartiere: fare bookcrossing, come dicono, o portarli le domeniche in cui fanno questa cosa, ci sono associazioni nate proprio per farlo… Be’, sì, quello non è abbandonarli come cani. È qualcosa di diverso… È come… esporli. Esporli come facevano coi bambini che non si poteva o non si voleva tenere. Prenderne altri in cambio poi… un baratto che gli sembra troppo disinvolto, in qualche modo spietato. Nei confronti del libro che avevi comprato, che avevi tenuto con te per anni, e poi via, come se fosse stato sempre e soltanto una cosa. Sono cose che si hanno, i libri, d’accordo: ma diverse dalle altre. Vive, a modo loro, grazie a te che continui a tenerle, anche se non le usi più. Sono stati lì per anni, i libri, taciturni, e tu te ne disfi come se fossero stati lì per caso, senza rapporti con i loro simili che tu gli hai scelto come vicini.
No, non sa come farà a dar via i suoi libri.
***
[…]
Valeria i giornali non li legge, però quel che succede lo sa e un’idea ce l’ha sempre. Poi, non è che si parli di politica, neanche con lei. Ma non perché lei lo trovi importuno, o noioso. È che lo lascia dire per qualche minuto e poi le viene quello sguardo, affettuoso ma vagamente ironico, che significa sì, bene, hai ragione, ma ci tieni davvero a queste cose? È come se gli dicesse, insomma, che certo, non sta facendo chiacchiere, ma fra loro… non è il caso. Loro lo sanno che anche parlare di politica è un modo per non parlare di sé, di come stanno davvero. E lui lo sente che c’è del vero, in questo. Lo sente anche se al momento ci resta male, e quel leggere poco o niente del tutto i giornali gli sembra un muro che lei ha tirato su fra loro. Ma lo sa, è vero: parlare di politica, in fondo, non è che la chiacchiera che lui – che le chiacchiere non le sopporta – predilige. Salvo rendersi conto, le rare volte che gli capita – e se capita è solo con chi la pensa come lui, naturalmente – che con tutto il suo leggere, libri e giornali, il più delle volte non ha argomenti diversi da chi legge molto poco, e magari gli si è rivolto con quel tu che leggi i giornali che lo fa sentire come uno stravagante, rimasto aggrappato a un’abitudine che non ha più senso, o come un animale in via di estinzione. Matteo, suo cognato, parla di automobili, il suocero, Giacomo, parlava di viti e caccia, lui di politica. Tutto qui. Forse è questo che è diventato, il parlare di politica.
giovani non ti badano proprio se vai su quegli argomenti, e quelli della sua età, anche quelli della sua idea, lasciano cadere: sappiamo com’è andata, dai, cosa stai lì a insistere… Anche perché, forse, parlar di politica li rimanda ai tempi in cui pensavano di diventare qualcosa di diverso da quello che sono. E oggi sono solo quelli che sono. Finita. Anche se non sono scontenti di quello che sono diventati. Finita, in ogni caso.
Quelli poi che non sono più giovani ma sono ancora lontani dai sessanta sessantacinque, quelli li raccomando. Sono i primi a infastidirsi di fronte a certi discorsi. Come i suoi cognati, per esempio. Ma di cosa parleranno, loro? Che cosa si diranno Matteo e Loredana? Non riesce neanche a immaginarseli a discutere di qualcosa. Che non sia la marca da scegliere o le calorie da mangiare. Da non mangiare anzi.
Ma in fin dei conti, cosa fanno di male questi due? A loro il mondo va bene così com’è. Ecco. Il fatto è che per lui quelli che la vedono così sono subito sospetti, persone da averci a che fare il minimo necessario. Coi clienti del negozio è un’altra cosa: lì van bene tutti, non c’è da fare i difficili. Ma fuori… È proprio rimasto quello che era, da giovane: o uno la pensa come lui – o quanto meno si vede che ci sta alle strette nel mondo-così-com’è – oppure è uno che non vale neanche la pena di parlarci. Perché – qui sta il punto – lui questo mondo lo considera provvisorio, sotto sotto, o meglio: non del tutto vero. Ce ne può essere un altro, quello giusto, ma è inutile cercarlo dietro o sotto questo che si vede, in cui si vive. Che cosa c’è dietro? Che cosa c’è sotto: erano frasi che si dicevano, che si leggevano sui giornali, quando erano giovani, e facevano politica. Ne discutevano ore. E adesso, molti di quelli che cercavano dietro, siccome si sono accorti di non aver trovato niente, o si sono stufati di cercare, pensano che non c’era niente da trovare: perché dietro, o sotto, non c’è niente, e così è andata a finire che la pensano proprio come quelli che han sempre pensato così e perciò non hanno mai cercato. Sono gli stessi che – all’avvicinarsi dei cinquanta, nella maggior parte dei casi – senza entrare a far parte della schiera di quelli che si usa definire voltagabbana, un cambiamento l’hanno comunque fatto: è come avessero creato una propria, personale bad company. Loro restano quelli che erano, ci mancherebbe: uomini di sinistra, di sinistra quella vera. Però… il lavoro è lavoro, il mondo è questo, devi pur sopravvivere in tutta questa merda… E allora si son costruiti una specie di personaggio parallelo che ha una disinvoltura e ostenta una spregiudicatezza da far invidia a quelli che banditi lo erano sempre stati, e dei loro principi da legge della giungla erano sempre andati orgogliosi.
Dire che sono dei cinici non è dirla tutta: sono dei cinici bugiardi, cinici a corrente alternata, perché li devi sentire come sanno battere i pugni sul tavolo quando – fra amici, amici fidati, di quelli di una volta – parlano di politica.
Lui no, cinico di sicuro non lo è diventato, né lo è mai stato. Scettico se mai. Passava per scettico in quegli anni della politica. Scettico e spocchioso, anche.
Era la maschera che da qualche tempo usava: per distinguersi dagli altri, perché non riusciva ad aderire alla loro fiducia. Perché lo vedeva: era una fiducia che, presi uno ad uno, non avevano, e che manifestavano invece se erano insieme. Nelle riunioni e ancora di più nelle manifestazioni.
Lui no, neanche in quelle occasioni credeva che le cose stessero davvero per cambiare da cima a fondo.
Non lo sapeva spiegare, ma non ci credeva a tutta quella foga di saper vedere che cosa c’era davvero dietro: ai discorsi dei politici, alle manovre degli industriali, alle guerre. Perfino a quello che facevi o pensavi. Quegli altri lo sentivano che lui non era del tutto dalla loro parte. Ed è andata a finire che lui da quella parte c’è ancora: perché – crede di averlo capito, adesso, non da molto tempo – lui pensava, anche se non abbastanza da dirlo, allora, che si dovesse cercare dentro. Né dietro né sotto: dentro. Dentro questo mondo, dentro gli uomini e le donne che ci sono, non in quelli che ci saranno. O che sono da qualche altra parte (il suo sentirsi spaesato, distante dagli altri, nei pochi cortei studenteschi cui ha partecipato: con quell’inneggiare a Al Fatah e al compagno Ho Chi Minh…). Lui pensava, senza sapere il perché – non lo saprebbe spiegare davvero neanche adesso, se è per quello – che l’altro mondo, quello giusto, è dentro questo che conosciamo e non ci piace. C’è già, è qui, vicino, anche se per arrivarci, per farlo venir fuori chissà cosa ci vuole. Un lavoro lunghissimo, difficile, che non si sa se riuscirà mai. Ma, almeno, scavare nel posto giusto: dove si è, non da un’altra parte. Non lo sa perché la pensa ancora così. Non sa pensarla diversamente, ad ogni modo.
Continua la lettura nel pdf:
![]() Se vuoi leggere il libro nella sua interezza lo puoi acquistare alla nuova libreria Rinascita di Brescia (10 euro).
Se vuoi leggere il libro nella sua interezza lo puoi acquistare alla nuova libreria Rinascita di Brescia (10 euro).
Via della Posta, 7 – 25121, Brescia
Tel. 0303755394
libri@nlr.plus
Se vuoi riceverlo a casa puoi inoltrare il tuo ordine indirizzandolo a: ordini@secondorizzonte.it
e segnalando l’avvenuto versamento dell’importo indicato tramite bonifico sul conto corrente della libreria (IBAN: Unipol Banca – Agenzia di Brescia: IT 10 B 031 2711 20000000000 1851).
La spedizione non comporta aggravi di spesa.
Da Bresciaoggi del 15 gennaio 2016.
Clicca sull’immagine per visualizzare l’articolo.
Da Gruppo 2009 del 6 gennaio 2016: link
Clicca sull’immagine per visualizzare l’articolo.
Da AB inverno 2015.
Clicca sull’immagine per visualizzare l’articolo.

Diversi sono gli episodi e le situazioni da cui prendono spunto questi racconti, pensosi alcuni, altri venati di umorismo, ma percorsi da un tratto comune, rappresentato dall’atteggiamento di chi vi è coinvolto. Nessuno dice niente, per ragioni diverse: banale conformismo, o ritegno prudente; reticenza o indiff erenza, vera o apparente che sia.
Un non voler vedere, un non voler sapere: una scelta di diniego se non di rimozione, che si risolve comunque nell’astenersi dal prendere posizione, dal passare a un intervento attivo. In questo contesto, maturano però anche altre scelte, dettate da attitudini discrete alla separatezza, da private secessioni, da progressive adesioni alla pratica di un silenzio che non è assenza, né rinuncia alla parola. Un silenzio che somiglia a quello degli animali.
Sono i narratori che via via compaiono in questi racconti, essi stessi coinvolti nelle vicende che riferiscono, a dover constatare l’emergere di questa generalizzata e diff usa propensione a chiamarsi fuori, o comunque a tacere, e a farvi in qualche modo argine contrapponendo il loro bisogno di rendere testimonianza di quanto accade.
È proprio la loro incapacità di allinearsi a quella sorta di omertà volontaria che sembra pervadere i comportamenti collettivi a fornire un’occasione essenziale e a off rire una motivazione di fondo alla scrittura.
Perché scrivere – lo ricorda Maria Zambrano – “è difendere la solitudine in cui ci si trova; è un’azione che scaturisce soltanto da un isolamento eff ettivo, ma comunicabile”.
Quelle che seguono sono le pagine iniziali di alcuni dei racconti.
Pappataci
Guarda… una cosa mai successa. Ero lì che stiravo. Tutt’a un tratto ho sentito… come un prurito, ma fortissimo: un bruciore, ecco. Come una scottatura, ma da grattarsi, da non farcela più a star fermi. Ho dovuto metter giù il ferro da stiro: sulla gamba era, dietro il ginocchio, che sai che se c’è un posto brutto quando ti pungono le zanzare… be’, una roba che… mi sono seduta e ho cominciato a grattarmi che non la finivo più… sì, certo che lo so, figurati: ero io a dirtelo sempre, ti ricordi? lascia stare, non grattarti che se no è peggio. Ma questa era un’altra cosa: da non resistere, ecco. Sì, due o tre segni rossi, appena un po’ gonfi, niente di speciale, semplici tossole a guardarle. Eh no, è questo il fatto: che qui di zanzare non ne abbiamo mai avute, tant’è vero che non abbiamo mai avuto in casa niente… non so, zampironi, o spray… Ah sì? A te era capitato quando andavi a caccia col papà? Be’, però lì eravate nell’umido, si capisce che c’erano zanzare e roba del genere, ma qui… No ti dico, non ne ho viste: è questo il fatto. Di zanzare neanche l’ombra… Ma no, figurati se sono andata nelle ortiche… a fare? Sì, va be’, ciao, sì, andrò in farmacia a prendere qualcosa… ciao… ciao…
Come al solito ho messo giù il telefono tirando un sospirone, di sollievo e di rabbia anche. Se non la liquidavi, a un certo punto, lei era capace di andare avanti ore con una telefonata, anche quando non aveva niente da raccontare. Come adesso: mezz’ora perché un insetto l’aveva punta! Che palle! Ma del resto, se non le ho fatto la telefonata giornaliera… è come se non mi sentissi a posto. Hai bisogno di soffrire, mi dice Mara. No, dico io: si deve prevenire il rimorso, inutile dire, dopo: pensare che quando c’era non le telefonavo mai povera mamma e cose del genere.
Stanotte mi sono svegliato di soprassalto: l’alluce destro, sul lato interno. Mi ero sognato che camminavo sui sassi e mi facevano male. Invece nel sonno mi ero grattato, un piede contro l’altro, e adesso non ce la facevo a star fermo. Mi giravo, mi rigiravo. Cercavo di non grattarmi più. Mi son messo un po’ di saliva dove mi prudeva di più, ma non serviva a niente. Stavo svegliando anche Mara col mio agitarmi. Allora mi sono alzato, sono andato in bagno: niente, un piccolo rossore. Solo quando sono stato lì, a guardarmi l’alluce alla luce del lavandino mi è tornata in mente la telefonata di mia madre. Vuoi vedere che… Ma no. Lei è in città, a trecento chilometri da qui, nel caldo della città. Qui siamo al fresco, in montagna… Eppure…
Neanche l’acqua fresca mi dava sollievo. Ho cercato di distrarmi. Ma cosa volevi fare lì, in una camera d’albergo? Tornare a letto, al buio, neanche parlarne, con quel tormento. Ho preso il giallo che avevo iniziato e mi sono seduto sul water chiuso, a leggere. Ogni tanto il piede nel bidè, sotto l’acqua. Ma non mi passava neanche così. Sono rimasto in piedi due ore prima di poter tornare a stendermi e addormentarmi.
E’ cominciata così, per quel che mi ricordo. E non è più finita. Ma non è sempre andata allo stesso modo. Allora, nei primi tempi, e ancora per un bel po’ dopo, non si faceva che parlarne. Tutti ne parlavano, o ne scrivevano: i giornali, le tivù. Adesso no. Non è che sia vietato, ma…
Allora sembravano tutte coincidenze, casi strani, accaduti solo a te, e dunque volevi saperlo se erano capitati proprio a te soltanto. Spiacevoli, certo, ma più che altro roba da far due chiacchiere, un po’ come il tempo e le stagioni. Era tutto un ma pensa te, ma non dirmi, sai che anch’io eccetera.
Poi sono cominciati i pareri degli esperti. Primi gli entomologi naturalmente: eravamo diventati tutti esperti delle diverse famiglie di pappataci, una parola che avevo già sentito ma che non avevo mai usato: mi sembrava goffa…
***
La bufera
Si guardano negli occhi. Non s’era mai accorto che l’asino ha gli occhi così distanti, ai due lati del muso: adesso che ce l’ha proprio di fronte vede che sporgono, a sinistra e a destra. Eppure, anche se messi in questo modo, lo guardano fisso.
Gli occhi, dell’asino, nei suoi. I suoi in quelli dell’asino.
Stava passando, a testa bassa, e non si era accorto. E’ stato l’asino a venir giù per il prato, di corsa. Ha raggiunto il filo spinato nel punto dove era arrivato lui in quel momento, e ha fatto il suo raglio. Quell’urlo appena tentato che poi, nel sentirsi, sembra si perda d’animo e finisca in quel resto di grido sconsolato che suona come una rinuncia, quasi che l’asino si fosse una volta di più convinto che non è il caso di continuare, né di riprovare.
Ogni raglio di asino sembra l’ultimo. L’ultimo tentativo, una prova cui ancora una volta non ha saputo resistere ma che non farà più.
E’ stato dopo, che sono rimasti lì a guardarsi negli occhi. Dopo il raglio e dopo che l’uomo è salito di un passo sulla proda e tenendosi a un paletto del filo spinato ha raggiunto con la mano la fronte dell’asino e ce l’ha tenuta un momento.
Adesso sono lì uno di fronte all’altro. Fermi. Passano almeno due o tre minuti prima che l’animale distolga lo sguardo.
L’uomo sente che ha fatto male. Non doveva insistere, doveva smettere prima lui di guardar fisso negli occhi l’asino. Ma è andata così.
Gli dà ancora un carezza. Nota che è un asina, non un asino.
Le dice arrivederci, ad alta voce.
Poi riprende a salire, ma sente i tonfi degli zoccoli dell’animale che lo seguono: cammina poco dietro di lui, lungo il sentiero che le sue zampe hanno scavato parallelo alla strada, appena di là del filo spinato.
L’uomo, quando arriva all’angolo dove la recinzione finisce, si impone di non girarsi a guardare l’asina. Sa che è là che lo guarda andarsene.
E’ una cosa che conosce e non sopporta. Lui che se ne va e qualcuno che lo guarda andarsene, e il cuore che gli si fa pesante della pena di quell’andare. Come se fosse, nello stesso tempo, quello che se ne va ma anche quello che rimane e guarda l’altro allontanarsi.
***
San Rocco
Anche la mia è una casa uscendo dalla quale, al mattino, si può decidere se andare da una parte o dall’altra.
La mia come tutte le altre case, si potrebbe osservare. In realtà, ce ne sono che non si possono dire di questo genere. Ne ho abitato alcune dalle quali si usciva per andare sempre e soltanto da una parte. Quella stessa in cui sto la maggior parte del tempo, in città, è una di queste. Essendo ai margini del centro storico, è verso quello che invariabilmente portano i passi. Si può anche prendere dalla parte opposta, naturalmente, ma è solo un diversivo: alla prima traversa si torna dalla parte che si era creduto di non aver scelto quella mattina.
L’altra casa, quella di cui dicevo all’inizio, si trova invece in un piccolo paese, uno dei cinque o sei che stanno sul monte sopra il lago. Non ce n’è uno più importante dell’altro, anche se ognuno si ritiene il migliore, per il panorama di cui gode, o la tranquillità che vi regna, o per le sue vie lastricate più di recente, o ancora perché – unico fra tutti – ha un ufficio postale.
In realtà – per me almeno, che non sono nativo del luogo ma ospite, o tale mi sento, anche se vi abito per qualche mese all’anno da più di un trentennio – più dei paesi sono altri i punti di riferimento. Quando si esce, al mattino, si può decidere, come dicevo: se andare dalla parte di San Valentino o da quella di San Rocco.
Si può, ho scritto. Ma, a dire il vero, certe mattine si deve.
Ci sono giorni nei quali si sa quel che si vuole. O meglio: si fa, si va. Senza bisogno di volerlo. Altri, invece, nei quali l’obbligo di scegliere si presenta di continuo, importuno, e quando, perplesso, scegli, è come se un altro l’avesse fatto al posto tuo. Giorni nei quali una cosa equivale all’altra, e allora tanto varrebbe non farne nessuna. Ma appunto questa è l’unica scelta che appare inammissibile.
E allora esco, ma ancor prima di raggiungere il cancellino mi rendo conto che non so da quale parte prenderò. Sono ormai sulla soglia e continuo a non saperlo. So solo che non potrò avviarmi da una parte, poi ripensarci e tornare sui miei passi. Quello no. Non so perché, ma sento che quello sarebbe passare il segno, un’eventualità di cui non saprei valutare le conseguenze.
E’ un istante quello in cui la sospensione si risolve in decisione. Un istante tanto breve, infinitesimale, che nessuno che fosse lì a osservarmi potrebbe cogliere un’ombra d’incertezza. Tanto breve, del resto, che neanch’io potrei dire con sicurezza di aver deciso.
***
L’aquila
Una course ha detto: venerdì facciamo una course, indicando dietro di sé, oltre la finestra, le montagne che chiudono la valle. Dolomiti all’aspetto: campanili e sfasciumi di roccia, solcati da rare lingue verdi di erba aggrappata al terreno quasi verticale.
Una course. Col mio poco francese ho chiesto la differenza con la promenade, la bonne promenade che mi auguravano quando mi vedevano andare a far un giretto fino alla sorgente della Clarée, un’ora di cammino, o su al rifugio della Buffere, poco di più. E la differenza con la balade: si erano complimentati con me due giorni prima per la balade che avevo fatto, da solo. Sei ore. Lo chemin de ronde del monte Thabor, che partendo in alto sopra i loro tre chalets – baite, diremmo noi, che loro avevano riadattato – arriva fino in fondo alla valle, sotto a quelle rocce che sembrano via via spostarsi, l’una nascondendo l’altra e lasciandola poi riapparire, per restare comunque sempre inarrivabili, al di là del confine dei luoghi fatti per gli uomini.
Ecco: una course era andare là, su quelle rocce. Non una passeggiata come la promenade o una gita come la balade. Una course era di più. Era un’ascensione.
Mi sono subito reso conto, già mentre cercavo le parole per fare la domanda, che quella mia curiosità lessicale non era che un modo per differire un cortese ma fermo no. No: non è cosa per me. Magari un’autoironica ammissione dei miei limiti, o – perché no? – della mia paura: mi era sembrata questa la strada quando Marie, la moglie di Albert, aveva buttato lì un cauto mais… le vertiges: lei c’era andata lassù, col marito. Fino a pochi anni prima l’aveva accompagnato sempre, prima di rinunciare alle courses, e poi anche alle balades.
Lui però non ha raccolto, come si trattasse d’una obiezione tanto futile da non meritare neanche un cenno di risposta, e non m’ha dato tempo di confermare che sì: io soffro di vertigini e dunque…
Ha invece continuato in quel che stava dicendo, lasciando anzi il suo tono pacato e dimenticandosi di parlar lentamente, come faceva di solito, in modo da farsi capire anche da me, perché Francesca, mia moglie, il francese lo parla bene, ma io no.
Di quel che diceva ho colto solo un hors du sentièr, accompagnato dal gesto del braccio e della mano tenuti quasi a novanta gradi, e mi era sembrato un po’ sinistro il suo sorriso nel dire di questo andar fuori dal sentiero per arrampicarsi su pendii che era facile immaginare quanto ripidi anche solo guardandoli da lontano.
E cos’è successo? E’ successo che ho detto va bene. Non gli ho detto che lo ringraziavo della fiducia ma là non ci andavo, non me la sentivo di andarci. E non è che non l’ho detto solo perché per me era difficile da dire in francese, una roba del genere.
Ma cosa gli era saltato in mente di propormi, anzi, di decidere, un’impresa del genere? Lui stesso era qualche anno che non ne faceva di simili… E cosa diavolo mi aveva impedito di tirarmi indietro?
***
Racconti a Parigi
La domenica, la domenica pomeriggio, si vede chi è solo e chi no. O meglio: chi vive solo e chi vive con una moglie, con dei figli. Il che non implica necessariamente che sia solo, o che tale si senta.
Le persone sole, nei giorni feriali, camminano come tutti gli altri. E come tutti gli altri guardano davanti a sé. Verso una loro meta. La casa, il lavoro, un impegno preso in un certo posto con una certa persona. La domenica pomeriggio, invece, camminano lente, e si guardano in giro. Guardano attente – come a studiarli, a cercar di definire una differenza decisiva – quelli che non sono soli, o che tali non appaiono.
Anche questi ultimi camminano lenti, a differenza che nei giorni feriali, ma guardano avanti a sé, anche la domenica, non però verso una meta. Guardano avanti ma come non vedessero, o come se avessero già visto tutto. Un po’ come i ciechi, che non vedono niente, o non hanno mai visto niente, se ciechi dalla nascita, o vedono, a loro modo, qualcosa di completamente diverso da tutti gli altri. Che magari non è come non vedere niente.
Quelli che vanno a passeggio con la famiglia non mostrano attenzione. Tutt’altro. Sono distratti. Distratti da un vuoto che, a differenza di chi è solo, non possono immaginare di riempire.
Chi è solo può essere triste. Chi non è solo, ma tale si sente, no. E’ distratto, appunto Se è triste, non lo sa.
Mica male. Non importa se è vera questa cosa delle persone sole e non sole. Vorrebbe scrivere tutti pezzi così. Brevi. Semplici. Che però danno l’idea che sa vedere quello che c’è intorno.
***
Racconto n° otto
Stamattina, come ogni mattina, s’è svegliato poco prima delle sette.
E’ rimasto a letto una mezzora, ma non per cercare nei sogni di quella notte qualcosa di utile per i suoi racconti. Più di una volta gli era accaduto che aprendo gli occhi addirittura un’intera storia si fosse formata durante la notte nella sua mente, nella forma d’un sogno già disposto in modo da essere trascritto. O almeno si era ritrovato con uno spunto: il sogno gli aveva portato una figura, una voce, un luogo, e sempre, ad accompagnarli, un senso di consolazione o di disgusto. Niente mezze misure: conforto o nausea. Senza un perché. Ed era capitato che cercare quel perché diventasse scrivere un racconto.
Ancor prima di alzarsi trascriveva allora sui suoi foglietti – ne teneva ovunque, anche sul comodino naturalmente, o più spesso sul letto stesso, dalla parte lasciata vuota dalla moglie – quel che aveva in testa, poche parole, spesso nella forma di un incipit, e solo dopo, magari non quella stessa mattina, gli riusciva di farne nascere qualcosa. Era, questa dei sogni, una risorsa di cui si era compiaciuto di parlare in pubblico, anche durante le presentazioni dei suoi libri, e s’era accorto che faceva sempre effetto. Creava un ponte fra lui e chi ascoltava – tutti dormono, e sognano – ma nello stesso tempo sottolineava la sua diversità, l’unicità del suo talento. Solo lui sapeva mettere a frutto quel che il sonno portava anche agli altri.
Non cerca più, da parecchio tempo, fra i brandelli di sogni che gli restano. Non fanno a tempo a comparire e già gli si squagliano nella memoria. Neanche brandelli. Sensazioni. Sogna ma è come non sognasse più. Le benzodiazepine arruffano i pensieri della notte e li fanno d’una materia densa e viscida, grigiastra, che si disperde alla prima luce.
Non dormire più non era meglio, del resto. Oltre a non sognare si ritrovava poi a cadere da un pisolino all’altro durante il giorno. La testa vuota fra uno sbadiglio e l’altro. Del tutto sprovvisto di quella fiducia benevola, verso di sé, senza la quale non si può scrivere nulla, neanche pensare di poterlo fare. Neanche desiderarlo.
![]() Se vuoi leggere il libro nella sua interezza lo puoi acquistare alla nuova libreria Rinascita di Brescia (10 euro).
Se vuoi leggere il libro nella sua interezza lo puoi acquistare alla nuova libreria Rinascita di Brescia (10 euro).
Via della Posta, 7 – 25121, Brescia
Tel. 0303755394
libri@nlr.plus
Se vuoi riceverlo a casa puoi inoltrare il tuo ordine indirizzandolo a: ordini@secondorizzonte.it
e segnalando l’avvenuto versamento dell’importo indicato tramite bonifico sul conto corrente della libreria (IBAN: Unipol Banca – Agenzia di Brescia: IT 10 B 031 2711 20000000000 1851).
La spedizione non comporta aggravi di spesa.
Dal Giornale di Brescia dell’8 giugno 2015.
Clicca sull’immagine per visualizzare l’articolo.
Da Bresciaoggi del 3 ottobre 2015.
Clicca sull’immagine per visualizzare l’articolo.
Dal Corriere della Sera del 10 ottobre 2015.
Clicca sull’immagine per visualizzare l’articolo.
*Intervento al Convegno Il lavoro che trasforma il mondo, organizzato nell’ambito della mostra promossa dalla Cgil di Brescia CapoLavoro. Arte e impegno sociale nella cultura italiana attraverso il Novecento (Brescia, Museo di Santa Giulia, 10 ottobre-10 dicembre 2014)
Oltre la dimensione economica e tecnica che lo connota, al lavoro ne va riconosciuta una culturale: la sua considerazione, la sua promozione, il ritenerlo un diritto non negoziabile – e di più: una delle condizioni che fondano la relazione con gli altri – non dipendono solo dal grado di sviluppo tecnologico, dall’andamento dell’economia e dallo stato dei rapporti fra le parti sociali e le loro rappresentanze, ma anche dal posto che esso occupa nella mentalità diffusa.
Indipendentemente dal fatto che il lavoro dei contadini di pianura e di montagna ha costruito grande parte del paesaggio e che il lavoro degli artigiani ha fornito i presupposti di gran parte del nostro vivere quotidiano e continua a svolgere in questo senso un ruolo essenziale assicurandone la continuità, è innegabile che il lavoro che trasforma il mondo – stando all’immagine che il titolo di questo incontro evoca – rimanda al lavoro industriale, al lavoro che maneggia la materia di cui il mondo è fatto cambiandone natura e forma. Ma è proprio l’immagine del lavoro industriale che oggi evidenzia i segni di un appannamento della sua presenza nel sentire collettivo. Un appannamento che torna in questi ultimi tempi a farsi divaricazione dei modi di rappresentare il lavoro, il lavoro operaio in particolare: per gli uni componente e per molti aspetti matrice delle sperimentazioni della democrazia, per altri residuo di una società scomparsa (si pensi a come si parla degli anni Settanta, quasi fossero una sorta di preistoria, quasi non appartenessero alla storia del paese, e non fossero ancora memoria viva).
Continua a leggere Pensiero del Presente / Il lavoro nella cultura e nell’immaginario attuali*

È bene dirlo all’inizio. Se fossi vissuto negli anni ’80 dell’Ottocento, e per di più a Parigi, temo che sarei stato fra coloro che guardarono con diffidenza o aperta ostilità la costruzione della Tour Eiffel, emblema ingegneresco dell’Esposizione Universale del 1889. Non mi sarei trovato in cattiva compagnia, c’è da dire. Guy de Maupassant e Alexandre Dumas figlio si schierarono senza remore contro “l’inutile e mostruosa Tour Eiffel”. Quanto ai pittori, se Seurat manifestò la sua approvazione ritraendola quando ancora le mancava l’ultimo piano, Pissarro ci tenne a non raffigurarla mai nei suoi quadri.
Difficile comunque, oggi, confondersi fra quei parigini – una sparuta minoranza di certo – che si ostinano a chiamare la Tour che domina la loro città “l’asparago di ferro”. Come non essere d’accordo con un maître à penser, certo non di bocca buona, come Roland Barthes, al quale la creazione di Gustave Eiffel appariva un “edificio inutile e insostituibile, testimone di un secolo e monumento sempre nuovo, oggetto inimitabile e incessantemente riprodotto”?









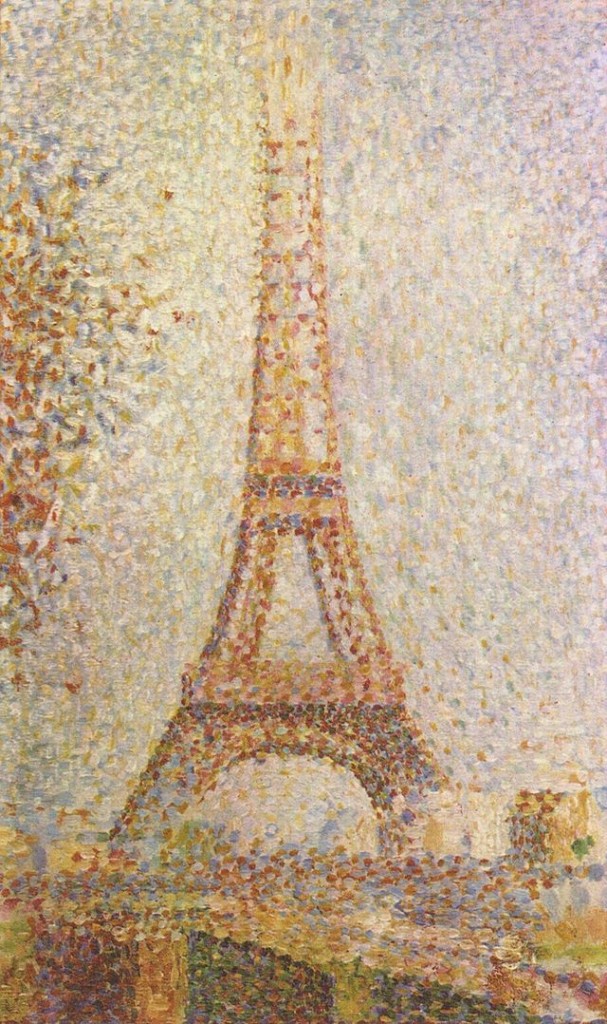

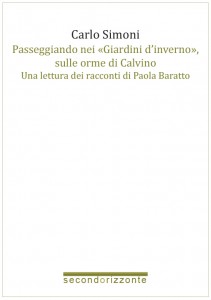
(* Paola Baratto, Giardini d’inverno, Manni 2014)
Da dove viene il senso di leggerezza – e di conforto, vorrei dire: di quieta fiducia – che ci resta dopo la lettura di questi racconti, come dopo una passeggiata. breve e ristoratrice? Non certo dal fatto che si tratti di una lettura scacciapensieri. E perché conserviamo una simpatia solidale con i personaggi che abbiamo incontrato? Personaggi che sono lontanissimi dai modelli di vincenti che molto spesso ci vengono proposti più o meno esplicitamente come termini di identificazione, e che dichiarano questa loro estraneità sin dai nomi che portano, nomi comuni (Nino, Irma, Bianca, Fausto, Giulia, Adele) o che suonano addirittura un po’ prosaici, fuoricorso (Biagio, Martino, Gabriele), quasi se ne fosse voluto sottolineare la non eccezionalità. Uomini e donne miti, modesti, e tuttavia animati da una ferma consapevolezza della propria diversità e della necessità di proteggerla. Con discrezione. Ecco la parola: sembrano personaggi ritagliati da un libro, recensito da “La Repubblica” qualche mese fa ma non ancora tradotto in italiano: La discrétion, di Pierre Zaoui, pubblicato dalle parigine Édition Autrement. Vi si parla di persone che praticano “una forma felice e necessaria di resistenzan. (…) lontana dalla dissimulazione, dal calcolo prudente, o dalla paura d’esser vista, l’anima discreta offre una giusta presenza al mondo”. La discrezione: “l’esperienza di un tempo modesto che basta a se stesso”. Non una qualità da esibire, né un atteggiamento che possa generalizzarsi, dal momento che si tratta di un andar controcorrente: “la nostra modernità – sostiene Zaoui – non pare caratterizzarsi solo per una lotta sfrenata per il riconoscimento e la visibilità, ma in pari grado per una lotta sotterrane, più calma ma molto tenace, per l’anonimato et l’invisibilità.” Un fare sotterraneo, deciso ma tranquillo, non appariscente: non sono avventure eclatanti quelle che i personaggi di Giardini d’inverno vivono. Vicende, piuttosto, nelle quali si rapprende uno stile di vita in grado di farsi testimonianza che contraddice la banalità dei discorsi e il conformismo dei comportamenti, e per questo suscita timore. Perché “ciò che è banale ha l’unico merito di essere rassicurante”, e ciò che non lo è non solo può inquietare, ma suscitare osservazioni sarcastiche, sdegnose prese di distanza, o addirittura reazioni ostili (la signora che veste “come se fosse sgusciata da una cartolina seppiata degli inizi del Novecento” “non dovrebbero lasciarla andare in giro”, e l’uomo che si costruisce una casa piena di finestre e lucernari, vedrà la sua “casa di vetro” presa a sassate).
Man mano che si procede nella lettura si comincia a sentire una medesima aria circolare fra le pagine dei racconti che si susseguono, un significato che li accomuna, un gioco di rimandi che li tiene saldamente insieme, senza che si ricorra all’espediente ormai collaudato di far incontrare, a un certo punto, tutti i personaggi, come avviene in tanti film, francesi soprattutto. I protagonisti di Giardini d’inverno marciano ognuno per la propria strada. Solo in un paio di casi si incrociano, comparendo uno nel racconto dell’altro ma senza interferire più di tanto. Per il resto, si attengono a una coerenza che ogni inizio di racconto ci presenta come un tratto di lungo periodo, da tempo praticata. Non enunciata, da chi scrive, ma che sta al lettore intuire dai gesti e dalle parole, poche, dei personaggi.
Si tratta di “collezionisti” nei quattro racconti della prima sezione, di sognatori o abitanti di “altrimondi” nella seconda, di ascoltatori attenti della “lingua delle cose mute” nell’ultima. Tutta gente che nello scegliere tra l’avere e l’essere non hanno dubbi. Non occorre possederle le case in cui ci piacerebbe abitare: basta assegnare ad ognuna il mese in cui preferiremmo farlo. E sono del tutto immateriali i pezzi che insegue la collezionista di stagioni, riconoscendole nel suono struggente dei garriti delle rondini, in profumi e odori evanescenti, nella sensazione tattile del velluto di muschio che avvolge il tronco di una pianta: non è la contemplazione della caducità che la donna coltiva, ma proprio il suo opposto. Lei, delle stagioni cerca “quello che non cambia”: nel loro divenire scova l’essere. L’essere di un tempo ciclico, e già questo rappresenta a ben vedere uno scarto, non una contestazione ma uno scostamento netto rispetto al tempo rettilineo che imperativamente ci domina, sin nel profondo.
Così come dilagante e contagioso è l’uso distratto, omologato delle parole: occorre riconoscerne la fisionomia, verificarne la rispondenza con noi stessi, apprezzarne addirittura la carica erotica per farne oggetto di collezione, e in questo modo contrastarne l’usura. Ma è altrettanto possibile e motivato raccogliere invece sassi, uno diverso dall’altro e anche per questo suscettibili di farsi segno della unicità di ognuno di noi, memoria inconfondibile di chi se n’è andato. E’ difficile non ritrovare in questa sensibilità, che ravvede significati umani anche nell’inorganico, una suggestione analoga a quella che doveva aver mosso l’anonimo collezionista di sabbia – sabbia grigia del Balaton, bianchissima del Siam, rossa del Senegal – la cui opera Italo Calvino aveva visto a Parigi (e dove se no… Parigi è punto di riferimento ricorrente nei racconti di cui parliamo). Un collezionista, quello, che è inevitabile sentire fratello della Irma che raccoglie sassi. Un collezionista, spiega Calvino, che “sapeva dove voleva arrivare: forse proprio ad allontanare da sé il frastuono delle sensazioni deformanti e aggressive, il vento confuso del vissuto”.
Ma in fondo non è proprio questo l’orizzonte non solo di Cuore di pietre, ma anche degli altri racconti di Paola Baratto? Non è questo il filo che ne fa un unico romanzo? “Come nelle poesie e nelle canzoni le rime scandiscono il ritmo, così nelle narrazioni in prosa ci sono eventi che rimano fra loro”: è lo stesso Calvino a ricordarcelo in una delle sue Lezioni, quella sulla rapidità.
Senza trascurare altri fili, certamente. Situazioni che tornano e via via si precisano nella ricchezza dei loro significati. Il silenzio innanzitutto. Non un vuoto, tutt’altro, essendo che “se la musica è ordita da innumerevoli combinazioni di note, lo stesso vale per il silenzio” (parole che sembrano quelle di Mario Brunello, nel suo trattatello recentemente dedicato, appunto, al silenzio).
Basta saperlo ascoltare, il silenzio. Sarà allora possibile rendersi conto che “anche il più piccolo frutto maturo possiede un suo relativo fragore, nell’istante in cui spacca la buccia”, e che non c’è “nulla di più variegato e multiforme del tacere degli esseri umani” (mi torna in mente quell’aneddoto dell’incontro fra Borges, ormai cieco, e Calvino, che la reverenza per il maestro rende più taciturno del solito: “L’ho riconosciuto dal suo silenzio”, risponde più tardi Borges a chi gli domanda come ha fatto a capire che fra le persone che erano andate a visitarlo c’era anche lo scrittore italiano).
Il silenzio, parente stretto della trasparenza (“il vetro è trasparente come il silenzio, tutto lo attraversa”), ma anche delle ombre, “quel risvolto inseparabile dai corpi, dalle cose”, presenza silenziosa, “gemello muto” degli esseri viventi. E’ fotografando le ombre dei suoi clienti che Adele ne coglie i sentimenti inespressi, o inconfessabili, così come è guardando attraverso la nebbia che avvolge la sua casa di pianura che Fausto impara a “leggere tra le righe delle frasi dette per calcolo, per compiacenza, per ipocrisia”.
Un altro tratto comune ai protagonisti: la calma, la lentezza. Di fronte ai capolavori pittorici conservati nei musei Bianca – che non è una monaca, ma un’”ispettrice in ambito turistico”, costretta dal suo lavoro “a spostarsi da una città all’altra”- si concedeva d’indugiare”, “si godeva la pausa”, e uscita dal museo amava il “passeggio senza meta”, la flânerie, ma anche il sostare “dietro le vetrine scintillanti d’una brasserie, ch’era poi, ugualmente, una forma di flânerie sedentaria”. E’ questa propensione alla lentezza che le permette di abitare i quadri che ama, di “inoltrarsi dentro una dimensione temporale cristallizzata, esclusa dall’ingranaggio inarrestabile dello scorrere”.
Non solo le opere d’arte, però, rappresentano interlocutori essenziali. Anche le cose suscitano una pietas che sa interpretare la loro “lingua muta”, e fra di esse soprattutto gli “oggetti vecchi, ossidati, opachi” (come capitava a Brecht: “Fra tutti gli oggetti i più cari”, notava, “sono per me quelli usati. Storti agli orli e ammaccati…): “gli utensili dozzinali d’uso quotidiano” per i quali Gabriele sente “una specie di pena” e che esita a buttar via, che raccoglie addirittura quando li vede abbandonati vicino a un cassonetto dei rifiuti, “relitti domestici senza più domus”.
Motivi e atteggiamenti che, si diceva, danno unità ai dodici racconti (solo dodici purtroppo), ma che non si limitano a questo. O meglio: se questo è il loro effetto è perché non sono che gli aspetti di una stessa critica. Una critica che non si vuol argomentare, che resta lontanissima da ogni intento di persuasione e ancor meno di polemica. Si direbbe che l’autrice condivida la propensione di Adele, la “fotografa delle ombre”, che “da qualche tempo disertava la chiarezza e preferiva lasciare ad altri l’incombenza spugnosa delle spiegazioni”. Non è lo sguardo che si accanisce criticamente quello che si è indotti da questa lettura a rivolgere al nostro mondo. E’ invece uno sguardo che sa cogliere qui dove siamo l’altrove di cui avvertiamo un bisogno vitale. Un altrove in cui regnano – ripetiamolo – il silenzio, la trasparenza, le ombre, la lentezza: basta pensarne il contrario e si ricavano, per contrasto, i caratteri del mondo in cui viviamo: il rumore e la chiacchiera, l’ opacità e insieme la luce cruda e abbagliante che illumina le merci (cioè tutto, tendenzialmente), la velocità ossessiva, la non affezione per le cose che usiamo e gettiamo.
Uno sguardo capace dunque di pazienza e fermezza insieme, di spietatezza e dedizione allo stesso tempo. Ma che soprattutto sa rivolgersi sempre indirettamente a ciò che osserva. Allo stesso modo di Perseo, che non posa i suoi occhi “sul volto della Gorgone ma solo sulla sua immagine riflessa nello scudo di bronzo”, in ciò offrendoci “un’allegoria del rapporto del poeta col mondo, una lezione di metodo da seguire scrivendo”: “è sempre in un rifiuto della visione diretta che sta la forza di Perseo – siamo alla Lezione sulla leggerezza adesso – ma non in un rifiuto della realtà del mondo di mostri in cui gli è toccato vivere, una realtà che egli porta con sé, che assume come proprio fardello.”
Ecco. Prendere le distanze dalla realtà del mondo è forse il modo (l’unico, oggi?) per non nascondersi l’inevitabilità di portarne il fardello.
Gira e rigira è sempre a Calvino che mi riportano i passi che muovo in questi Giardini d’inverno, a conferma del fatto che “la leggerezza è qualcosa che si crea nella scrittura”, in una scrittura come questa, prova convincente e viva della “funzione esistenziale” che può avere la letteratura quando si fa “reazione al peso del vivere”.
E’ solo a questo punto che quel senso di conforto, e di pacata fiducia, di cui dicevo all’inizio mi si chiarisce, e posso individuarne la fonte: nella voce che trascorre in queste pagine. La voce che con parsimonia i personaggi fanno sentire è la stessa che guida la scrittura di questi racconti. Apparentemente svagata, mai assertiva, e pure decisa nella sua scelta.
Ancora Calvino, quello delle Città invisibili stavolta: “L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio.”
È questo secondo modo che Paola Baratto ha scelto. Di qui viene la voce che ci ha dato questi sommessi, poetici minima moralia.
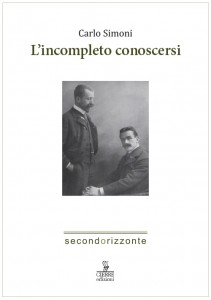
Questo libro inaugura la collaborazione fra Secondorizzonte e la casa editrice veronese Cierre edizioni, che dalla metà degli anni Ottanta opera nel campo dell’editoria di approfondimento e qualità.
Una situazione “scabrosa e singolare” quella di persone “che si conoscano solo attraverso lo sguardo”: la richiama Thomas Mann nella Morte a Venezia, notando che è proprio da questo loro “incompleto conoscersi che nasce il desiderio”.
È quanto accade al protagonista, dodicenne, di questo romanzo quando incontra Heinrich e Thomas Mann, durante un loro soggiorno di cura a Riva del Garda, ed è lo sguardo del secondo a colpirlo: “alzava gli occhi a guardare il lago, però si vedeva che guardava più lontano. O non guardava neanche… Certo è che non mi avrebbe tanto colpito lo sguardo che quel signore, improvvisamente giratosi dalla mia parte, mi rivolse, se non ne avessi prima notato quel modo di guardare…”.
L’incontro, insieme a quello che si ripeterà anni dopo a Viareggio, durante un altro periodo di vacanza dello scrittore, segna la vicenda del protagonista, rivelandogli una “forza, che fino a quel momento non aveva mai sospettato di possedere” e che si traduce nel desiderio di sfuggire alla vita che il destino familiare gli offre. Un desiderio che conoscerà diversioni ma si manterrà in qualche modo fedele a se stesso e lo condurrà, prima bambino, poi giovane, a riattraversare la storia drammatica della propria famiglia da un lato, e dall’altro a intraprendere un lungo e complesso itinerario di conoscenza di sé.
Quella che segue è la pagina iniziale del romanzo.
A dodici anni portavo ancora i capelli lunghi come quando ero piccolo. Così voleva mia madre, che nei mesi precedenti la mia nascita s’era convinta che stava per veni- re al mondo la bambina che desiderava da sempre. Invece ero arrivato io, e lei mi teneva a quel modo i capelli, fin sulle spalle, e prima di uscire con mio padre, la domenica, me li lisciava con una spazzola che usava solo per me, e poi mi metteva un poco di rossetto sulle guance e non ancora contenta si inumidiva di saliva l’indice e il medio d’una mano e me li passava sulle sopracciglia.
Quanto agli abiti mi vestiva come un maschio, ma i capelli voleva che restassero così, e mio padre aveva smesso di protestare. C’era un patto fra loro, da tempo. Che quando sarei entrato in fabbrica anch’io, il giorno prima lui mi avrebbe portato dal barbiere, e non dall’Amedeo, che stava al Varone, ma dal barbiere Bonometti, quello giù in città. Perché il taglio doveva essere perfetto.
Se mi si chiedesse che cosa ne pensavo io, non saprei rispondere. O direi che ad avere i capelli lunghi ero abituato. E comunque la cosa non mi interessava poi tanto. Come se riguardasse un altro. Quella saliva sulle sopracciglia e quei pomelli rossi, quelli sì mi davano fastidio, e cercavo di divincolarmi quando mia madre me li imponeva. Ma i capelli no. Non escludo che in fondo mi ci sentissi a posto. Li avevo sempre avuti così e non badavo a quelli degli altri ragazzi, a scuola: sarebbe stato come sentirmi diverso perché il mio naso, o il colore degli occhi o la forma delle orecchie non erano uguali a quelli di un altro. Quello ero io, e basta. Coi capelli lunghi e ancora biondi del biondo che poi coll’età scurisce. Ma questo non lo sapevo, allora. Non sapevo molte cose allora.
Continua la lettura nel pdf:
![]() Se vuoi leggere il libro nella sua interezza lo puoi acquistare alla nuova libreria Rinascita di Brescia (10 euro).
Se vuoi leggere il libro nella sua interezza lo puoi acquistare alla nuova libreria Rinascita di Brescia (10 euro).
Via della Posta, 7 – 25121, Brescia
Tel. 0303755394
libri@nlr.plus
Se vuoi riceverlo a casa puoi inoltrare il tuo ordine indirizzandolo a: ordini@secondorizzonte.it
e segnalando l’avvenuto versamento dell’importo indicato tramite bonifico sul conto corrente della libreria (IBAN: Unipol Banca – Agenzia di Brescia: IT 10 B 031 2711 20000000000 1851).
La spedizione non comporta aggravi di spesa.
Dal Corriere della Sera-Brescia del 26 novembre 2013.
Clicca sull’immagine per visualizzare l’articolo.
Dal Corriere del Trentino del 20 novembre 2013.
Clicca sull’immagine per visualizzare l’articolo.
Dal Giornale di Brescia del 26 novembre 2013.
Clicca sull’immagine per visualizzare l’articolo.
Da Bresciaoggi del 28 novembre 2013.
Clicca sull’immagine per visualizzare l’articolo.
Da Gruppo 2009, 3 febbraio 2015.
Clicca sull’immagine per visualizzare l’articolo oppure qui.
Da AB inverno 2015.
Clicca sull’immagine per visualizzare l’articolo.

Il luogo innanzitutto: la lontana Lipari, lontana e sperduta ma non tanto da non poter stabilire contatti con la rete dei fuoriusciti antifascisti che stavano a Londra e a Parigi. E in quest’isola, che possiamo immaginare immersa nella luce e nel sole della primavera mediterranea, degli uomini, che vi sono stati confinati dal regime, e si presentano ognuno con i loro carattere, il loro stile specifico. C’è il metodico, il tipo che appare “incapace di alterare le proprie abitudini”, e quell’altro che con i suoi gesti quotidiani offre di sé “l’immagine di un uomo tutto dedito allo studio e alla famiglia”.
In realtà – e lo scopriamo presto, magari in una scena in cui li vediamo confabulare tra loro – stanno inscenando una rappresentazione per i loro sorveglianti. Impersonano una parte studiata appositamente.
Sembra l’inizio di un romanzo di Graham Green, o il soggetto di un film. A me vengono in mente i personaggi della Grande fuga – e del resto la storia che uno di questi uomini scriverà anni dopo, in inglese, si intitolerà Escape: fuga, appunto – quando appena evasi dal campo di concentramento assumono le sembianze di tranquilli cittadini tedeschi. Ma anche prima, quando sono ancora prigionieri e architettano la loro impresa, i personaggi del film sembrano vicini ai confinati di Lipari che osservano i metodi dei servizi di vigilanza, studiano orari e percorsi, addirittura si esercitano al nuoto, perché è da un’isola che devono fuggire. E fra questi uomini non manca naturalmente la figura femminile, la moglie di uno di loro, che li appoggia approfittando della relativa libertà di cui gode in quanto inglese.
Poi però, come in ogni trama romanzesca che si rispetti, l’imprevisto: il piano salta, il proposito di buttarsi in mare, nel pieno della notte, e farsi raccogliere da “un’imbarcazione veloce in grado di sottrarsi all’inseguimento dei MAS” – e qui pregustavamo già un inseguimento spettacolare, questa volta alla Fleming – non risulta attuabile. Altri confinati – che ci piace immaginare sprovveduti e impazienti, giovani e spavaldi, incapaci di adeguarsi alla preparazione metodica di quegl’altri – mettono in allarme le guardie.

Come scrive uno storico? i suoi procedimenti sono del tutto diversi da quelli del romanziere o ci sono punti di contatto?
Perché alcuni libri di storia, al di là delle notizie che contengono e del rigore del metodo in essi impiegato, coinvolgono il lettore e altri no?
Domande che nascono in chi legge saggi storici come in chi si è trovato a scriverne (non importa se a scala locale), e che sottendono questioni di fondo attinenti al significato stesso della ricostruzione storica e, in senso più generale, al nostro rapporto con il passato.
Domande che rimandano a una lunga e non conclusa discussione che ha visto impegnati filosofi e storici, e che ha portato alcuni studiosi a sostenere che la storia non è che un genere letterario, e dunque è necessario che anche gli storici che non l’hanno finora fatto tornino (dopo aver cercato di imbrigliare le loro ricostruzioni storiche nelle reticoli di teorie di diversa ispirazione) alla narrazione.
Ma più di questo dibattito – intrigante e intricato: una buona ricostruzione si trova in La teoria della storiografia oggi, di Paolo Rossi, pubblicato dal Saggiaore nel 1983 – se si vuol cercare di rispondere alle domande iniziali occorre chiedersi se la narrazione non sia tanto una scelta che lo storico fa o non fa quando, letti e analizzati i suoi documenti, prende in mano la penna, ma piuttosto non sia l’unico modo che ha a disposizione per costruire il suo discorso, o addirittura l’unica via per dargli consistenza; capacità conoscitiva rispetto al passato e persuasiva rispetto al lettore; coerenza e rigore, sia pure in un modo diverso da quello delle scienze esatte.
Sembra di questa idea Hannah Arendt (in Vita activa. La condizione umana): “Chi parla di ciò che è stato racconta sempre una storia”, dice, e non usa il termine history, la storia in quanto disciplina, studio del passato, ma story, che significa storia nel senso di racconto, trama, narrazione (e anche, come in italiano, fandonia, bugia).
D’altra parte – e reciprocamente, si potrebbe intendere – Paul Ricoeur, nella sua opera monumentale Tempo e racconto, sostiene che “raccontare una qualsiasi cosa vuol dire raccontarla come se fosse accaduta”.


Il ritardo che segnò la comparsa della grande industria in Italia fece sì che nel nostro paese la grande trasformazione si avviasse in un periodo nel quale la tendenza artistica dominante si stava ormai orientando in una direzione poco propensa ad ammettere la fabbrica fra i soggetti della pittura, mentre erano del resto quelli tradizionali che il gusto diffuso, e il mercato dell’arte, continuavano a prediligere: le ragioni addotte per spiegare la scarsa presenza dei luoghi del lavoro industriale nella pittura italiana possono probabilmente essere trasferite in qualche misura al caso bresciano.

Al confronto, orientarsi fra sunniti e sciiti, e nelle nuove strane alleanze nei paesi arabi è facile. Noi, lettori di giornali e spettatori di tg, capiamo poco o niente, invece, di quel che succede in Africa, e quando succede di incontrare qualcuno che c’è stato e ne parla dunque per esperienza diretta, l’impressione di un’insormontabile difficoltà a metter ordine in quel che ci viene raccontato prevale. Soprattutto quando chi riferisce quel che ha visto non è né un turista né un volontario che per uno o due mesi si è aggregato a un’iniziativa umanitaria o a una missione. Quando si tratta di una persona che là ci sta stabilmente, da anni, è l’immagine di un mondo complicato all’inverosimile, il senso di una diversità incolmabile rispetto a quel che conosciamo, che ci si riversano addosso, e ci fanno d’improvviso sentire il nostro tremendo ritardo o, per meglio dire, l’estraneità, l’astrattezza, l’approssimazione di quel che credevamo di sapere dell’Africa.
E’ quanto mi è capitato parlando con *** (“non scrivere il mio nome, non mi interessa: faccio il mio mestiere come uno lavora in banca o insegna a scuola…”). Bresciana, sociologa (laurea a Trento poco più d’una ventina d’anni fa), e ora funzionaria Onu. Tredici anni di lavoro. In Kosovo, Costa d’Avorio, Iraq, Sud Sudan, e oggi nel Nord Kivu, una provincia – ricchissima di minerali – della Repubblica Democratica del Congo che confina con Uganda e Ruanda.
Funzionaria è però termine generico. Lei è una delle migliaia di peacekeepers. Peacekeepers: donne e uomini il cui intervento è finalizzato a “mantenere la pace”. Questo significa peacekeeping, secondo la definizione data dall’Onu stessa: “un modo per aiutare paesi tormentati da conflitti a creare condizioni di pace sostenibile”. Da non confondersi dunque, i peacekeepers , con gli esportatori di democrazia. Non fanno notizia il “disarmo e reinserimento di ex combattenti” ossia, in concreto, il cercare di convincere i guerriglieri dei vari eserciti irregolari a disertare. A tornare a casa, perché la maggior parte di loro vengono da altri paesi. Fra quelli dell’M23, uno dei tanti gruppi combattenti – è anche con quelli che l’unità cui appartiene la mia interlocutrice ha a che fare – ci sono ruandesi e ugandesi, ad esempio. Un lavoro di moral suasion si potrebbe allora definire il suo? No, non lo definirebbe così ***, perché non sono discorsi generali, di principio, che si rivolgono a queste persone. Li si invita piuttosto a badare a quel che conta, a riprendersi la loro vita, atornare a casa appunto, promettendogli l’aiuto necessario, portandogli le prove che altri hanno scelto di farlo e ci sono riusciti e adesso stanno bene, si fa per dire.
La ascolto mentre mi spiega che hanno quindici siti dislocati nel Nord Kivu, accanto alle basi militari ONU – è qui che i guerriglieri che vogliono disertare possono farlo in sicurezza – e usano cinque radio mobili, dalle quali trasmettono messaggi ai guerriglieri, nelle varie lingue locali. Poi mi mostra il video, realizzato artigianalmente, di un altro tipo di azione: il lancio di volantini dall’elicottero. Sorvolano zone montuose e verdissime, in cui la vegetazione è interrotta qua e là da villaggi che la distanza – per quanto l’elicottero voli a bassa quota – fa somigliare a villaggi vacanza (saranno i bungalow. o quelli che tali i sembrano, o il paesaggio invitante in cui sono immersi, ma l’impressione è quella). I volantini sciamano verso terra e si vedono ragazzi che corrono a raccoglierli, come si faceva, bambini della colonia marina, quando sopra la spiaggia passava l’aereo della pubblicità del dentifricio. I guerriglieri no, non si vedono: sono dentro quel verde che attornia i villaggi, ma ce ne sono anche mescolati ai civili. Non si lasciano vedere comunque, e però quei volantini li leggeranno: migliaia di loro hanno già disertato.
Ma come si è arrivati a una situazione del genere? Inevitabile chiederlo, ma ecco che di nuovo la confusione, che mi pareva di aver un po’ superato in quel racconto di messaggi radio lanciati nel fitto della foresta e in quelle immagini colorate di luoghi e persone, torna a dominare. Vicende di alleanze e tradimenti, di generali e dittatori che si fan fuori l’un l’altro, di eserciti che spuntano dal nulla, di scontri ed eccidi di cui non si riesce a fissare la successione mentre ancora te ne parlano.
Credevi di sapere qualcosa dei posti dove *** e i suoi compagni lavorano perché ti erano rimaste impresse le immagini di Hotel Ruanda, il film sul genocidio perpetrato dalla maggioranza Hutu sulla minoranza dei Tutsi (un milione di morti, nel ’94). E ti accorgi che quella tragedia non è finita. Perché fra i guerriglieri dell’M23, che combattono contro l’esercito regolare della repubblica congolese ci sono molti Tutsi: figli e nipoti dei trucidati di vent’anni fa, e a quanto pare è il Ruanda soprattutto ad armarli. Ma c’è anche la milizia Hutu delle FDLR. Sono una ventina i gruppi armati attivi nel Nord Kivu. E allora lo sforzo è quello di convincerli a smettere, sforzo contestuale all’intervento militare nel Congo orientale deciso dall’Onu nel marzo dell’anno scorso e finalizzato non solo a proteggere i civili, e gli stessi peacekeepers, ma anche a neutralizzare i gruppi armati.
Credevi che bastasse qualche foto di bambini soldato per avere un’idea della violenza che si vive là, e invece ti rendi conto, adesso, che cosa significa che molti di quelli che cercano di attraversare il Mediterraneo fuggono dalle guerre e che il viaggio sul barcone, che approdi a Lampedusa o invece finisca prima, è stato preceduto da un altro viaggio, altrettanto inimmaginabile, per fatica, costi, rischi: il viaggio per arrivare al nostro mare partendo dall’interno del continente.
Dopo l’incontro con *** leggo con altri occhi gli articoli che parlano dell’Africa, e li leggo fino in fondo. Tanto più che, nel frattempo, le notizie sono purtroppo aumentate, per via di Ebola: “all’abisso già esistente fra l’Africa e il resto del mondo che ci ha reso insensibili davanti alle stragi del Mediterraneo – ha scritto Adriano prosperi su “La Repubblica” del 9 ottobre – oggi si aggiunge la minaccia di abissi anche più profondi all’interno delle nostre società e dei nostri rapporti umani abituali. Excalibur – il cane dell’infermiera spagnola Teresa Romero contagiata da Ebola, abbattuto l’8 ottobre – può essere la prima vittima di un esperimento assai più vasto.”
Un esperimento il cui presupposto è forse già un dato di fatto: “C’è una chiara tendenza a depennare come casi da cestinare parti del mondo, quali l’Africa occidentale e quella centrale”. Lo afferma Stanley Cohen, studioso degli Stati di negazione (come si intitola il suo libro, in Italia pubblicato da Carocci nel 2002, sottotitolo: La rimozione del dolore nella società contemporanea). La mancanza di informazione non spiega tutto, anzi: “alle persone, alle organizzazioni o ad intere società sono fornite informazioni troppo inquietanti, minacciose o anomale perché siano interamente assorbite o apertamente riconosciute. Pertanto tale informazione è rimossa, negata, messa da parte, re-interpretata. Oppure essa viene sufficientemente ‘registrata’, ma le sue implicazioni – cognitive, emotive o morali – sono evitate, neutralizzate, razionalizzate”. E così che alle notizie su diverse realtà – come l’aumento evidente della povertà anche nelle società occidentali, o il riscaldamento del pianeta con le sue conseguenze più manifeste, o il disastro dell’Africa appunto – “la gente reagisce come se non sapesse quello che sa.”
E “sapere e non agire è non sapere”, ricorda Cohen riportando un antico detto cinese.
L’abbandono dell’idea di una sede unica per gli uffici comunali e del progetto dell’edificio spettacolare progettato da Libeskind negli spazi degli ex Magazzini Generali, fra via Dalmazia e via Don Bosco, sembrava avesse aperto spazio per nuove idee, un anno fa, o alla ripresa di ipotesi che erano già state avanzate pochi anni prima. Come quella di un auditorium: già attorno al 2006 si era pensato (ed era lo stesso LIbeskind l’architetto coinvolto) che ad ospitarlo potessero essere le casére, i grandi capannoni in cotto che dagli anni ’30 avevano ospitato decine di migliaia di forme di formaggio. Non era un’idea strampalata: a Parma, in uno stabilimento dismesso dall’Eridania, Renzo Piano ha realizzato appunto un auditorium, ricordavano Giovanni Comboni e Elena Franchi nel settembre 2013 su questo stesso giornale.
Solo un mese dopo, però, dell’idea non restava traccia. Dall’incontro fra l’Amministrazione comunale e la società proprietaria dell’area usciva una nuova definizione della destinazione del luogo: un nuovo centro commerciale, residenze (in buona parte edilizia convenzionata) e uffici.
Recentemente, nel mondo della critica letteraria è emersa l’idea che per ridare vitalità e credibilità a una letteratura sempre meno capace di incidere su un immaginario collettivo colonizzato e omologato dai media sia consigliabile tornare al romanzo storico: strumento, paradossalmente, per catturare l’attenzione di chi vive oggi.
Altri hanno invece ravvisato la stessa potenzialità nel giallo, o nel noir, nel quale ravvisano una sorta di romanzo sociale della nostra epoca.
C’è chi – a volte avvalorando teorie simili, altre semplicemente ascoltando la propria voglia di scrivere, di raccontare – ha fatto convergere i due generi, e ha scritto romanzi gialli ambientati nel passato, ed è E’ Il nome della Rosa di Eco, naturalmente, che viene innanzitutto in mente.
Più recentemente, una novità si può rilevare nel fatto che come protagonista, come detective, si sono scelti personaggi d’eccezione. Niente meno che Aristotele è l’investigatore dei romanzi di Margaret Doody, una scrittrice canadese: alla fine degli anni settanta il paio di racconti che aveva pubblicato avevano avuto così poco successo da indurre la Doody a lasciar perdere, ma nel 1999 i due volumi sono stati ripubblicati in Italia, da Sellerio, riscuotendo grande consenso di pubblico e di conseguenza la scrittrice ha ripreso la serie con nuovi racconti nei quali Aristotele mette la sua logica ferrea al servizio dell’indagine, in ciò assistito da un tale Stefanos, secondo il collaudato schema per cui non c’è uno Sherlock Holmes senza il suo Watson (come del resto nel Nome della rosa).
Seguendo l’esempio della Doody, sia pure con esiti meno brillanti, un’americana, Diane Stuckart, ha fatto indossare l’abito del detective a Leonardo da Vinci.
Albertano da Brescia. Magistrato e uomo di lettere, non ha certo la statura di Aristotele o di Leonardo, ma l’avergli assegnato attitudini e capacità di investigatore collocano in questo filone un recente romanzo di Enrico Giustacchini (Il giudice Albertano e il caso della fanciulla che sembrava in croce, Brescia, Liberedizioni, 2014), che tuttavia può vantare tratti indubbi di originalità rispetto ad altre prove del genere.
A partire dalla decisione dell’autore di non tenere per sé la natura dei documenti che gli hanno permesso di ideare la sua storia: due registri d’inventario della Mensa vescovile che danno la possibilità di restituire la fisionomia dei luoghi e dei loro abitanti. Di restituirla ma, allo stesso tempo, anche di immaginarla, perché dei documenti l’autore di romanzi storici si deve liberare, dopo essersene servito. Deve immaginare, appunto, pur sempre entro i confini del verosimile, e l’occuparsi di un’epoca come quella medievale di sicuro favorisce questo rapporto col documento: ce lo ha ben spiegato uno storico come Georges Duby, che nel suo Il sogno della storia dichiarava apertamente come la ricostruzione storica sia frutto anche di immaginazione e come l’immaginazione possa dare il suo contributo essenziale quanto più i documenti sono scarsi, lacunosi. Se questo è vero per lo storico rigoroso lo è tanto più per il romanziere, libero di forzare il documento e di colmare vuoti.
Giustacchini non vuole però abusare di questa libertà, o meglio: ne vuole rendere esplicite le condizioni, e i limiti. E dunque – avverte nell’introduzione – “coloro che lo desiderano potranno fruire, in appendice al volume, di un repertorio di notizie, citazioni, rimandi” con “la raccomandazione di accostarvisi però solo dopo aver terminato il romanzo”. Perché è appunto la logica del romanzo che deve prevalere, con tutti i suoi artifici. Artifici che l’autore usa con padronanza, mostrando in primo luogo la capacità di entrare nella testa del protagonista e di far conoscere al lettore i suoi pensieri ricorrendo all’espediente di introdurre un altro personaggio, sapendo che questo dovrà però essere all’altezza del protagonista, un intellettuale, per cui quest’altro personaggio dovrà possedere gli strumenti per capirlo e se del caso contraddirlo. Ecco allora Berengario (non a caso, un medico: come Watson, anche se lo schema della coppia genio dell’indagine-compagno che gli fa da spalla in questo romanzo non risulta dominante).
E come dire del contesto, della scena che fa da sfondo agli avvenimenti e ai discorsi dei personaggi? Usando il punto di vista di questi ultimi, mettendo in bocca a loro i cenni descrittivi, attribuendo a loro il compito essenziale di farli vedere, i luoghi, e non arrogandosi il privilegio scontato, e stucchevole, del narratore onnisciente. E le vicende storiche pregresse: come renderne conto? Spesso nei romanzi storici il raccontarle crea uno stacco sgradevole, un cambio di registro che fa venir voglia di saltare qualche pagina per ritrovare lo svolgersi della trama vera e propria. L’alternativa, scelta da Giustacchini, sta in brevi flashback, introdotti sempre in modo motivato laddove la trama lo richiede ( “L’imperatore, Albertano l’aveva visto una volta sola (…) era avvenuto a Bologna”, e poi, a due pagine di distanza: “Diciott’anni dopo, Albertano si chiedeva se avrebbe rivisto Federico”). Flashback – analessi – ma anche prolessi, anticipazioni: “Albertano meditava di scrivere un libro sul tema della consolazione e del perdono”, quel Liber consolationis che non a caso sarà un “trattato morale ma insieme il racconto di un delitto”. Lo stesso libro di cui l’autore costella il racconto con brevi estratti che marcano le tappe salienti della storia. Che segnano il testo di rimandi a un ipertesto, si potrebbe dire.
Ma veniamo al protagonista, Albertano. Conosciuto come uomo dall’intelligenza e dall’acume proverbiali, non smania tuttavia per mettersi a far ricerche e non sembra entusiasta di doversi occupare di un delitto. Se si lascia convincere dal gastaldo ad occuparsi del caso della morte di Jacoma è perché la ragazza, brevemente incontrata, l’aveva affascinato ricordandogli, con la sua bellezza e il suo profumo, “la stagione vibrante della gioventù”. Del detective ha comunque la stoffa. Ne ha l’intuizione (“Hai mentito, caro il mio ragazzo”, dice fra sé dopo aver ascoltato uno dei personaggi, Lucio Frere), ma ha anche l’atteggiamento che conosciamo ad altri investigatori: non a Holmes, ma piuttosto a un Maigret: Albertano lascia che nella sua anima “(si insinuino) mille e mille dubbi” e non disdegna affatto ma accoglie come un dono il fatto che l’intuizione gli venga da un sogno, un dono che Albertano sembra voglia lasciar libero il lettore di stabilire se venga dal buon Dio, come provvidenziale illuminazione, o dal lavorio di una mente raziocinante.
Oltre a questi, il protagonista è contraddistinto da tratti che si intuisce condivisi dall’autore: il disincanto per esempio, che si manifesta nel modo di fare di Albertano, ma anche nei suoi pensieri più profondi (“tutto ha un fine e tutto finirà. Il tempo perderà il suo significato e tra la vita effimera di una lucciola e quella del firmamento, proseguita immutabile dal quarto giorno della creazione, non vi sarà più differenza”). Non si tratta di una questione di poco conto: un personaggio è vivo e credibile quando l’autore in certa misura gli aderisce. L’identificazione dello scrittore col suo personaggio è condizione dell’identificazione e quindi del piacere del lettore, fatto anche e forse soprattutto di risonanze fra sé e quel che legge. Ed ecco allora, oltre al disincanto, la sobrietà dell’espressione (carattere decisivo in un uomo che avrebbe scritto un’opera intitolata De arte loquendi et tacendi). Una sobrietà che fa tutt’uno con una razionalità non fredda, sillogistica (come quella di Holmes), ma fatta di comprensione degli altri. Una razionalità che ammette piccole abitudini che di razionale hanno poco (mi chiedo se anche l’autore abbia l’abitudine di scarabocchiare i margini dei libri che legge con disegnini fanciulleschi come faceva Albertano e molti di noi fanno).
E infine, un altro tratto distintivo, che costituisce un carattere di fondo di questo romanzo: una certa fiducia, negli uomini, in generale, e dunque anche nella capacità del lettore di accostarsi e di gustare una vicenda non semplicemente complicata nell’intreccio ma, anche, densa di rimandi culturali: l’alchimia, ad esempio, o la complessa rete di allegorie che caratterizzava il pensiero medievale, anche queste introdotte senza cadere nel didascalico ma come riferimenti necessari alla svolgersi della trama e introdotti con naturalezza attraverso il dialogo dei personaggi.