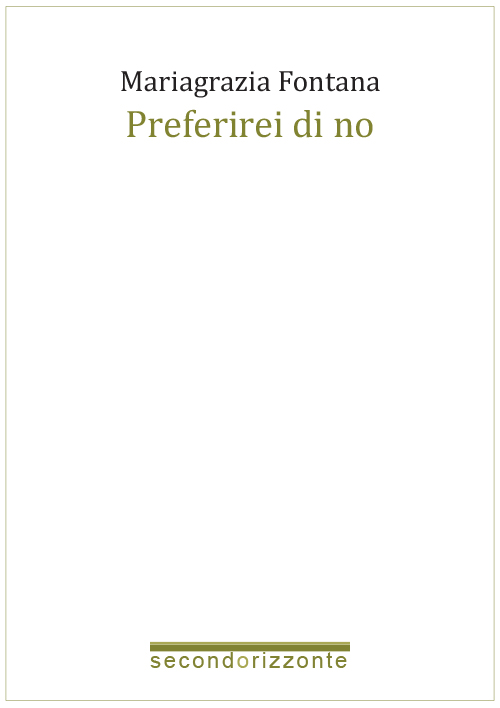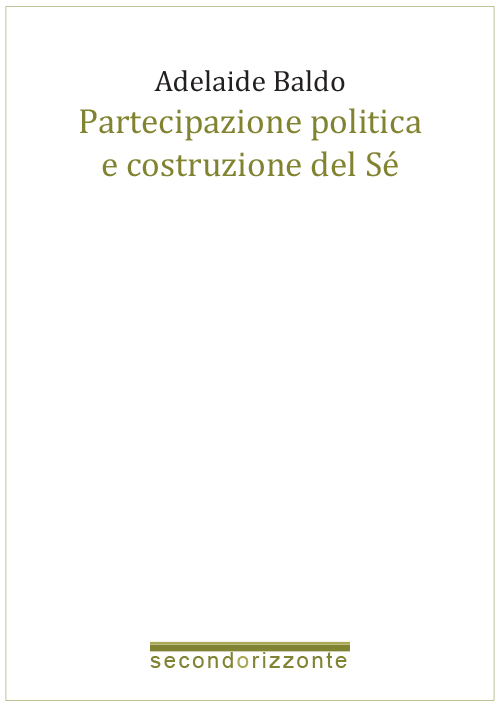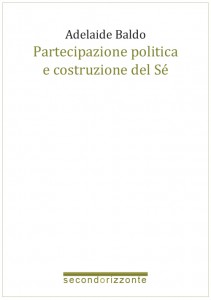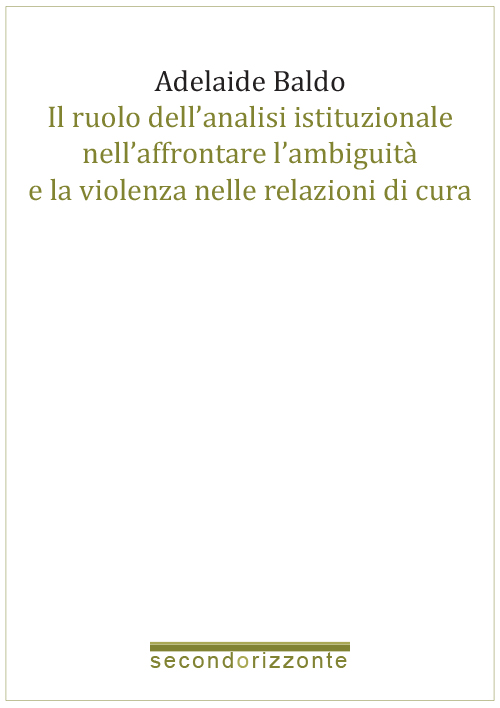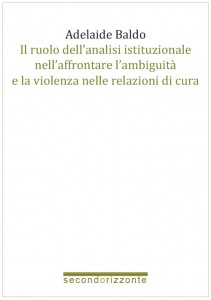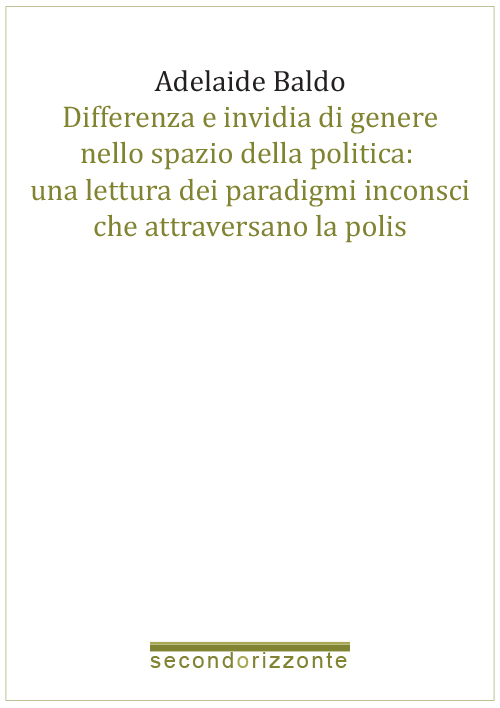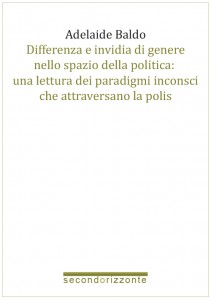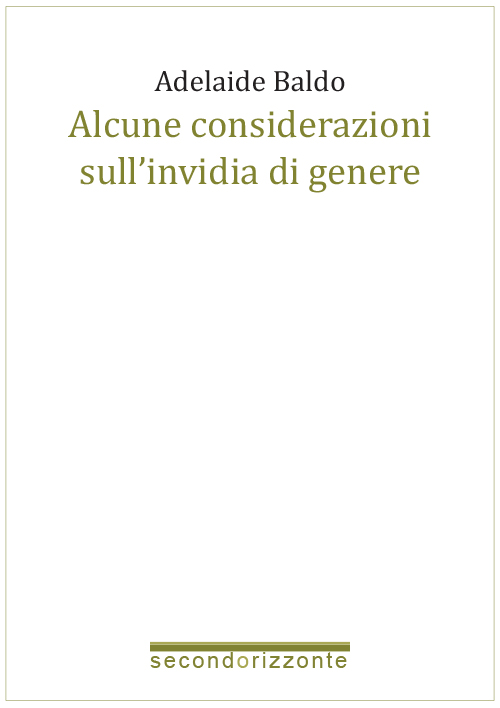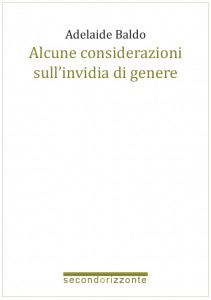“Poiché la disperazione era un eccesso che non gli apparteneva, si chinò su quanto era rimasto della sua vita, e riiniziò a prendersene cura con l’incrollabile tenacia di un giardiniere al lavoro, il mattino dopo il temporale.”
Non so dove ho trovato questo pensiero di Alessandro Baricco, ma so che non potrei esprimere meglio di così, la tenacia con la quale finora ho cercato di prendermi cura di quanto rimaneva della mia vita ogni volta che un temporale arrivava a sconvolgere il mio giardino interiore . L’allenamento è iniziato presto e la scrittura, quella che accompagna i nostri giorni, è stata la pratica che mi sono trovata tra le mani. Esercizio umile, senza pretese, mosso unicamente dalla necessità di veder chiaro e, nella chiarezza, ritrovare la calma che c’è al fondo dell’anima capace di accogliere la verità, quale essa sia.
Come molte donne della mia generazione, non distratte dall’arrivo continuo e invadente delle chat, ho potuto preservare questo spazio di scrittura che ha bisogno di silenzio e solitudine, per tutto il tempo della mia vita adulta riempiendo molti quaderni. Di questi, solo uno, è diventato un piccolo libro con il titolo Lontano dalle strade battute. Il sottotitolo, Diario di un anno, dichiara la sua origine. L’anno, dal 13 dicembre 1994 al 3 novembre 1995, è quello dell’incontro con il cancro (un cancro al seno), della cura chemioterapica, della decisione di non rientrare subito al mio lavoro di insegnante e della determinazione a chiudere con questo lavoro appena possibile (tre anni dopo). Una necessità inderogabile che non scaturisce da una serie di ragionamenti ma che emerge da una visione chiara e immediata: vedo spalancarsi la mia vita a qualcosa di vasto, una sensazione che allarga il respiro e infonde una gioia sconosciuta, generando subito uno slancio che non avevo mai conosciuto prima. Sento che una porta si apre su una strada che non so dove mi condurrà, ma so che non posso fare a meno di percorrerla.
Questo diario, scritto su un quaderno a righe della Naj-Oleari, che un’amica mi porta in dono all’indomani dell’intervento chirurgico, diventerà (come da allora non ho smesso di fare) un quaderno confezionato con le mie mani, da regalare alle amiche e amici che mi sono stati vicini. Sarà una decisione delle dottoresse Gemma Martino e Gabriella Galperti del Centro medico Metis di Milano a trasformare questo prodotto artigianale in un piccolo libro, edito da METIS medicina e memoria, stampato da Grafo edizioni (1997). Qualche anno più tardi, tradotto in spagnolo da Gemma Del Olmo, sarà uno dei primi libri della nuova casa madrilena Sabina editorial.
Nel tempo raccolto della malattia e della cura ero riuscita a sentire una voce che non veniva da un io ferito, una voce, mi dissero le dottoresse, che poteva entrare nel dolore e nella ferita di altre donne e trasmettere forza… Nel silenzio e nella solitudine del tempo della cura riuscivo ad accoglierla e a non distrarmi… I disegni di cui il diario è ricco mi aiutavano a stare dentro questo tempo senza ricorrere alle parole, mi aiutavano a stare dentro la realtà che trascende lo spazio umano: a sentirmi in comunione con gli alberi, gli animali, i fiori, l’acqua, le montagne, il cielo … il cosmo di cui siamo parte, partecipe dello spazio vasto che accomuna gli esseri viventi.
Sentirsi, come ripete il mio maestro Jacques Castermane, “essere della natura” e non “essere nella natura”, è esperienza profonda che trasforma il nostro spirito radicalmente.
Così, senza rendermene conto, mi sono trovata irrimediabilmente, irreversibilmente fuori dall’antropocentrismo della cultura in cui sono cresciuta… Una trasformazione di cui solo adesso, a distanza di trent’anni, riesco a rendermi conto.
Domenica 12 gennaio 2025: la dottoressa Gemma Martino mi regala una delle ultime copie rimaste del diario. Mi chiedo se lasciar andare definitivamente questo dono di parola che la vita mi ha ispirato o rimetterlo al mondo sotto forma di dono offrendolo a chi ne ha bisogno. Scelgo questa possibilità, e, insieme al diario, decido di pubblicare qui altri due scritti che costituiscono le tracce di un processo terapeutico che, grazie alla ricerca di Metis, mi ha messo sulla Via del corpo, il cammino aperto al mistero del corpo che siamo, che sente intimamente la vita orientandola con profonda sapienza.
Che cosa sa il corpo che io non so, Era semplicemente ritornata alla vita… sono i miei contributi al primo de “I quaderni di Metis”, Le donne e il cancro al seno, METIS medicina e memoria (2004), anche questo esaurito.
Lontano dalle strade battute

Che cosa sa il corpo che io non so

Che cosa sa il corpo che io non so
Scarica il saggio
Era semplicemente ritornata alla vita
Scarica il saggio