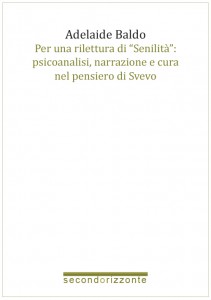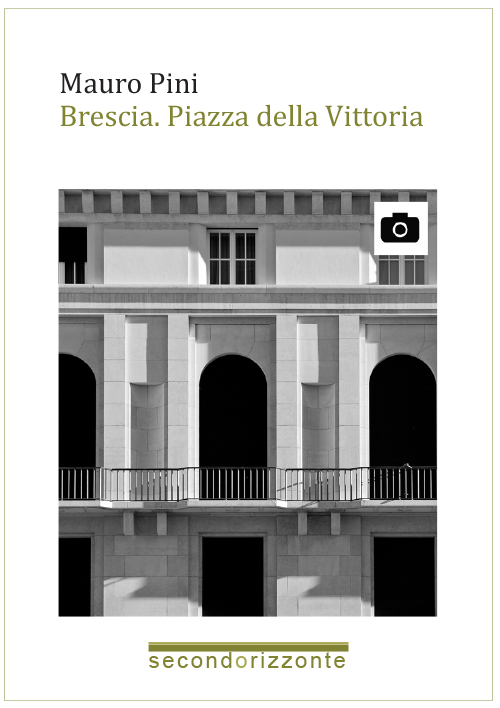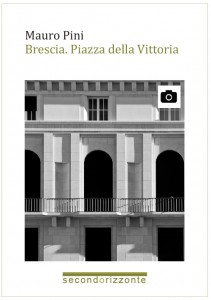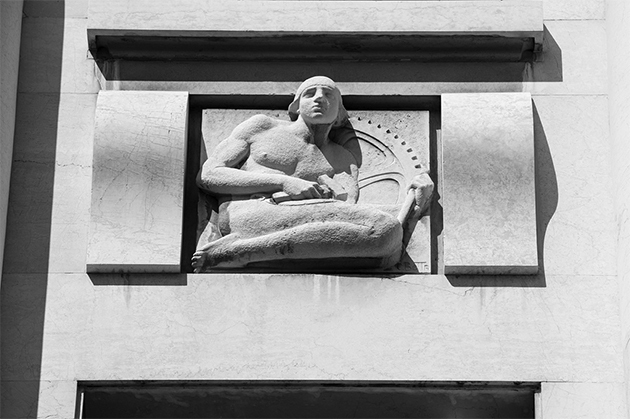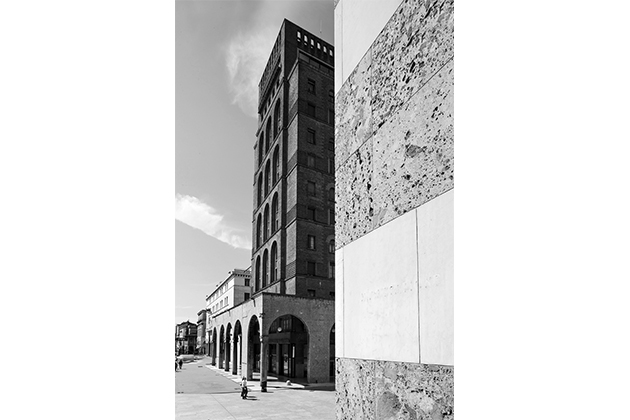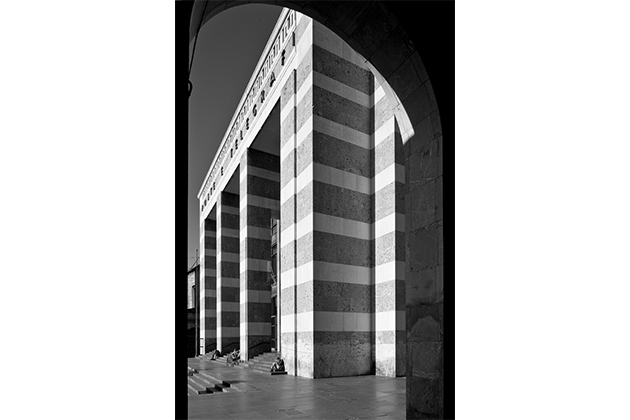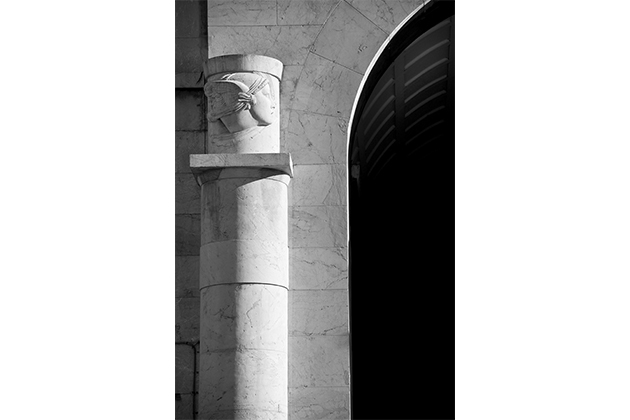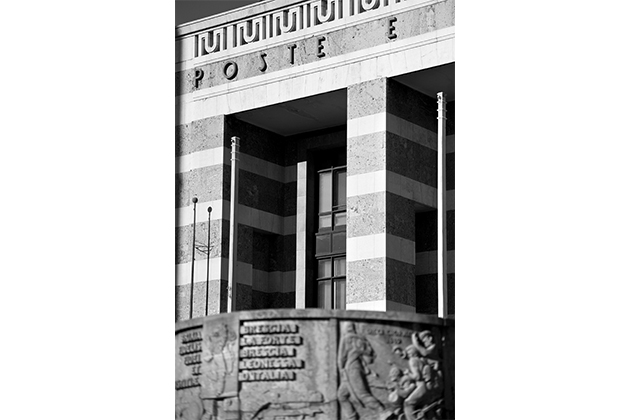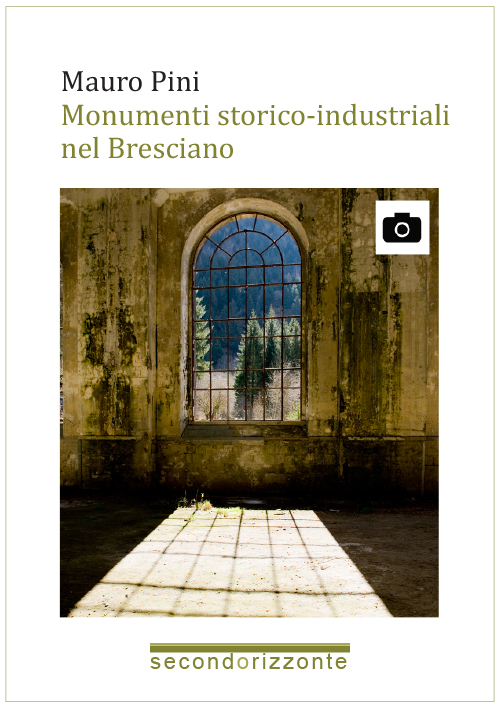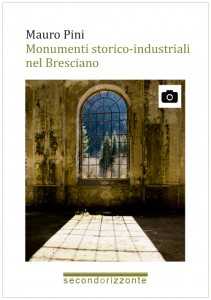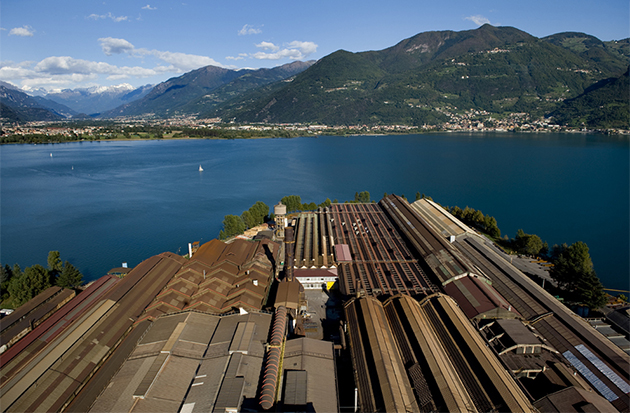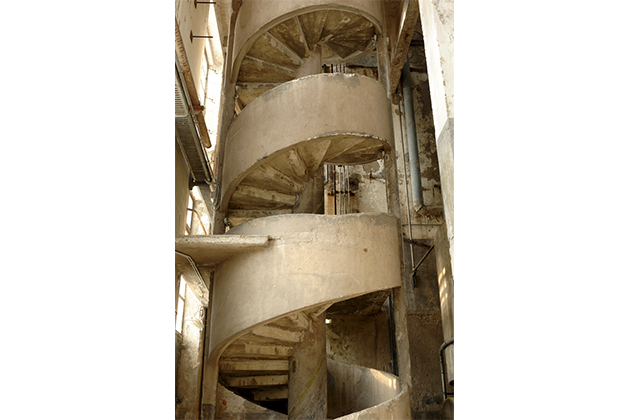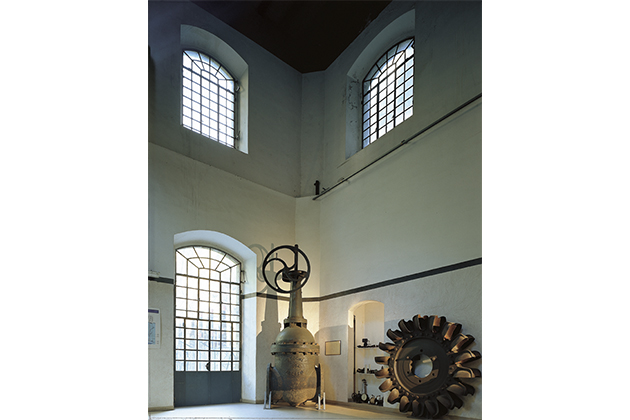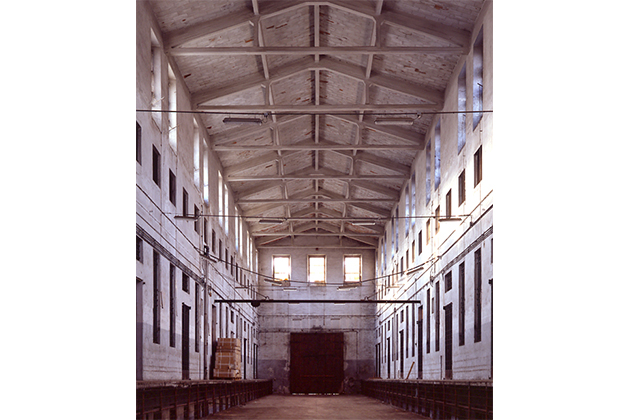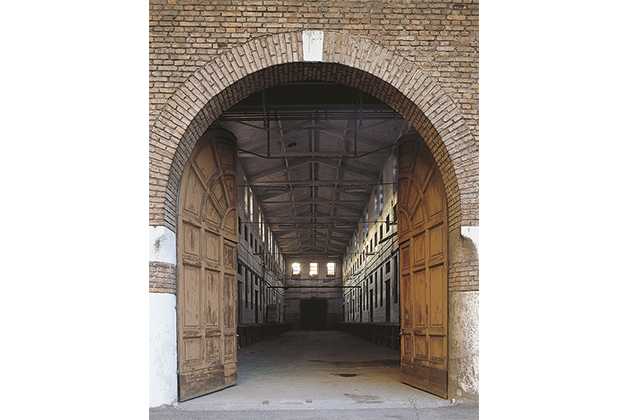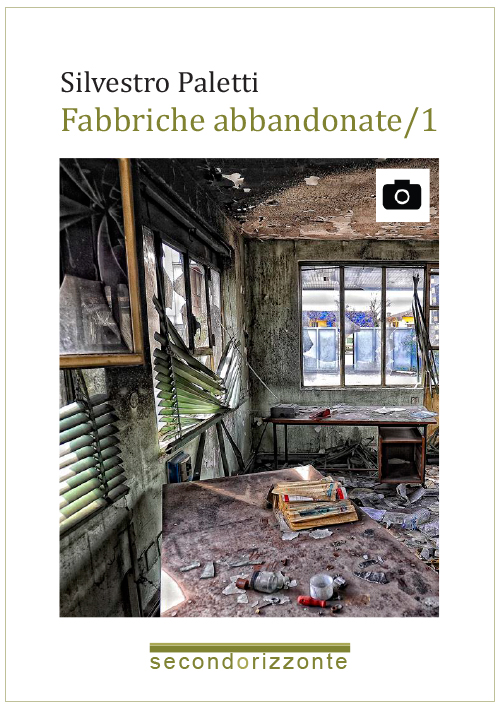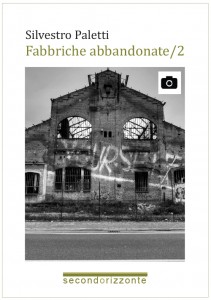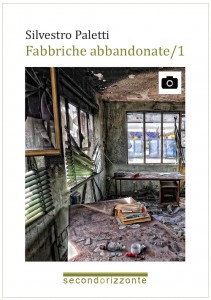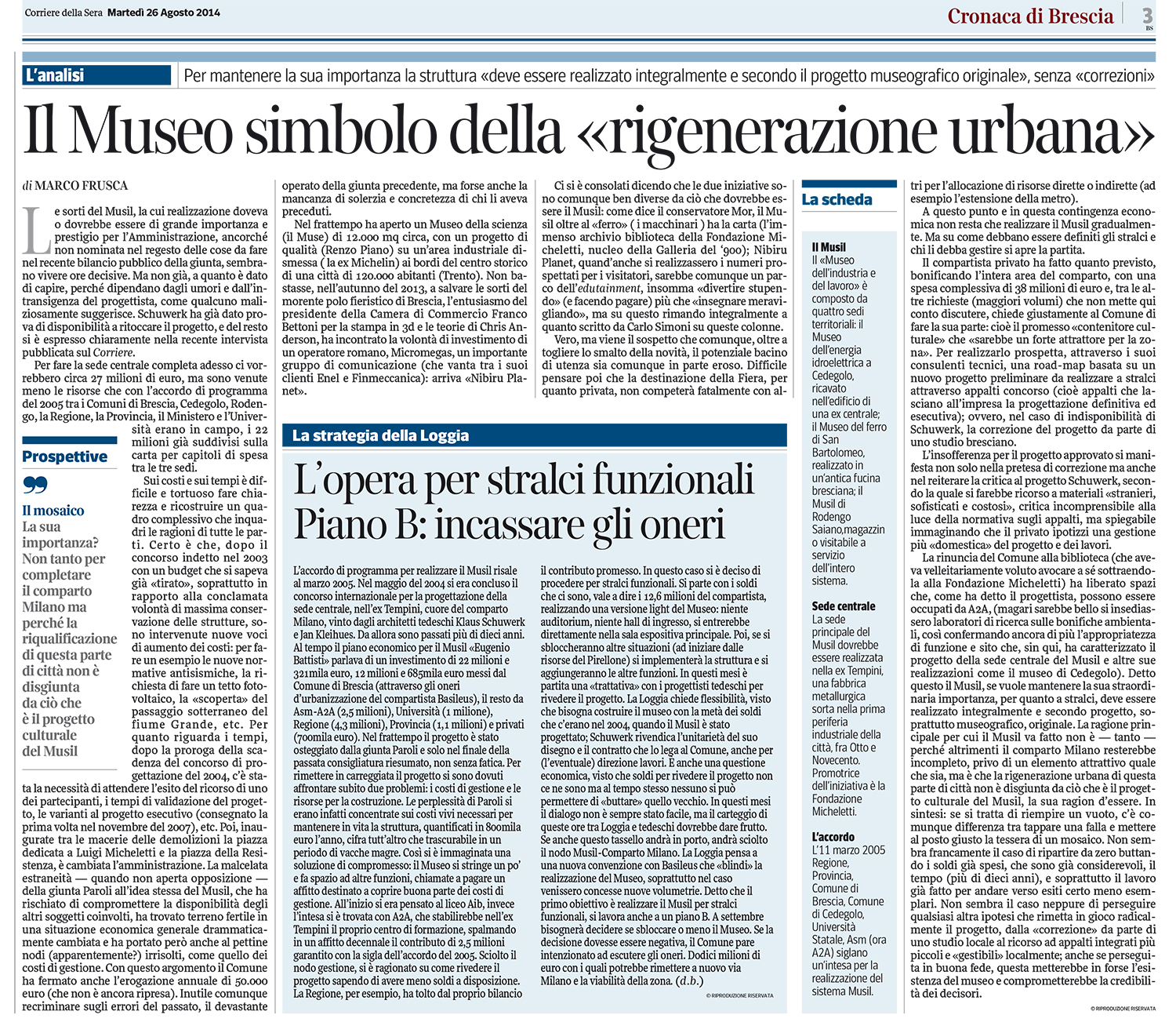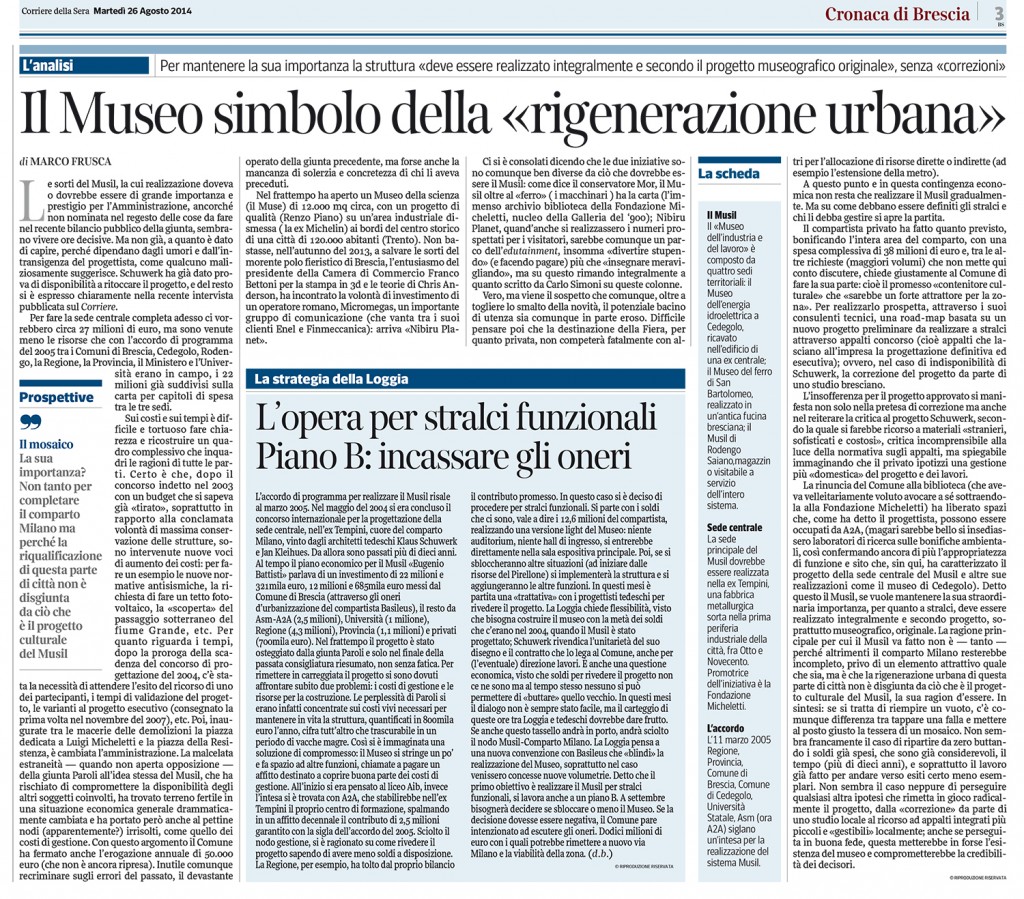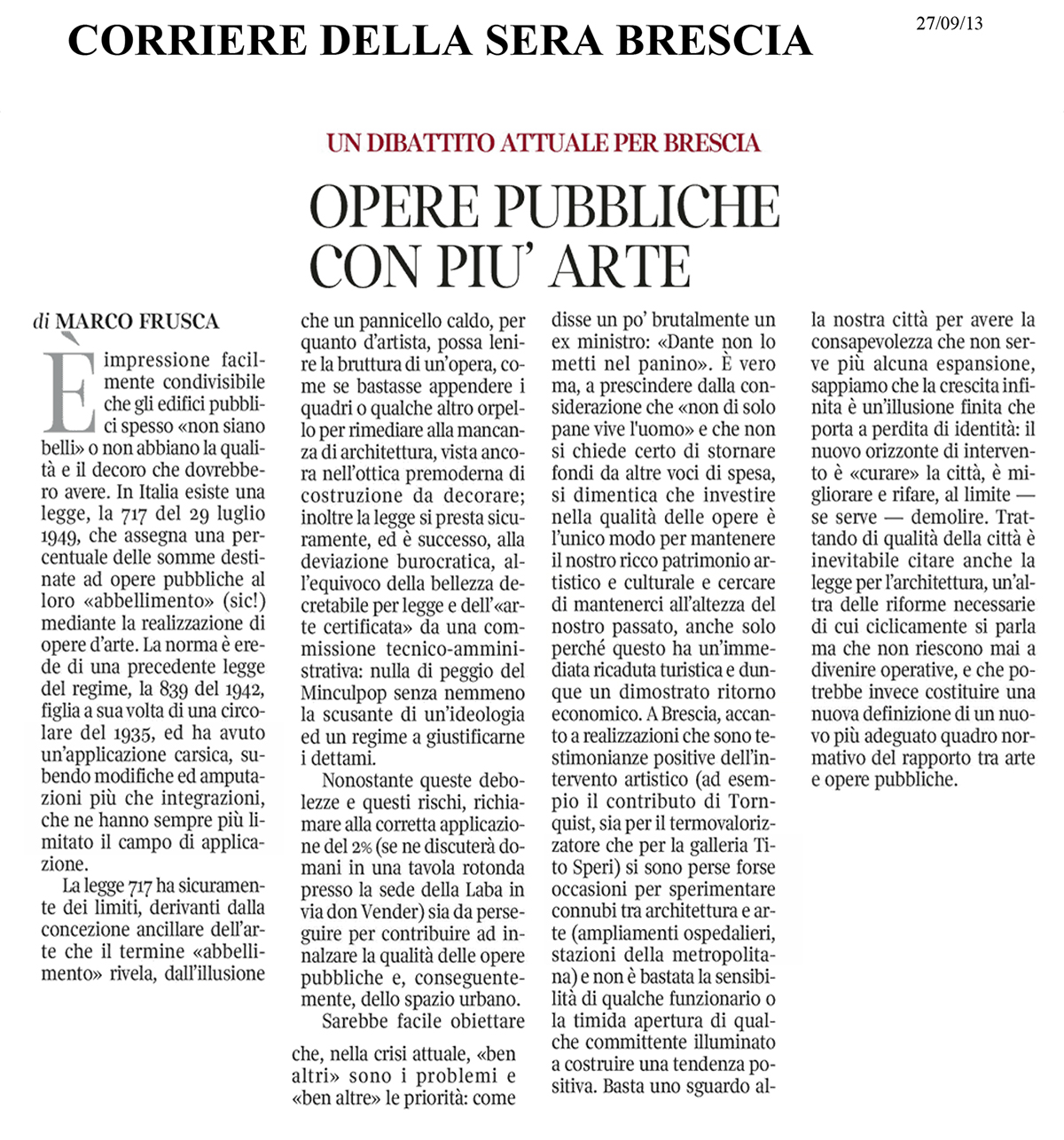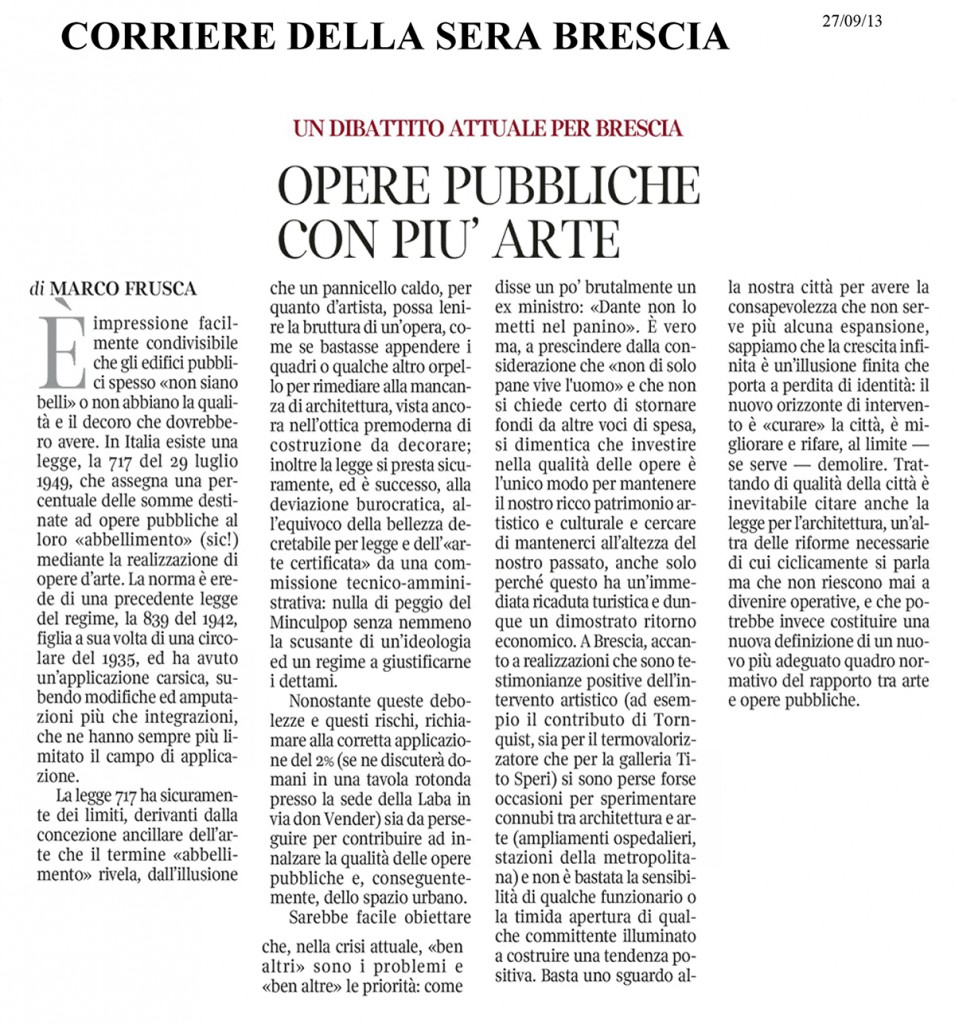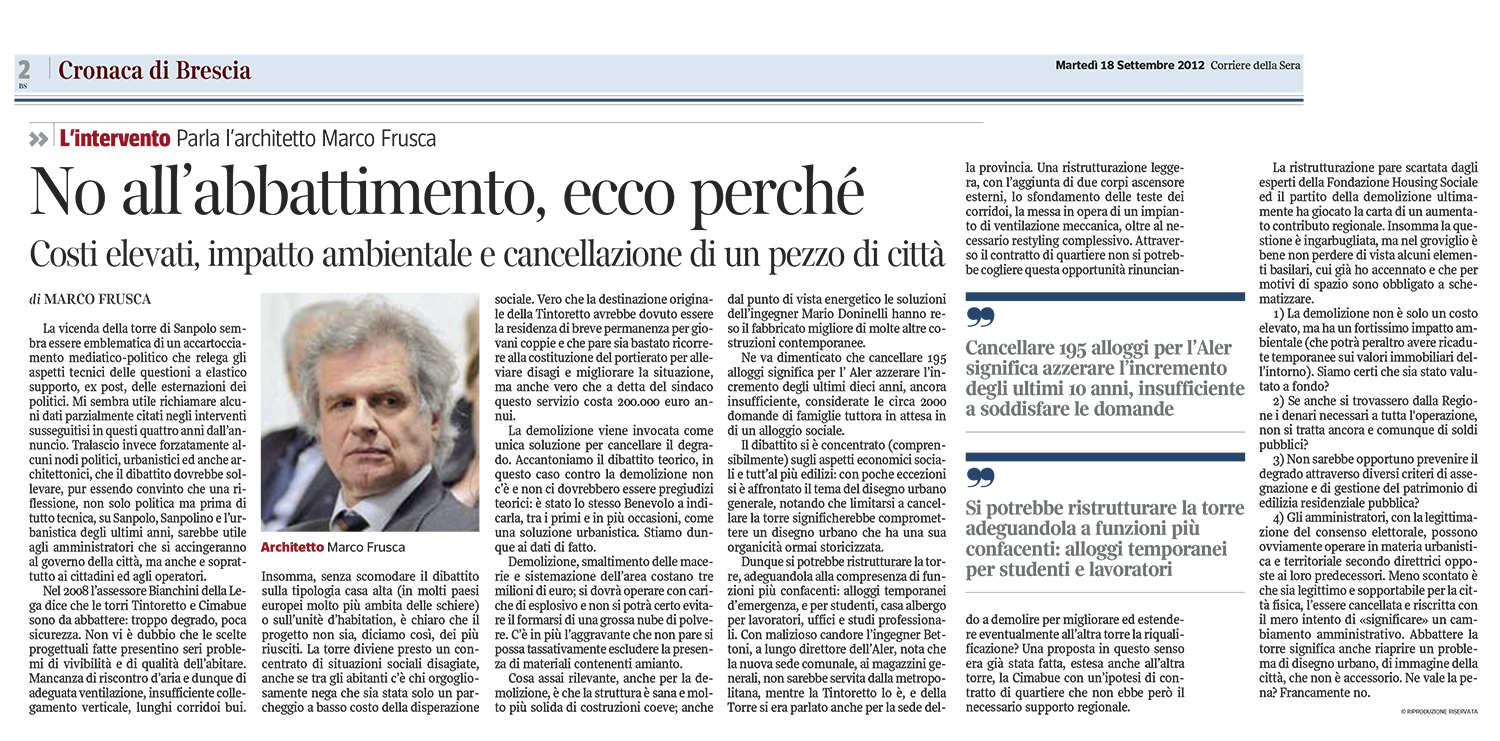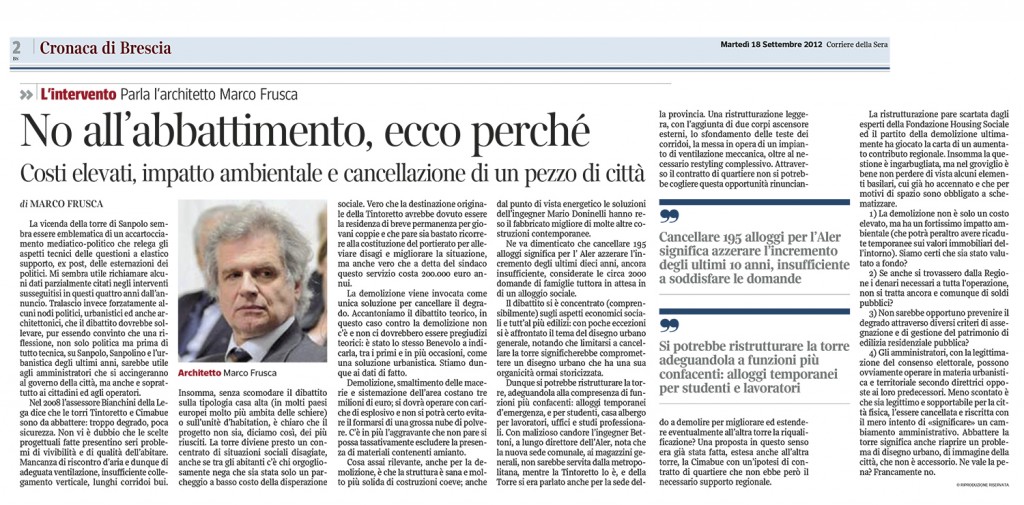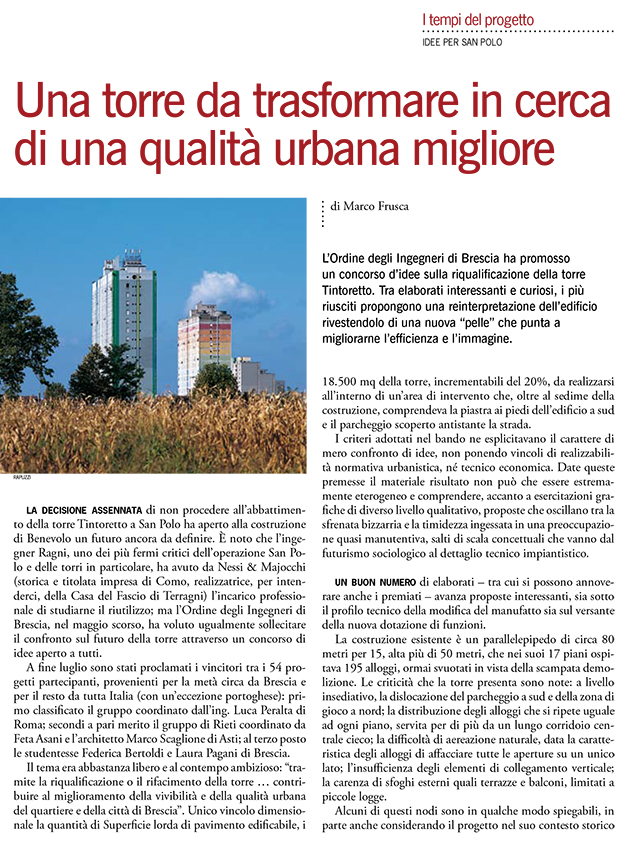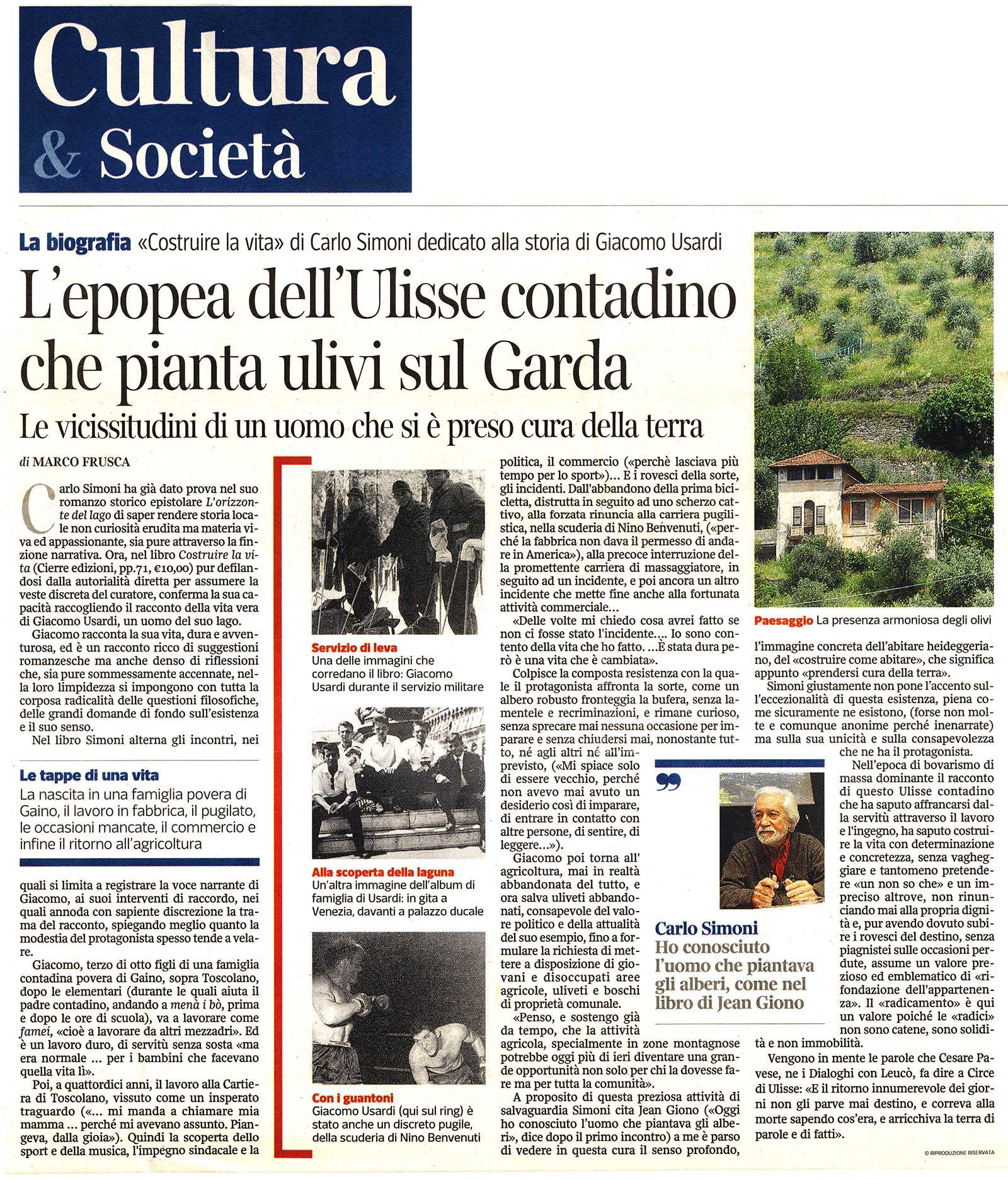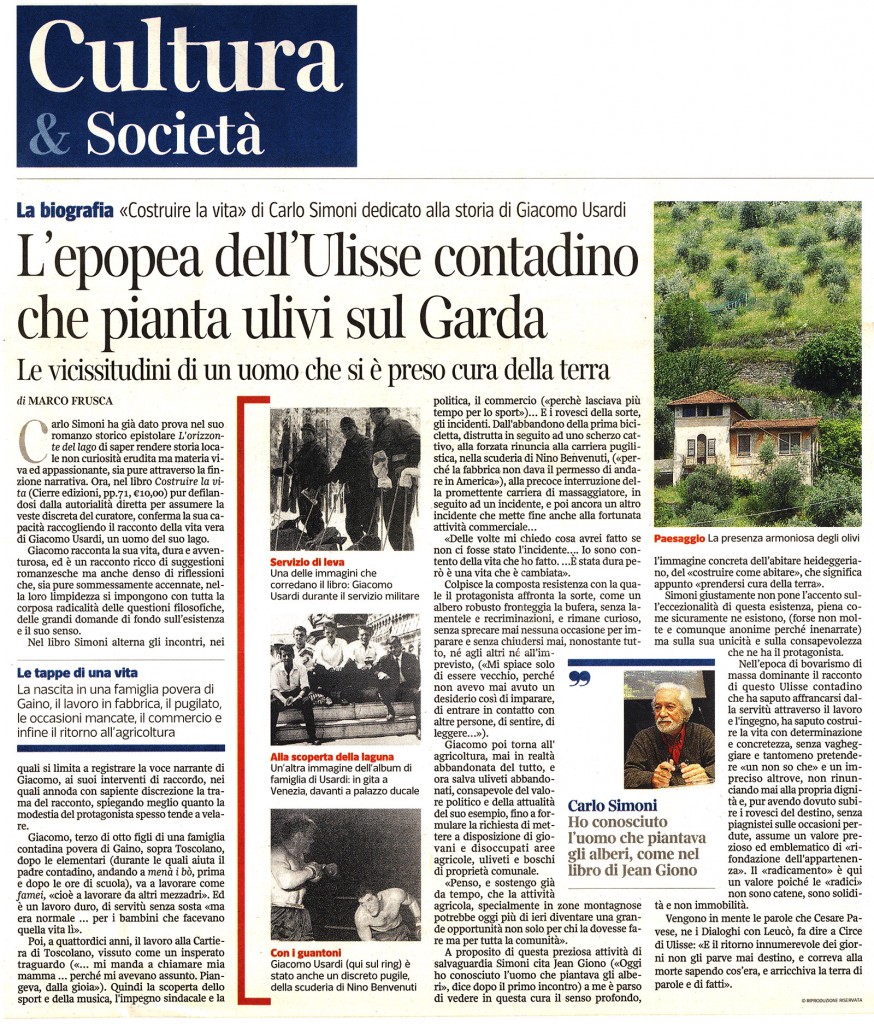I rapporti tra psicanalisi e letteratura sono talmente complessi che sembra sia impossibile poter esaustivamente cogliere i nessi profondi che legano queste due discipline fra le quali, da sempre, vi è un vivo interesse reciproco.
Vorrei qui limitare il discorso all’uso della psicanalisi, o meglio del suo linguaggio e delle sue strutture interpretative, in relazione alla critica letteraria.
Molto spesso la critica letteraria -ma anche quella che si applica al cinema o alle arti figurative – si avvale di strutture interpretative desunte dalla psicoanalisi che, utilizzata al di fuori del suo naturale habitat clinico, sembra essere in grado di offrire l’opportunità di svelare aspetti che, altrimenti, resterebbero nascosti.
È vero che la psicoanalisi nasce come strumento terapeutico, ma essa è anche un tramite di conoscenza secondo una teoria che può anche non essere condivisa, ma che comunque rappresenta uno dei possibili modi di leggere la realtà e, a maggior ragione, la realtà artistica, la produzione artistica, dal momento che in essa è quanto mai agevole riconoscere linee interne di percorso inconsce, passibili quindi di analisi del profondo.
L’impressione che se ne ricava è che queste due discipline si incontrino in uno spazio condiviso, abitato dalla comune ricerca del “capire” e del “dare significato”.
Il lavoro dello psicanalista consiste infatti nel “dare significato” a quel mondo interno che rischierebbe di restare inaccessibile o, peggio, utilizzabile solo con modalità patologiche, proprio come il lavoro del critico consiste nell’indicare i possibili modi di “leggere” un’opera, individuandone e portandone alla luce gli aspetti “segreti”.
Vi sono opere letterarie che con prepotenza si offrono a un’interpretazione analitica, o perché propongono personaggi dagli evidenti tratti patologici, o perché il loro intreccio induce a riflettere sulle dinamiche psicologiche, o, ancora, perché traspare in esse una ricerca dell’autore, più o meno consapevole, diretta verso le parti più profonde di sé.
Tra gli autori di opere siffatte rientra senza dubbio Italo Svevo: credo sia davvero impossibile leggere Svevo senza fare un collegamento con la psicoanalisi, se non altro per ragioni storiche, dal momento che la produzione sveviana si sovrappone cronologicamente a quella di Freud, il cui pensiero, come è noto, penetrò precocemente in Italia proprio nella Trieste sveviana.
Tuttavia, nell’individuare le ragioni dell’interesse reciproco fra psicoanalisi e letteratura, non va dimenticata quella che è certamente la meno riconoscibile, ma anche la più profonda, e cioè il fatto che la stessa psicanalisi può essere considerata un genere letterario basato sulla narrazione.
La psicanalisi, o le psicoterapie analitiche, si dipanano infatti secondo un filo narrativo, anzi si può dire che la psicoanalisi sia una narrazione, una narrazione del tutto particolare alla quale non interessa tanto il descrittivismo naturalistico, quanto la possibilità di individuare connessioni simboliche che introducano nella narrazione un elemento di conoscenza critica sulla quale fondare la possibilità di giungere alla meta finale che è la trasformazione di una struttura psichica.
Durante una psicoanalisi il paziente rivive e riscrive, e non già descrive, il “romanzo” della propria vita e, nel corso della narrazione, il paziente e il terapeuta sono chiamati al tempo stesso ad essere protagonisti ed osservatori.
Ecco che allora la psicanalisi solleva degli interrogativi relativi al senso del narrare: a cosa serve narrare ?
Quale è lo scopo del narrare?
È semplicemente portare fuori da sé quegli aspetti esistenziali che vengono percepiti come dolorosi o fastidiosi – per liberarsene – o è introdurre una possibilità di conoscenza trasformativa?
È proprio intorno a tali quesiti che si articola la differenza tra interpretazione analitica di un’opera letteraria ed opera letteraria di contenuto analitico.
La differenza sta, come si capisce, non tanto in ciò che si narra, ma nella qualità della narrazione; non consiste tanto nel descrivere una patologia, o semplicemente un carattere, quanto nel cogliere il nesso tra malattia e narrazione da una parte e narrazione e terapia dall’altro.
Da questo punto di vista Svevo è un autore che si può definire analitico, poiché la sua narrazione risponde a un buon numero di quelle caratteristiche che contraddistinguono la psicoanalisi.
Innanzi tutto egli, nel corso della narrazione, è osservatore, sa mantenersi lucido e critico, ma è anche protagonista, poiché il colore della narrazione è quello di una vicenda vissuta in prima persona (anche se formalmente “Senilità” è scritto in terza persona, a differenza della Coscienza di Zeno, che è un romanzo-diario).
Non solo, ma il tema centrale di “Senilità” è quello della narrazione, anzi di una narrazione mancata e, per traslato, di una terapia mancata e di una guarigione mancata.
Continua la lettura nel pdf: