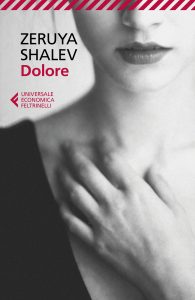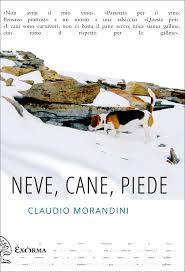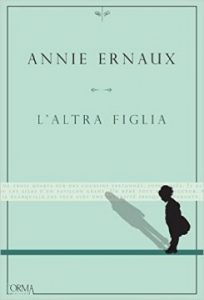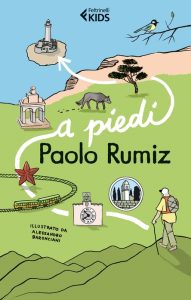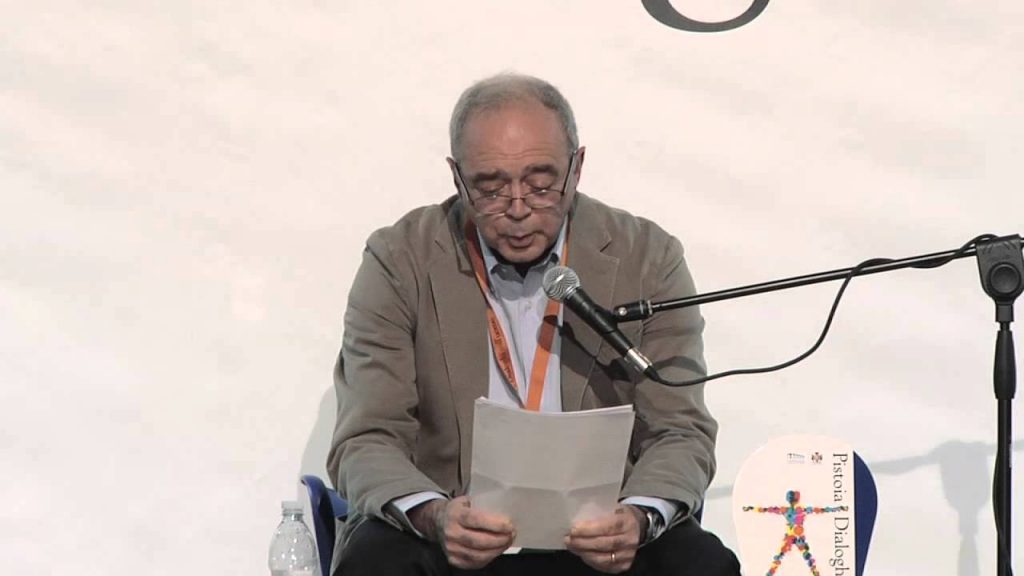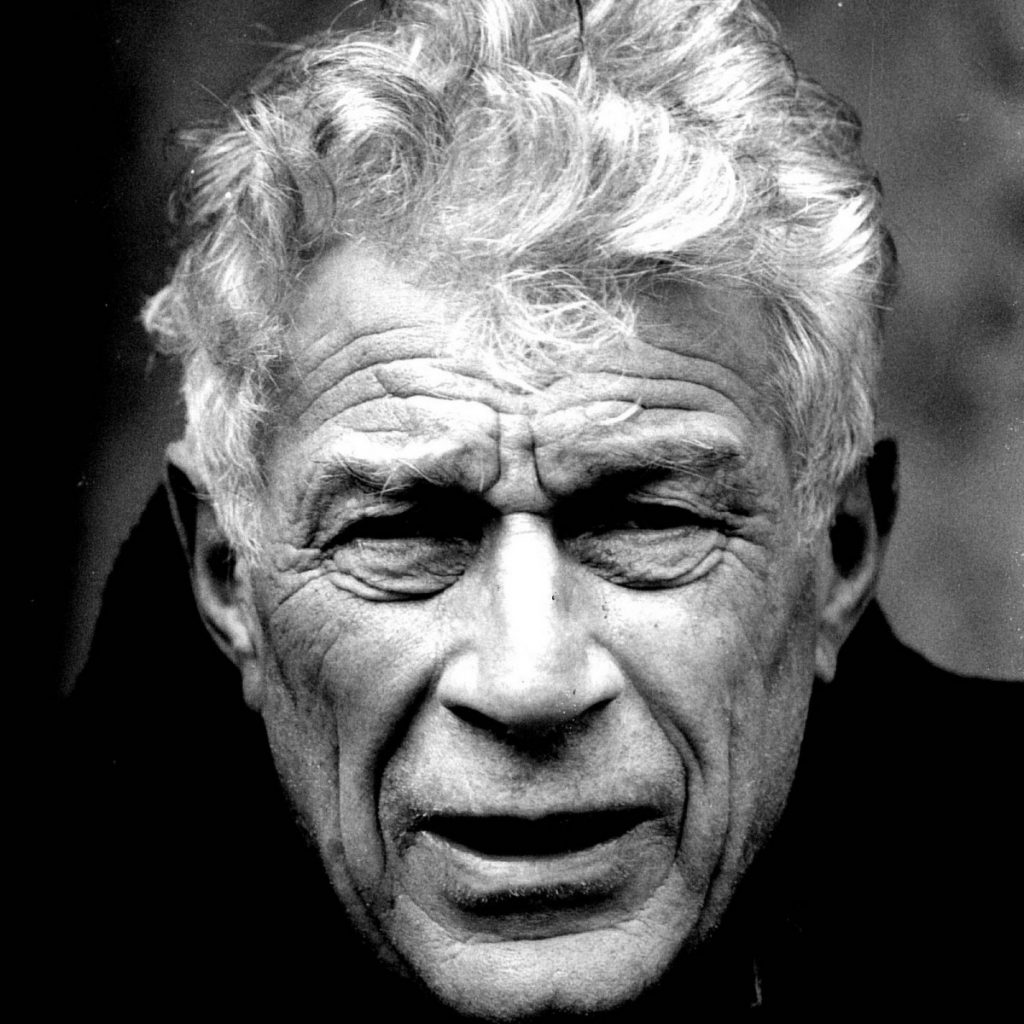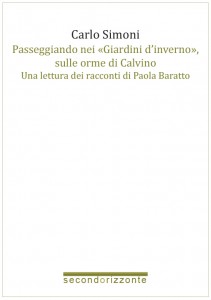(* Paola Baratto, Giardini d’inverno, Manni 2014)
Da dove viene il senso di leggerezza – e di conforto, vorrei dire: di quieta fiducia – che ci resta dopo la lettura di questi racconti, come dopo una passeggiata. breve e ristoratrice? Non certo dal fatto che si tratti di una lettura scacciapensieri. E perché conserviamo una simpatia solidale con i personaggi che abbiamo incontrato? Personaggi che sono lontanissimi dai modelli di vincenti che molto spesso ci vengono proposti più o meno esplicitamente come termini di identificazione, e che dichiarano questa loro estraneità sin dai nomi che portano, nomi comuni (Nino, Irma, Bianca, Fausto, Giulia, Adele) o che suonano addirittura un po’ prosaici, fuoricorso (Biagio, Martino, Gabriele), quasi se ne fosse voluto sottolineare la non eccezionalità. Uomini e donne miti, modesti, e tuttavia animati da una ferma consapevolezza della propria diversità e della necessità di proteggerla. Con discrezione. Ecco la parola: sembrano personaggi ritagliati da un libro, recensito da “La Repubblica” qualche mese fa ma non ancora tradotto in italiano: La discrétion, di Pierre Zaoui, pubblicato dalle parigine Édition Autrement. Vi si parla di persone che praticano “una forma felice e necessaria di resistenzan. (…) lontana dalla dissimulazione, dal calcolo prudente, o dalla paura d’esser vista, l’anima discreta offre una giusta presenza al mondo”. La discrezione: “l’esperienza di un tempo modesto che basta a se stesso”. Non una qualità da esibire, né un atteggiamento che possa generalizzarsi, dal momento che si tratta di un andar controcorrente: “la nostra modernità – sostiene Zaoui – non pare caratterizzarsi solo per una lotta sfrenata per il riconoscimento e la visibilità, ma in pari grado per una lotta sotterrane, più calma ma molto tenace, per l’anonimato et l’invisibilità.” Un fare sotterraneo, deciso ma tranquillo, non appariscente: non sono avventure eclatanti quelle che i personaggi di Giardini d’inverno vivono. Vicende, piuttosto, nelle quali si rapprende uno stile di vita in grado di farsi testimonianza che contraddice la banalità dei discorsi e il conformismo dei comportamenti, e per questo suscita timore. Perché “ciò che è banale ha l’unico merito di essere rassicurante”, e ciò che non lo è non solo può inquietare, ma suscitare osservazioni sarcastiche, sdegnose prese di distanza, o addirittura reazioni ostili (la signora che veste “come se fosse sgusciata da una cartolina seppiata degli inizi del Novecento” “non dovrebbero lasciarla andare in giro”, e l’uomo che si costruisce una casa piena di finestre e lucernari, vedrà la sua “casa di vetro” presa a sassate).
Man mano che si procede nella lettura si comincia a sentire una medesima aria circolare fra le pagine dei racconti che si susseguono, un significato che li accomuna, un gioco di rimandi che li tiene saldamente insieme, senza che si ricorra all’espediente ormai collaudato di far incontrare, a un certo punto, tutti i personaggi, come avviene in tanti film, francesi soprattutto. I protagonisti di Giardini d’inverno marciano ognuno per la propria strada. Solo in un paio di casi si incrociano, comparendo uno nel racconto dell’altro ma senza interferire più di tanto. Per il resto, si attengono a una coerenza che ogni inizio di racconto ci presenta come un tratto di lungo periodo, da tempo praticata. Non enunciata, da chi scrive, ma che sta al lettore intuire dai gesti e dalle parole, poche, dei personaggi.
Si tratta di “collezionisti” nei quattro racconti della prima sezione, di sognatori o abitanti di “altrimondi” nella seconda, di ascoltatori attenti della “lingua delle cose mute” nell’ultima. Tutta gente che nello scegliere tra l’avere e l’essere non hanno dubbi. Non occorre possederle le case in cui ci piacerebbe abitare: basta assegnare ad ognuna il mese in cui preferiremmo farlo. E sono del tutto immateriali i pezzi che insegue la collezionista di stagioni, riconoscendole nel suono struggente dei garriti delle rondini, in profumi e odori evanescenti, nella sensazione tattile del velluto di muschio che avvolge il tronco di una pianta: non è la contemplazione della caducità che la donna coltiva, ma proprio il suo opposto. Lei, delle stagioni cerca “quello che non cambia”: nel loro divenire scova l’essere. L’essere di un tempo ciclico, e già questo rappresenta a ben vedere uno scarto, non una contestazione ma uno scostamento netto rispetto al tempo rettilineo che imperativamente ci domina, sin nel profondo.
Così come dilagante e contagioso è l’uso distratto, omologato delle parole: occorre riconoscerne la fisionomia, verificarne la rispondenza con noi stessi, apprezzarne addirittura la carica erotica per farne oggetto di collezione, e in questo modo contrastarne l’usura. Ma è altrettanto possibile e motivato raccogliere invece sassi, uno diverso dall’altro e anche per questo suscettibili di farsi segno della unicità di ognuno di noi, memoria inconfondibile di chi se n’è andato. E’ difficile non ritrovare in questa sensibilità, che ravvede significati umani anche nell’inorganico, una suggestione analoga a quella che doveva aver mosso l’anonimo collezionista di sabbia – sabbia grigia del Balaton, bianchissima del Siam, rossa del Senegal – la cui opera Italo Calvino aveva visto a Parigi (e dove se no… Parigi è punto di riferimento ricorrente nei racconti di cui parliamo). Un collezionista, quello, che è inevitabile sentire fratello della Irma che raccoglie sassi. Un collezionista, spiega Calvino, che “sapeva dove voleva arrivare: forse proprio ad allontanare da sé il frastuono delle sensazioni deformanti e aggressive, il vento confuso del vissuto”.
Ma in fondo non è proprio questo l’orizzonte non solo di Cuore di pietre, ma anche degli altri racconti di Paola Baratto? Non è questo il filo che ne fa un unico romanzo? “Come nelle poesie e nelle canzoni le rime scandiscono il ritmo, così nelle narrazioni in prosa ci sono eventi che rimano fra loro”: è lo stesso Calvino a ricordarcelo in una delle sue Lezioni, quella sulla rapidità.
Senza trascurare altri fili, certamente. Situazioni che tornano e via via si precisano nella ricchezza dei loro significati. Il silenzio innanzitutto. Non un vuoto, tutt’altro, essendo che “se la musica è ordita da innumerevoli combinazioni di note, lo stesso vale per il silenzio” (parole che sembrano quelle di Mario Brunello, nel suo trattatello recentemente dedicato, appunto, al silenzio).
Basta saperlo ascoltare, il silenzio. Sarà allora possibile rendersi conto che “anche il più piccolo frutto maturo possiede un suo relativo fragore, nell’istante in cui spacca la buccia”, e che non c’è “nulla di più variegato e multiforme del tacere degli esseri umani” (mi torna in mente quell’aneddoto dell’incontro fra Borges, ormai cieco, e Calvino, che la reverenza per il maestro rende più taciturno del solito: “L’ho riconosciuto dal suo silenzio”, risponde più tardi Borges a chi gli domanda come ha fatto a capire che fra le persone che erano andate a visitarlo c’era anche lo scrittore italiano).
Il silenzio, parente stretto della trasparenza (“il vetro è trasparente come il silenzio, tutto lo attraversa”), ma anche delle ombre, “quel risvolto inseparabile dai corpi, dalle cose”, presenza silenziosa, “gemello muto” degli esseri viventi. E’ fotografando le ombre dei suoi clienti che Adele ne coglie i sentimenti inespressi, o inconfessabili, così come è guardando attraverso la nebbia che avvolge la sua casa di pianura che Fausto impara a “leggere tra le righe delle frasi dette per calcolo, per compiacenza, per ipocrisia”.
Un altro tratto comune ai protagonisti: la calma, la lentezza. Di fronte ai capolavori pittorici conservati nei musei Bianca – che non è una monaca, ma un’”ispettrice in ambito turistico”, costretta dal suo lavoro “a spostarsi da una città all’altra”- si concedeva d’indugiare”, “si godeva la pausa”, e uscita dal museo amava il “passeggio senza meta”, la flânerie, ma anche il sostare “dietro le vetrine scintillanti d’una brasserie, ch’era poi, ugualmente, una forma di flânerie sedentaria”. E’ questa propensione alla lentezza che le permette di abitare i quadri che ama, di “inoltrarsi dentro una dimensione temporale cristallizzata, esclusa dall’ingranaggio inarrestabile dello scorrere”.
Non solo le opere d’arte, però, rappresentano interlocutori essenziali. Anche le cose suscitano una pietas che sa interpretare la loro “lingua muta”, e fra di esse soprattutto gli “oggetti vecchi, ossidati, opachi” (come capitava a Brecht: “Fra tutti gli oggetti i più cari”, notava, “sono per me quelli usati. Storti agli orli e ammaccati…): “gli utensili dozzinali d’uso quotidiano” per i quali Gabriele sente “una specie di pena” e che esita a buttar via, che raccoglie addirittura quando li vede abbandonati vicino a un cassonetto dei rifiuti, “relitti domestici senza più domus”.
Motivi e atteggiamenti che, si diceva, danno unità ai dodici racconti (solo dodici purtroppo), ma che non si limitano a questo. O meglio: se questo è il loro effetto è perché non sono che gli aspetti di una stessa critica. Una critica che non si vuol argomentare, che resta lontanissima da ogni intento di persuasione e ancor meno di polemica. Si direbbe che l’autrice condivida la propensione di Adele, la “fotografa delle ombre”, che “da qualche tempo disertava la chiarezza e preferiva lasciare ad altri l’incombenza spugnosa delle spiegazioni”. Non è lo sguardo che si accanisce criticamente quello che si è indotti da questa lettura a rivolgere al nostro mondo. E’ invece uno sguardo che sa cogliere qui dove siamo l’altrove di cui avvertiamo un bisogno vitale. Un altrove in cui regnano – ripetiamolo – il silenzio, la trasparenza, le ombre, la lentezza: basta pensarne il contrario e si ricavano, per contrasto, i caratteri del mondo in cui viviamo: il rumore e la chiacchiera, l’ opacità e insieme la luce cruda e abbagliante che illumina le merci (cioè tutto, tendenzialmente), la velocità ossessiva, la non affezione per le cose che usiamo e gettiamo.
Uno sguardo capace dunque di pazienza e fermezza insieme, di spietatezza e dedizione allo stesso tempo. Ma che soprattutto sa rivolgersi sempre indirettamente a ciò che osserva. Allo stesso modo di Perseo, che non posa i suoi occhi “sul volto della Gorgone ma solo sulla sua immagine riflessa nello scudo di bronzo”, in ciò offrendoci “un’allegoria del rapporto del poeta col mondo, una lezione di metodo da seguire scrivendo”: “è sempre in un rifiuto della visione diretta che sta la forza di Perseo – siamo alla Lezione sulla leggerezza adesso – ma non in un rifiuto della realtà del mondo di mostri in cui gli è toccato vivere, una realtà che egli porta con sé, che assume come proprio fardello.”
Ecco. Prendere le distanze dalla realtà del mondo è forse il modo (l’unico, oggi?) per non nascondersi l’inevitabilità di portarne il fardello.
Gira e rigira è sempre a Calvino che mi riportano i passi che muovo in questi Giardini d’inverno, a conferma del fatto che “la leggerezza è qualcosa che si crea nella scrittura”, in una scrittura come questa, prova convincente e viva della “funzione esistenziale” che può avere la letteratura quando si fa “reazione al peso del vivere”.
E’ solo a questo punto che quel senso di conforto, e di pacata fiducia, di cui dicevo all’inizio mi si chiarisce, e posso individuarne la fonte: nella voce che trascorre in queste pagine. La voce che con parsimonia i personaggi fanno sentire è la stessa che guida la scrittura di questi racconti. Apparentemente svagata, mai assertiva, e pure decisa nella sua scelta.
Ancora Calvino, quello delle Città invisibili stavolta: “L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio.”
È questo secondo modo che Paola Baratto ha scelto. Di qui viene la voce che ci ha dato questi sommessi, poetici minima moralia.