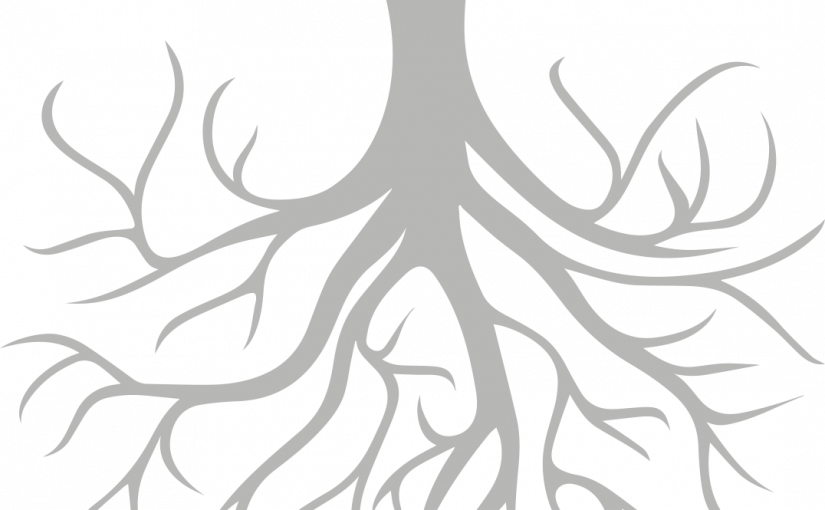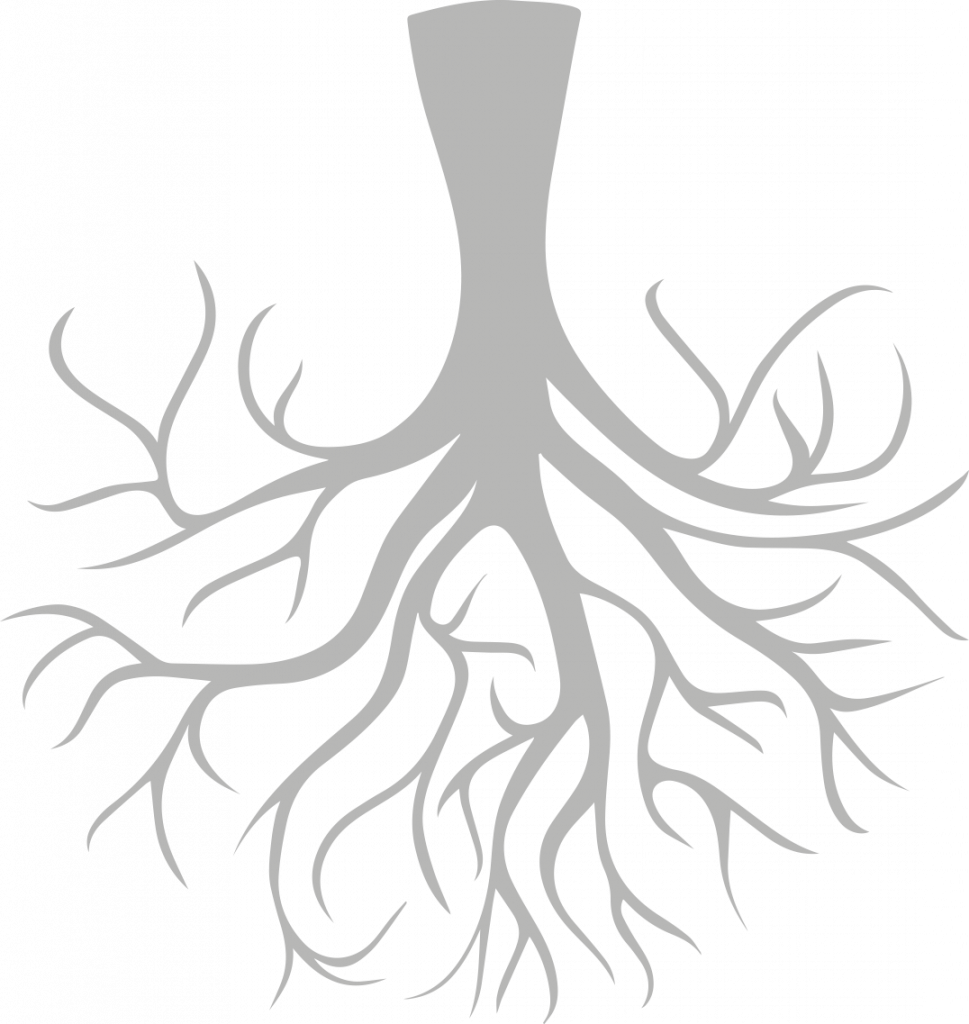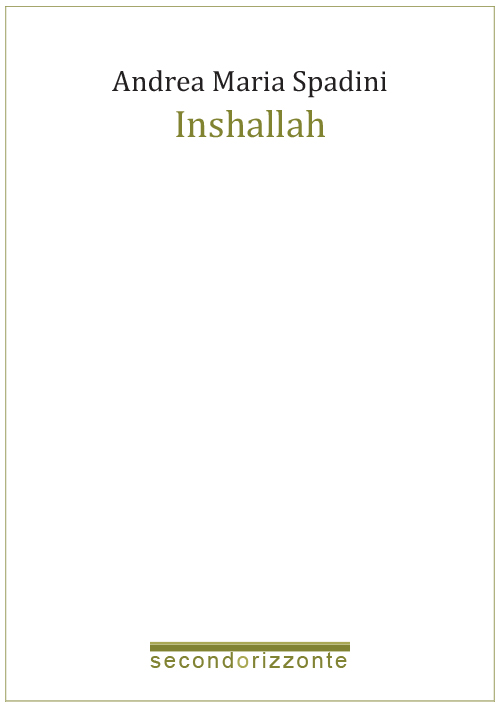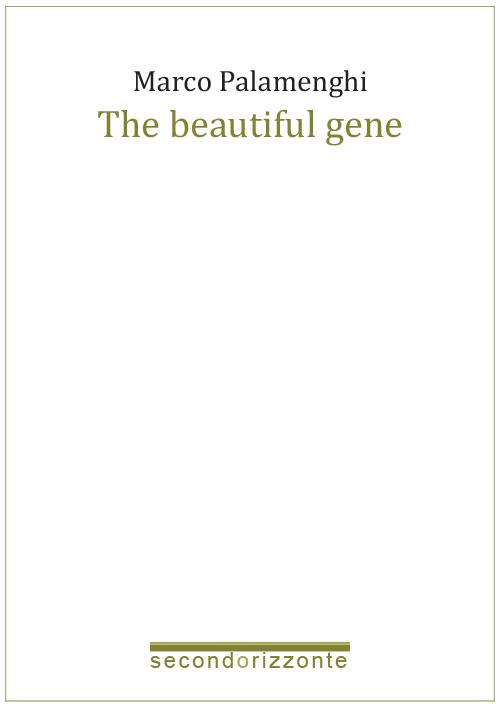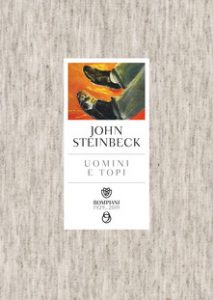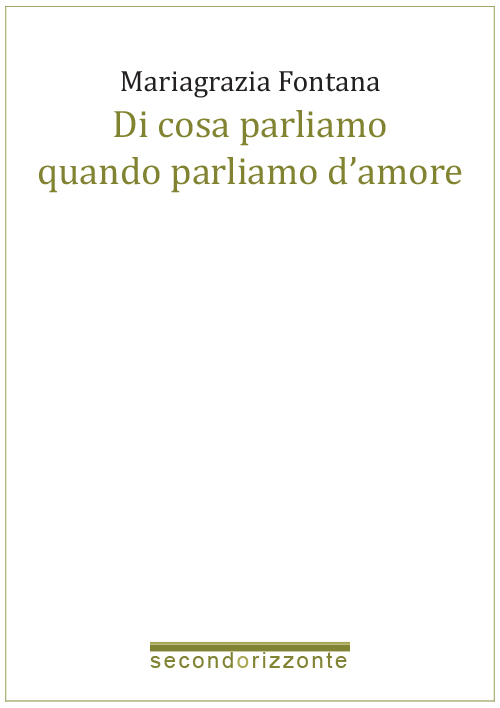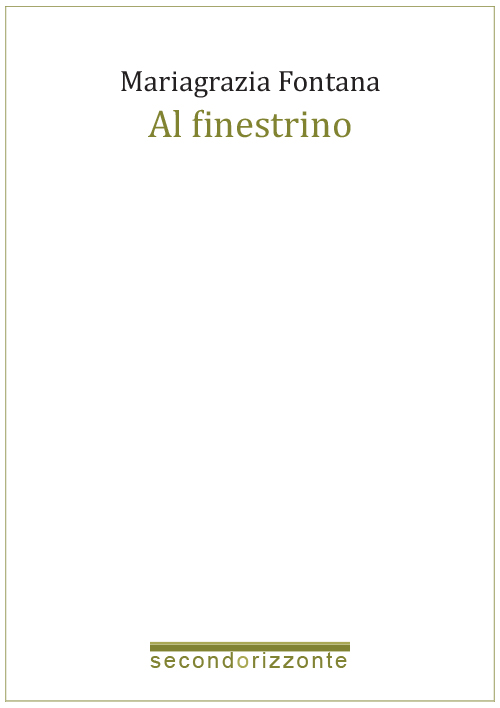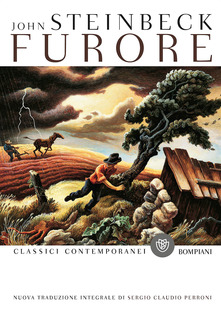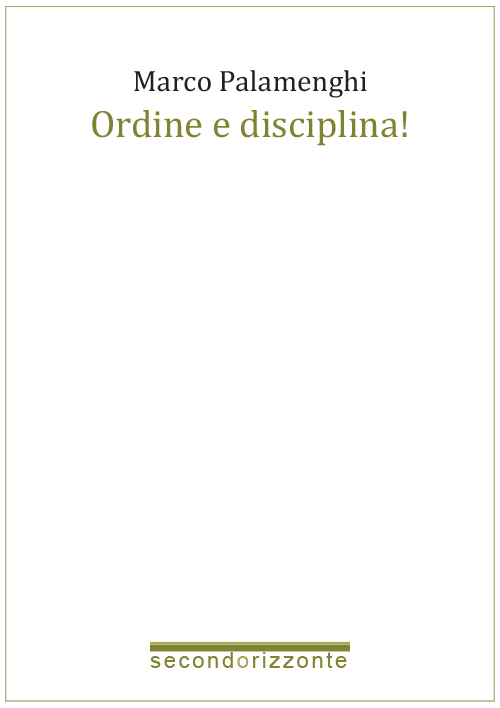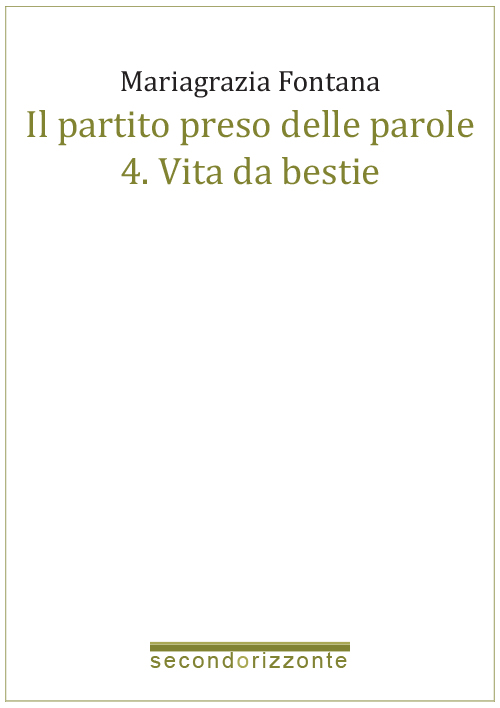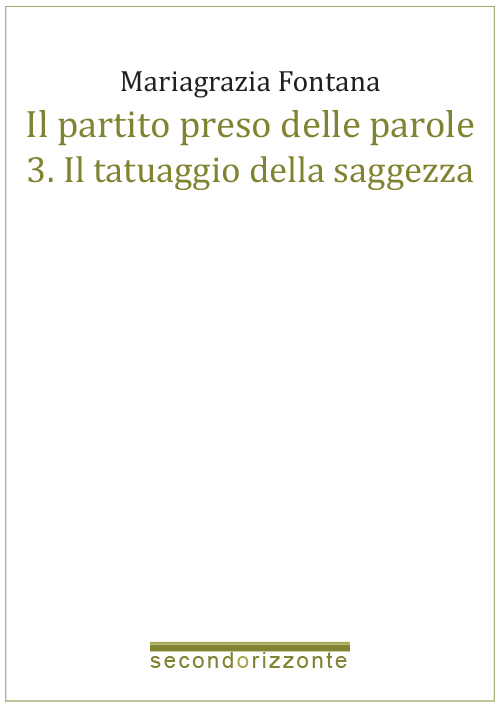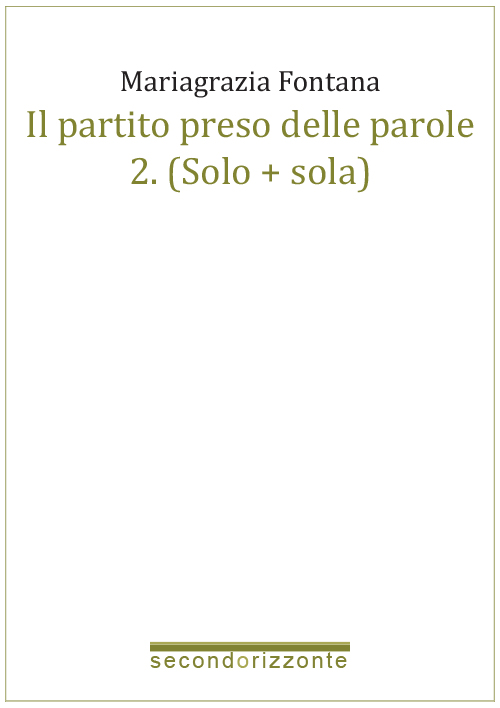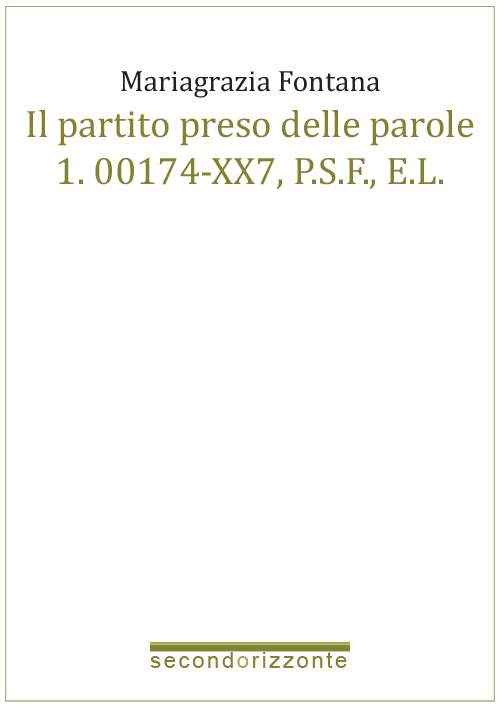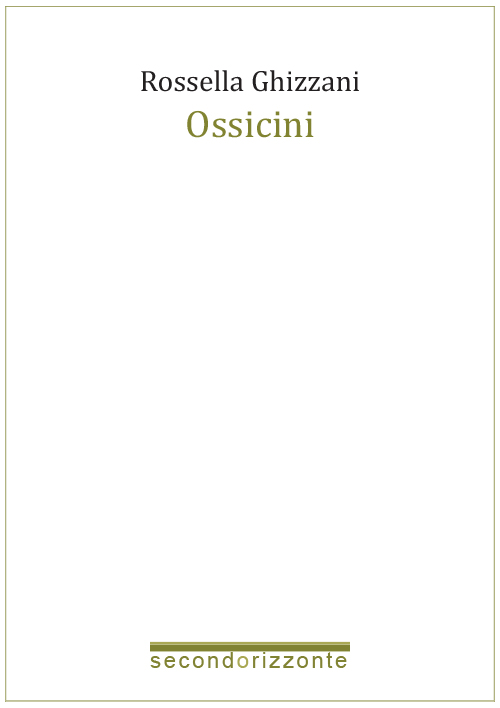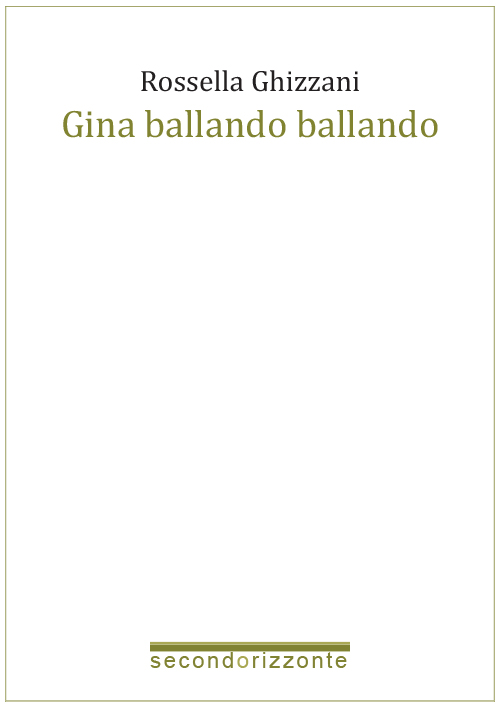Un racconto e i suoi rami: la “Storia di T.” è stato lo spunto per un gioco narrativo cui hanno partecipato alcuni degli amici di secondorizzonte: ognuno di loro si è provato a proseguire e concludere a suo modo il racconto dando vita così a sette nuove storie.
Storia di T.
di Carlo Simoni
Questa è la storia di T., un uomo non più giovane e non ancora vecchio, e dei ventitré anni che visse – ma non sapeva di aver ancora da vivere – dopo aver deciso che doveva fare una cosa ben precisa: chiedere scusa a tutti coloro ai quali riteneva di aver fatto un torto.
Aveva in mente solo un paio di nomi, il giorno in cui gli venne questa idea: S., al quale si era rifiutato – una trentina d’anni prima – di prestare gli appunti del corso universitario che lui aveva seguito diligentemente, al contrario dell’amico che invece a lezione c’era andato secondo l’umore del giorno; D., al quale aveva portato via – non per una volontà precisa, ma era andata così – la donna con la quale stava da parecchi anni, come fossero sposati; F., una collega che a un certo punto, non più d’una decina d’anni prima, aveva sostituito nel ruolo che quella da tempo sperava di assicurarsi: non che le avesse fatto le scarpe, come si dice, ma è un fatto che di quello che lui sapeva i capi stavano decidendo si era ben guardato dal parlarle, e così la sua responsabilità e il suo stipendio erano migliorati. Il suo, non quelli di F.
Torti molto diversi fra loro, com’è evidente, di quelli che possono essere ridimensionati, liquidati addirittura, da un così è la vita. Così è la vita: nei rapporti di amicizia come nelle faccende sentimentali e nei posti di lavoro.
Ma T. aveva deciso che se sentiva una ragione per chiedere scusa non avrebbe dovuto star lì a pesare la gravità delle sue azioni, né a valutare le conseguenze che effettivamente ne erano derivate. Perché era convinto che altrimenti avrebbe potuto tranquillamente concludere di non aver poi fatto succedere il finimondo, di non aver rovinato l’esistenza a nessuno eccetera eccetera, e dunque non c’era motivo di scusarsi. Né del resto le conosceva davvero, quelle conseguenze: S. s’era laureato anche lui, alla fine; D. non si era suicidato perché la sua donna l’aveva lasciato, non era passato un anno che era già con un’altra; F. ci lavorava ancora in quel posto, e la sua carriera l’aveva fatta comunque.
Ma non era questo il problema. La questione riguardava lui. Il suo bisogno di chiedere scusa. Indipendentemente dall’esito che il suo gesto avrebbe avuto, se avvertiva di aver fatto un torto, piccolo o grande che fosse, quale che fosse l’ambito di relazioni nel quale s’era compiuto, lui sentiva di dover tornare dalla vittima, se la vogliamo chiamare così: ricordarle quel periodo, quel fatto, se nel vederlo non le fossero tornati subito alla mente. E chiederle scusa. Non si trattava di ottenerne il perdono, o meglio: se qualcosa del genere fosse accaduto ne sarebbe stato contento, ma nel suo proponimento di riavvicinare la tale o il tal altro non doveva giocare alcuna valutazione preliminare delle probabilità che ciò avvenisse.
La lista si era andata allungando, e per ogni nome T. aveva cominciato a rintracciare recapiti, numeri telefonici, indirizzi e-mail. Anche se escludeva di risolvere la cosa a distanza. Quei dati dovevano servirgli solo per stabilire il primo contatto, buttar lì un pretesto per rivedersi, ipotizzare il giorno e l’ora in cui sarebbe andato. Perché, non ne sapeva esattamente la ragione, ma gli pareva essenziale che fosse lui a recarsi dall’altro, a casa sua, o comunque nel luogo in cui viveva. Alcuni infatti non stavano nella sua città. O non ci avevano mai abitato, o si erano trasferiti.
Era deciso. Avrebbe cominciato con uno a caso, facendo un sorteggio magari, poi via di seguito. Senza tener conto del tempo che era passato dal fatto. E qui un dubbio, o piuttosto un malessere, lo prendeva: aveva già annotato un paio di nomi di persone che avevano continuato a vivere nella sua stessa città, così come ne aveva appuntato almeno uno – ma sapeva che altri se ne sarebbero aggiunti – al quale il torto l’aveva arrecato di recente. Molto di recente. Decise di fare un elenco a parte per questi, così vicini, nello spazio e nel tempo, e di rimandare l’approccio con loro. Non di escluderlo, questo no, avrebbe guastato l’intero suo proposito, ma di non prevederlo nell’immediato.
Era tutto pronto dunque. Appena finita l’estate avrebbe cominciato. Dal primo.
Ancora qualche bagno, un po’ di sole, la festa dell’ospite di fine agosto e poi sarebbero tornati in città, e lui si sarebbe fatto sentire dal primo della lista.
Ed è stato proprio lì, attorno ai fuochi e alle grigliate di pesce sulla spiaggia, fra chitarre e fisarmoniche, che ha incontrato P. Erano sei, forse sette anni che non lo vedeva. Da quando aveva lasciato il lavoro che faceva per passare a quest’altro che pochi giorni dopo lo attendeva.
Erano diventati amici, lui e P., che pure era molto più giovane di lui. Proprio per questo forse: un’amicizia in cui c’era qualcosa del rapporto tra il fratello maggiore e quello più piccolo. Niente di paterno. T. aveva aiutato P., lo stimava, gli piaceva la sua passione per il lavoro ben fatto. Era stato questo ad accomunarli.
Ebbene, non appena i loro rapporti di lavoro erano cessati, P. non s’era più fatto sentire. T. l’aveva cercato, gli aveva proposto cene, occasioni per fare viaggetti, cose da fare insieme come una volta, ma P. niente. Non sono pochi quelli che, come cambi lavoro, tagliano di netto: la loro cordialità non era che interesse, è evidente. Ma da P. non se lo sarebbe proprio aspettato. Ne era rimasto ferito. Confuso prima, e poi ferito, appunto.
Avrebbe potuto fingere di non averlo visto, o limitarsi a un saluto da lontano. Invece gli era andato incontro, senza deciderlo, come fosse la cosa più naturale da fare, l’unica cosa possibile: l’aveva abbracciato, non badando al sorriso imbarazzato di quello, l’aveva fatto sedere al tavolo dove stavano sua moglie, i suoi figli, i suoi amici, aveva offerto a P. e alla ragazza che lo accompagnava grigliata e vino bianco. Il chiasso copriva le voci, non s’era neanche posto il problema di rievocare vecchi tempi, di scambiarsi le domande di prammatica, cosa fai adesso, come ti va eccetera. Solo qualche battuta su quelli che c’erano lì intorno, un commento su come andavano le cose, la politica, il lavoro, cose così.
A fine serata si erano salutati, una stretta di mano, un arrivederci senza alcun cenno al quando.
E qui, per T. era nata l’idea di un’altra lista da scrivere: la lista di quelli dai quali gli sembrava di averlo ricevuto, il torto, di quelli che l’avevano fatto restar male, o l’avevano fatto davvero soffrire.
Andare anche da questi: per sapere – senza la minima recriminazione, senza alcuna pretesa di ottenere spiegazioni e tanto meno scuse – la ragione per cui quella volta avevano detto, avevano fatto… O non avevano detto, non avevano fatto.
Tutto qui. Anche se non sapeva se sarebbe stato sempre bravo come con P. perché certe cose gli bruciavano ancora. Ma comunque voleva provare. Sentiva di non poter mettersi a pensare questo sì e questo no. Se uno di quelli che in qualche modo l’avevano offeso, o addolorato, gli veniva in mente, il suo nome doveva metterlo, in ogni caso.
A fine settembre le due liste erano abbastanza lunghe. La prima, quella dei torti fatti, soprattutto. Anche perché, rileggendola, si era reso conto di avervi incluso anche nomi di persone alle quali non aveva ragione di chiedere scusa, ma che sentiva ugualmente di dover raggiungere per dire un grazie. Non scusa ma grazie. Grazie perché in una particolare situazione gli erano state vicine, magari senza fare o dir nulla di speciale: gli si erano fatte sentir vicine, ecco. Oppure perché, anche senza averne precisa intenzione, gli avevano dato un’indicazione sul come fare una data cosa, o sulla direzione da prendere a un certo punto della sua vita, un incoraggiamento insomma, esplicito e meno che fosse stato. E a queste persone lui non aveva saputo manifestare la sua gratitudine: per sbadataggine, o pudore, o… avarizia. Quell’avarizia del cuore che non si sa o non si vuole riconoscere come tale e dalla quale ci si ritiene comunque esenti, come potesse riguardare sempre e solamente gli altri. Sicché quei grazie, in fondo, erano riparatori. Per questo si era ritrovato a includerne i nomi dei destinatari nella stessa lista delle scuse.
Alla fine, seppure non complete, né l’una né l’altra, si è detto che le due liste andavano chiuse. Il rischio, se no, era di contentarsi di averle scritte e di aggiungervi un nome oggi e uno domani, senza mai mettere in pratica il proponimento da cui erano nate.
E dunque, T., appena tornato in città, cominciò.
Prima, la mamma di Aurora Sorsoli
Una nuova mano di carte di Giovanni Locatelli
L’ultimo dei giusti di Andrea Spadini
Un’anima fragile di Mariagrazia Fontana
Il faggio di Delfina Lusiardi
Il folle piano di T. di Marco Palamenghi
Vizi capitali di Rossella Ghizzani
Prima, la mamma
di Aurora Sorsoli
E dunque T. appena tornato in città cominciò, ma, si sa, è più facile l’intenzione dell’azione.
Per giorni l’indice della mano destra percorse l’elenco dall’alto verso il basso e viceversa: da chi cominciare? Forse era più sano, e da usare come allenamento, iniziare con i peccati meno gravi, come da piccolo in confessione, così avrebbe capito che parole usare, come introdurre il discorso, dove ambientare la conversazione. Avrebbe imparato a cogliere le espressioni, gli sguardi per poter dosare le parole e ammorbidire le eventuali reazioni negative. Sì, questo era già un passaggio.
Stilò un elenco in ordine di gravità e passò così un’altra settimana.
Era pronto, l’indice. Restò senza lavoro. Se quello era il criterio bisognava partire dal primo in lista, tale Ernesto, compagno di banco in seconda media sospeso per un giorno e malmenato dal padre che, si sapeva, era uomo violento, perché accusato, al posto suo, di aver manomesso in malo modo il registro.
Però … mah… chissà come reagisce…
Il fatto era che Ernesto, un tipo grande e grosso, che ancora abitava nel suo vecchio quartiere, nelle case popolari, nell’ultimo palazzo, il primo costruito negli anni ’60 per gli immigrati meridionali che venivano a lavorare nelle fabbriche del nord (il quartiere era appena dopo il parco del residence di lusso dove ora T. viveva)… Insomma, lui era grande, grosso e un tipo rognoso con precedenti per violenza e qualche anno di carcere e T., in verità, lo aveva incrociato qualche volta ma sempre aveva finto di non riconoscerlo: andare a suonargli il campanello per raccontargli questa vecchia storia… mah… chissà… boh… Era perplesso.
Forse anche questo elenco, di piccoli peccati, andava messo in ordine non solo di gravità ma anche tenendo conto delle personalità, dei caratteri e della storia di ciascuno.
L’indice iniziò nuovamente a scorrere l’elenco. T. vide i nomi, le facce, ma alcuni avevano ancora un viso giovane dopo venti, trenta, quarant’anni dal fatto? Non era possibile.
Così passò un’altra settimana. Provò sui social e alcuni furono così ritrovati e visualizzati. Alcuni riconoscibili, altri no, non era nemmeno certo che fossero loro, così diversi.
Roberta, per esempio, la bruttina, grassoccia e impacciata collega di tanti anni prima, era diventata una snella e affascinante cinquantenne, mentre lui era ormai pelato e grassoccio, impresentabile. Pensare che al tempo l’aveva snobbata: lui, quarantenne elegante e in carriera, di donne belle ne aveva quante voleva. Chissà… forse l’avrebbe trattato da vecchietto rincoglionito se lui si fosse presentato per scusarsi di come l’aveva trattata allora…
No no non voleva umiliarsi così.
L’indice riprese a ripercorrere l’elenco: che strano, si era fermato a Mamma. Beh… mah… Sì, tutto sommato gli sembrò un buon inizio: le ho fatto torti – pensò –, me ne ha fatti, ma devo dirle anche grazie…
Così, prese il suo primo appuntamento…
Una nuova mano di carte
di Giovanni Locatelli
T. non ricordava quando aveva inserito sé stesso nella lista degli amici da ringraziare. Non si era mai considerato un self-made man, uno che si è fatto con le proprie mani al punto da darsi una pacca sulle spalle da solo, eppure nell’estrazione per decidere da dove partire, proprio il suo nome era uscito per primo. Viste le due cose in croce che era riuscito a combinare nella vita, poteva sbrigarsela in pochi minuti: birra, balcone, sigaretta, calda sera di fine estate – ecco celebrati i suoi successi.
Successi… quali successi? Credeva davvero di aver messo a frutto i talenti che il Signore gli aveva affidato? Non li aveva piuttosto seppelliti sotto ore di inutile ufficio, fra colleghi che pensavano solo a mangiare o a essere mangiati – tipo F. – o sprecati gozzovigliando nei bar in città, con amici che poi si erano rivelati meri conoscenti, svaniti alla prima occasione – gente come P. insomma. Ma non era P., o F., che doveva biasimare: le critiche spettavano a lui soltanto, per non aver cercato, provato, insistito fino alla morte.
Altro che grazie! Asino, doveva darsi dell’asino per quella volta con J., si ritrovò a pensare. Aveva sedici anni, suonava la chitarra niente male, sapeva stare sul palco ancheggiando e dimenandosi come la moda rock and roll cominciava a prescrivere anche nel Bel Paese, con grandi mani che occupavano la scena, e aveva avuto la fortuna sfacciata di farsi sentire da J., sì, proprio quel J., di passaggio durante l’unica tournée italiana nella sua breve, fulminante, sfolgorante carriera.
«Stai facendo bene, amico», aveva detto J. con un italiano bislacco, imparato lì per lì.
«Grazie», aveva risposto T. arrossendo.
«Wanna join us?» aveva continuato, sfruttando la traduzione simultanea del suo agente per proporre a T. di unirsi alla carovana in qualità di roadie, il ragazzo che accorda le chitarre e prepara la strumentazione in genere.
T. non aveva saputo rispondere. Mollare tutto e partire così. C’era sua madre… c’era una ragazzina che cominciava a guardarlo, a tenerlo per mano… c’erano gli amici…
J. inconsciamente sapeva di avere i giorni contati e che un incidente o un’overdose un infarto un sospetto suicidio l’avrebbe stroncato entro pochi anni: non aspettava mai, agiva e basta. Non aspettò neppure T., si allontanò salutando con la mano, improvvisando con le lunghe dita affusolate una scala in mi bemolle maggiore.
T. rimase incastrato in quell’istante: non ho sfondato perché sono un codardo, non ho sfondato perché sono un idiota, non ho sfondato perché ho passato la mano, si ripeteva, sognando ogni notte quelle dita che, passando da una nota all’altra, scivolavano lontano da lui e dalla sua unica occasione di emergere dall’anonimato. Quelle mani lo ossessionavano, l’anonimato lo inghiottì.
Si fece adulto sovrappeso, impiegato stressato, marito fedele, padre apprensivo. Non prese mai più in mano una chitarra, ma di tanto in tanto, la sera, se la stanchezza lo costringeva ad abbassare la guardia, si sorprendeva a ripetere la scala di mi bemolle maggiore con rapide dita.
Non era tipo da restare con le mani in mano: cercò un nuovo hobby, scelse il poker. Nel frattempo J. era morto. T. non ci pensò più. Era passato un secolo in un secondo, da allora.
T. finì la birra in un sorso, spense la sigaretta sulla ringhiera di ferro del balcone, scagliò il mozzicone facendo scattare l’indice, fino a un secondo prima trattenuto dal pollice nella posizione di OK, depennò con un colpo di mano il suo nome dalle tre liste, quella dei “grazie”, quella degli “scusa”, quella dei “senti un po’ tu, stronzo, ricordi quella volta che” – era finito in ciascuna, a quanto pareva – e procedette a una nuova estrazione, una nuova mano di carte, in un certo senso, convinto della bontà del suo proposito, nonostante quella falsa partenza.
L’ultimo dei giusti
di Andrea Spadini
Erano già passati due anni ma ricordava molto bene la vicenda che aveva gettato il seme da cui era germogliata quest’idea dello scusarsi. Non che allora ci avesse pensato, no, ma ora questa cosa gli era perfettamente chiara. Sì, era nato tutto da lì…
“Ciao T., Sono G. Ti disturbo?”
“No, figurati. Sono felice di sentirti.” gli aveva risposto, mentre cercava di controllare la solita ondata di senso di colpa che lo investiva ad ogni telefonata dell’amico.
“Volevo solo farti gli auguri di Natale. Come stai? E M., tutto bene?”
“Si, si, tutto bene. Stiamo preparando il pranzo. Quest’anno abbiamo qui nostra figlia con il suo compagno e ho il sospetto che M. abbia un po’ esagerato con le portate. Vorrà dire che mangeremo gli avanzi per l’intera settimana.”
“Come ti capisco. Anche noi festeggeremo con i miei figli e le loro mogli. D. è barricata in cucina da tre giorni. Mi ha vietato di entrare perché dice che ai fornelli faccio solo disastri. Non ha tutti i torti, come ben sai… Ora ti lascio ai tuoi impegni. Salutami tanto M.”
“Grazie G. Tanti auguri anche a voi. Ci sentiamo presto.”
Quando stava per riattaccare, aveva sentito l’amico aggiungere, con tono fattosi serio: “Sì, però mi telefoni tu. Io non lo farò più. Il mio numero ce l’hai. Ciao T.” e, con un sussurro, aveva aggiunto: “Ti voglio bene.”
Aveva raggiunto sua moglie in cucina. Era china sul tavolo infarinato, ingombro di ravioli.
“Dai T., dammi una mano con questa striscia di pasta. Hai visto come faccio, no? Metti il ripieno e poi… Ma che cos’hai? C’è qualcosa che non va?” gli aveva detto dopo avergli rivolto uno sguardo, “Sei pallido. Chi era al telefono?”
“Era G. Voleva farci gli auguri.”
“Che carino… Come stanno lui e D.?” e, senza attendere la risposta, aveva proseguito: “Prima o poi dovrai deciderti a sciogliere questo nodo che ti avvelena l’anima. Lui ti vuole molto bene, questo lo sai. Beh, ora dammi una mano con questi ravioli, altrimenti oggi chissà a che ora pranziamo…”.
Si conoscevano fin dall’infanzia, lui e G. Allora abitavano nello stesso quartiere della periferia milanese, in due condomini popolari poco distanti. Per anni erano stati inseparabili, prima nei giochi di strada e nel campetto dell’oratorio, poi nella passione politica e nella militanza, entrambi con la certezza di poter sempre contare l’uno sull’altro.
Quando, anni dopo, G. si era dovuto trasferire in un’altra città per lavoro, i loro incontri si erano fatti più saltuari, ma quando si ritrovavano era sempre come se si fossero lasciati solo la sera prima. Una speciale alchimia faceva sì che i fili del loro rapporto si riannodassero sempre all’istante, senza nessuno sforzo.
Si erano rivisti al funerale della madre di T.
G. ci era andato solo, senza la moglie. Allo sguardo interrogativo dell’amico aveva risposto confidandogli la crisi del loro matrimonio. Dopo mesi di litigi aveva preso la decisione di andarsene da casa, almeno per un po’. Anche D. era stata d’accordo. Sì, aveva una relazione. In un altro momento gli avrebbe spiegato meglio.
Dopo una quindicina di giorni G. lo aveva chiamato. Avrebbe voluto andare a trovarlo quel fine settimana. T., felice della proposta inattesa, aveva acconsentito subito. Non stava attraversando un periodo facile: la recente morte della madre, la grave depressione del padre che ne era seguita e che non sapeva bene come gestire… Gli avrebbe fatto sicuramente bene la compagnia dell’amico. Già si immaginava la nottata che avrebbero trascorso a parlare davanti a un paio di bottiglie di vino. Quando G. gli aveva chiesto il permesso di portare con sé un’altra persona lo aveva colto un po’ alla sprovvista ma, a quel punto…
Era arrivato il venerdì sera accompagnato dalla sua nuova compagna, amante o chissà che.
T. e la moglie li attendevano con la tavola imbandita. Per l’occasione avevano anche spedito la figlia a dormire dagli zii per liberare la stanza da offrire ai due ospiti. Nonostante il loro impegno, la serata era stata, a dir poco, difficile. La conversazione che avevano cercato di animare era stata un supplizio, piena di argomenti da evitare, di incognite impreviste e di gaffe in perenne agguato. G. non li aveva certo aiutati, sempre torvo e silenzioso, con lo sguardo smarrito in chissà quali pensieri. I due giorni seguenti, se possibile, erano stati addirittura peggio. Nei rari momenti in cui T. e l’amico erano riusciti a rimanere soli, G. lo aveva sommerso di parole con cui gli descriveva l’amore che provava per quella donna e il futuro che immaginava di costruire con lei. T. aveva provato ad interrompere quel flusso incontenibile, almeno per potergli esprimere alcune delle sue numerose perplessità. Presto si era reso conto dell’inutilità dei propri sforzi, perciò si era silenziosamente arreso e lo aveva lasciato proseguire, senza prestargli più molta attenzione. Gli era sembrato completamente fuori di sé. G. era talmente assorbito da questa vicenda che non aveva sprecato nemmeno una parola per chiedergli come stava. Nemmeno una parola in un intero fine settimana.
Erano trascorsi quasi dieci anni da quei giorni e ancora non era riuscito a perdonarlo. Forse, se allora avesse avuto la forza di affrontare con lui la questione, le cose si sarebbero sistemate. Ma T. in quel periodo si sentiva come uno straccio logoro, sempre sul punto di strapparsi. Non ne era stato capace. E poi non sono discussioni che si possono fare per telefono. Certo, avrebbe potuto affrontarlo di persona e magari farci una bella litigata. Ma non lo aveva fatto. Così il tempo era trascorso e il suo rancore si era indurito, incistandosi in un grumo sempre più difficile da scalfire. Nemmeno l’affetto che pure sentiva di provare ancora per l’amico sembrava in grado di contrastare quella sensazione di amarezza e risentimento. Ma allora perché tutte le volte che G. gli telefonava stava male?
Durante quelle vacanze natalizie, chissà come, si era trovato a discuterne con la figlia.
Dopo averlo ascoltato con attenzione, lei gli aveva detto: “Papà, scusa se te lo dico senza tanti giri di parole, ma chi ti credi di essere? Mister perfezione? Ricordati che anche le persone migliori possono sbagliare. A proposito di migliori, ma tu sei proprio sicuro di esserti comportato bene con G. in quell’occasione?”
“Che domanda… Ho accolto e ospitato lui e la sua amica, l’ho ascoltato vaneggiare per un intero fine settimana, che altro avrei dovuto fare?”
“Forse renderti conto che stava male quanto te, magari di più. Forse accorgerti che ti aveva cercato perché non sapeva più a che santo votarsi, e magari sperava che il suo migliore amico potesse aiutarlo a ritrovare il filo smarrito della propria vita… Ma invece no, tu eri troppo concentrato sul tuo ombelico per accorgertene, vero? Papà, tu non sei stato capace di guardare il suo dolore esattamente come lui non è riuscito a vedere il tuo. Diciamo che siete pari. Tu, con la tua aria da ultimo dei giusti, non sei stato migliore di lui, lo vuoi capire una buona volta? G. almeno ha continuato a chiamarti per tutti questi anni, tu cosa hai fatto?”
Lo aveva lasciato senza fiato. Nei giorni seguenti aveva ruminato a lungo le parole di sua figlia: poi, il giorno dell’Epifania, si era finalmente deciso.
“Ciao G. Sono T.”
“T., che bella sorpresa…”
“È tutto merito della Befana.”
“La Befana? Ma T…”
“Una Befana giovane e con le lentiggini, però sì, era proprio lei. Pensa che, invece di presentarsi con il solito sacco di carbone, se lo è venuto a prendere: e si è portata via quello di quest’anno e pure quelli degli anni passati. Sapessi come mi sento le spalle leggere… Non puoi immaginare che gran regalo sia stato…”
“Scusa T., ma non ho capito… Va tutto bene?” “Si, si, G., va tutto alla grandissima… Ascolta, mercoledì della prossima settimana sarò nella tua città per lavoro. Vorresti pranzare con me? Ho così tante cose da raccontarti… Prima però ti dovrò parlare di una cosa importante, una cosa che avrei dovuto dirti, anzi chiederti, già tanto tempo fa…”.
Un’anima fragile
di Mariagrazia Fontana
Ciao sono Tom, posso salire?
Tom chi?
Quel Tom, Tommaso Corradi, ricordi?
Tommaso Corradi – ripete lei a bassa voce ed è come se una bomba le esplodesse dentro. Dio mio, e proprio lui. E ora?
Poi la sua voce d’impulso, risponde d’un fiato al citofono: ok, terzo piano.
Con il cuore in affanno, intanto Tommaso sale sull’ascensore di quel palazzo signorile in Corso Sempione a Milano. Basco calato in testa, giubbotto un po’ sdrucito, non proprio lindo, capelli ora brizzolati ad accarezzargli il collo, il volto avviluppato da una fitta trama di rughe minuscole convergenti verso la bocca.
Da lì aveva deciso di iniziare l’impresa di chiedere scusa. Non era stato necessario soppesare i grammi di torto distribuiti negli anni, il nome di Giulia si era imposto come primo nella lista, poi come secondo, poi come terzo. Aveva riempito la pagina con il nome di lei, e scrivendo si era consentito, dopo decenni, di risvegliarla dentro di sé. Non l’aveva dimenticata, ma aveva dovuto addormentare quei giorni, rinunciare a spingere il cuore nei luoghi, ora aspri e disabitati, della loro vita insieme.
Era a Giulia che aveva fatto la peggior carognata. Da lei avrebbe cominciato. Superata quella stazione, il resto della via crucis sarebbe stato un gioco da ragazzi.
Perdona se non mi sono annunciato con una telefonata, temevo che ti saresti rifiutata di incontrarmi, così ho pensato di presentarmi di botto, come un ricordo che viene su dalla nebbia. Volevo scusarmi. No scusarsi non è il verbo esatto. Per ciò che ho fatto ci si deve genuflettere, chinare il capo come davanti a Dio, se mai esistesse, e battersi il petto. Ma non pretendo perdono, è solo che volevo rivederti dopo più di quarant’anni e dirti che mi dispiace di aver buttato via tutto.
Parlava a precipizio, come in carenza di fiato o di coraggio, come per superare un ostacolo, prodursi in un passo definitivo senza ritorno. E intanto la guardava: gli occhi sempre grandi come il mare che sapevano sparpagliargli i pensieri, la pelle ancora fresca, come se il tempo l’avesse dimenticata e da Corso Sempione non fosse transitato. Forse era lo sguardo del ricordo che la ringiovaniva, che la faceva ragazza. Tom arrivò a pensare che restare giovane fosse per lei una forma di resistenza, la più radicale di tutte: ubriacare il tempo e sottrargli forza.
Un leggero rossore sulle guance tradiva lo stupore di lei e sembrava affiorarle negli occhi. Era bella come allora. Il viso non perfetto, il naso un poco pronunciato non riusciva ad alterarne l’armonia, la quiete che sapeva irradiare quando percorrevano stretti stretti le strade di Milano, quando discutevano fumando, quando credevano di poter rivoltare il mondo come un calzino, da quelle due stanze al quarto piano senza ascensore in cui vivevano con poco. Felici come non sarebbero stati mai più nella vita, almeno lui.
Distolse lo sguardo da quel volto che lo precipitava indietro negli anni, gli faceva risentire l’odore della vita, lo risucchiava negli abbracci, nelle assemblee, nelle speranze incrostate di certezze, in quel futuro passato come un lampo. Il tempo è una bestia senza pietà, una strada senza meta, un progetto senza costrutto.
Mi sono giocato ciò che avevo di più caro come un idiota. Tu sai quanto ti amavo – le disse con gli occhi bassi, torturando con entrambe le mani il basco che s’era levato per darsi un contegno, per non starsene lì in piedi come un allocco, con le braccia a penzoloni. Certe cose sono difficili da dire, ma a un certo punto dell’esistenza chiedono di essere buttate fuori, modellate in parole che sappiano descrivere errori, rigidità, imperativi morali. Era per quelli che aveva gettato tutto alle ortiche, per l’urgenza della rivoluzione che bussava alle porte, per quel mondo che sembrava rovesciarsi da un momento all’altro.
Le parole che gli uscivano dalla bocca parevano, a lui per primo, insufficienti, porose, incapaci di dipingere l’accozzaglia di passioni che allora gli era infuriata dentro. Doveva estrarle una per una da tutte quelle disponibili per esprimere ciò che sembrava impenetrabile.
Si fermò d’improvviso, come in preda ad un’assenza, come intento a scavare nel suo vocabolario alla ricerca di un aggettivo, un avverbio, un verbo che potesse misurare il prezzo della sua fuga, come se dalle parole dipendesse la salvezza della sua anima.
Un uomo non anziano, ma sicuramente avanti negli anni, un poco ingobbito, il capo chino in un silenzio inclemente, come perso in una piega degli anni, che lucidava ricordi, tentava di narrare l’indicibile con sguardo febbrile.
Non che Tom non avesse amato più dopo di allora, ma amori meno travolgenti, meno sanguigni, più pallidi. S’era trasferito in Francia, come molti di loro, per sfuggire alla galera e lì s’era ricostruito un’esistenza. Ma Giulia non l’aveva lasciata mai, gli scorreva nel sangue. Non pensava a lei consapevolmente, ne percepiva la presenza come un brusio lontano, ma ineludibile.
Ho avuto paura che le responsabilità mi imprigionassero, che facessero di me un omuncolo, uno di quelli che si adeguano, che stanno al mondo per tirare la carretta e rinunciano ai sogni. E i sogni per noi erano tutto, per quelli ti ho sacrificata, ci ho sacrificati. Ma il mondo non ha spazio per i sogni. Poi le cose hanno preso una piega storta, ma io ce l’ho messa tutta, non mi sono mai tirato indietro, ho fatto ciò che andava fatto, errori compresi. Anzi, soprattutto errori. Lo sai come eravamo fatti, rigidi, bacchettoni, così pieni di convinzioni da non vedere che la realtà aveva ben altra tinta. Ci credevamo entrambi, poi tu hai fatto la tua scelta, hai deciso che non te la sentivi di rinunciare al bambino, che un figlio era una cosa troppo importante.
Invece per me allora un figlio era un ingombro, una distrazione da ciò che contava, una segregazione. Per quello sono sgusciato fuori casa quella mattina. Sapevo che tu non avresti implorato, che avresti capito, ma guardarti mi avrebbe indebolito, avrebbe ridotto le mie convinzioni in pappa.
Questo volevo che tu sapessi, che non è stata la carenza d’amore ad allontanarmi, ma ciò che allora credevo essere un amore più grande, un dovere morale, una chiamata alle armi cui non era dignitoso sottrarsi. Però mi sei mancata sempre, giorno dopo giorno, attimo dopo attimo. E se potessi ricominciare tutto da capo con la testa di oggi, quell’errore non lo rifarei, perché l’ho sempre sentito quel costante disagio, quel qualcosa di me che non coincideva con l’io che credevo di essere, quell’io che era rimasto con te. Forse non ero tagliato per la felicità.
La sua bocca emise le ultime parole come un sussurro, le palpebre serrate, come tormentate da pensieri cupi, le mani strette a pugno, un lieve tremore nelle gambe. Un’inquietudine nuova, lentamente, dentro di lui mutava di forma, fino a definirsi in un’insospettata malinconia. C’era molta parte della verità che non riusciva a filtrare nelle parole, un passato che non si lasciava mettere in scena, che si celava nel silenzio. E il dire restava nelle intenzioni.
E nostro figlio, anzi tuo figlio? ora il bambino sarà un uomo fatto, magari anche padre – buttò fuori in un soffio come una stilettata, lo sguardo ansioso rivolto alla finestra. Dimmi solo se mi odia. Anzi no, non dirmi nulla, non potrei sopportarlo. Certo che mi odia, come non odiare un padre che ti abbandona a una vita priva di muri che ti proteggano, senza trave portante. Ma oggi no, non facciamone parola.
Poi, senza aspettare risposta, la sua faccia si indurì, si alzò come se la sedia scottasse, come se il dolore fosse entrato a vele spiegate nella stanza lasciandolo stordito. Non aveva neppure sfiorato il caffè che lei gli aveva messo davanti. A passo lento si incamminò verso la porta, esitante nel suo smarrimento, affaticato come camminasse contro vento. Si calò il basco in testa, calzato storto alla Che Guevara, accennò un mezzo sorriso e si avviò verso le scale.
Marina lo osservò in silenzio, mentre la sera consumava il pomeriggio. Non era riuscita ad aprire bocca, eppure sentiva che dentro quella fortezza massiccia si dibatteva un’anima fragile. Una moltitudine di emozioni le scrosciava addosso come pioggia, senza che un sentire pulito si definisse. Restò come ammaliata dalla sagoma di quell’uomo, il corpo allungato e scabro, il volto come sazio della vita, che si allontanava nelle tinte fosche della sera, curvo eppure non privo di una certa baldanza, preda dei rimpianti, del tempo che non dà tregua ad anima viva.
Non se l’era immaginato così suo padre, con quella tristezza dolce a solcargli le guance, con quell’incertezza nel passo. Lui, un ragazzo gonfio di principi.
Il faggio
di Delfina Lusiardi
Un ottobre così triste non si era visto, a memoria d’uomo, come si dice.
Ogni giorno si annunciava con un cielo melmoso. Il sole, chi se lo ricordava soffriva di nostalgia e di inquieta infelicità. Chi non lo ricordava stava quasi meglio. Non bene, ma meglio di chi non aveva smarrito l’immagine del sole e, con l’immagine, il desiderio di uscire di casa e andare nei boschi che circondano la città. Lì l’autunno era una festa di colori. Ogni anno si poteva fare il pieno di rossi, gialli, terra di Siena bruciata, di arancioni e viola… I tramonti autunnali erano una riserva irrinunciabile per riuscire ad entrare nell’inverno con un cuore pacificato. Per accettare di chiudersi in casa, di rallentare i ritmi, di sospendere gli incontri. E nutrirsi di libri ammonticchiati sul ripiano della libreria in attesa di essere letti con la dovuta attenzione.
Il programma di T. era rimasto bloccato dalla tristezza che lo aveva invaso appena rientrato in città. Sospeso, rinviato. T. era cocciuto e si sa che non avrebbe rinunciato ai suoi propositi elencati con metodo e puntiglio. Puntiglioso era. Usava la sua intelligenza come un cacciavite che doveva svitare tutto ciò che gli sembrava arrugginito, nel suo modo di vivere. E nel modo di fare, suo e degli altri.
Ma le piogge incessanti lo avevano indotto a mettere da parte il suo programma, in attesa di qualche spiraglio di sole che lo chiamasse in strada e gli desse lo slancio necessario per andare alla ricerca delle persone che doveva incontrare: quelle a cui lui aveva fatto torti, quelle che gli avevano fatto torto, quelle infine da ringraziare per il po’ di bene ricevuto.
I primi giorni di chiusura forzata li aveva usati per sistemare i suoi libri, per procedere nel suo programma di svuotamento dei ripiani della libreria. Un programma rimasto a metà, come quasi tutti i suoi programmi di pulizia da tutto ciò che sentiva inutile. E così, se la pioggia lo costringeva a stare dentro, il dentro si era un po’ dilatato. Arrivava alla sera stanco ma felice, come si dice di quelli che fanno una bella camminata di lena e arrivano a casa con un bell’appetito. Stanchi ma contenti… E il cibo non ha il sapore della compensazione, della fuga dalla noia, ma il sapore del giusto appagamento per aver fatto il proprio dovere. Per aver soddisfatto il corpo e lo spirito. Uno spirito che si accontenta di una bella camminata, anche quello di T. apparteneva a questo mondo spirituale degli umani che al cielo si rivolgono con la preghiera che faccia quello che va bene per loro.
Ma il cielo non fa i conti con i desideri umani, con le nostre limitate capacità di sopportazione degli imprevisti. Il cielo fa quello che non può fare a meno di fare… lo sanno tutti gli esseri che vivono esposti alle intemperie: gli alberi, i fiori, perfino l’erba dei prati che sembra non soffrire di niente. L’erba che sa riprendersi dalla siccità con una pioggerella o crescere a dismisura, potremmo dire, sotto piogge torrenziali.
Un filo d’erba, possiamo imparare da un filo d’erba, scrive Van Gogh. Imparare a disegnare prendendo come modello un filo d’erba. Ma da un filo d’erba possiamo imparare anche molto altro. Così radicato e vicino alla terra, così esile e forte da non temere i temporali e i venti. Anche i più violenti non possono sradicarlo, un filo d’erba ci insegna a vivere.
Ma T. non avrebbe mai preso lezione da un filo d’erba. Troppo uguale agli altri fili d’erba dello stesso prato. Un prato sì, gli piaceva, e gli piaceva anche che fosse composto da fili d’erba tutti uguali, così da formare un bel tappeto erboso, avrebbe detto il giardiniere. Una volta aveva chiesto consiglio al giardiniere per creare un bel tappeto erboso nella casa di campagna, senza tuttavia riuscirci, perché avrebbe dovuto rinunciare alla sua amata betulla. Al massimo lì sotto sarebbe cresciuto un po’ di muschio, misto a qualche filo d’erba, a qualche dente di leone, a qualche filo di pervinca che, all’ombra, al massimo si allunga e getta le sue perfette foglioline ovali senza poter offrire i suoi fiori blu… In abbondanza nel muschio crescevano germogli di vite canadese e di ligustro nati da semi portati dal vento e altre erbette di difficile identificazione… e foglie che promettevano fiori, primule e violette che non andavano tagliate con il tosaerba. Istruito dalla moglie campagnola, T. aveva imparato a rispettarle.
Il cielo restava inclemente e dopo alcuni giorni di bonifica, come lui chiamava questi lavori di sgombero, l’opera di T. si era fermata ai ripiani della libreria e alla riorganizzazione della biblioteca nella grande stanza comune. In casa ci sarebbero stati molti altri angoli da bonificare: sgabuzzini e armadi ingombri di abiti che nessuno più avrebbe indossato. Ma T. ormai aveva esaurito il suo slancio e quelle liste di gesti da compiere, atti di riparazione, tentativi di chiarificazione, azioni che dovevano liberarlo dalla colpa, pesavano come una spada di Damocle sul suo tempo. Sentiva che se non fosse riuscito a realizzare quel programma, il tempo si sarebbe fermato proprio nel punto in cui la spada sta sospesa e basta un niente per farla cadere sul suo capo.
Le piogge continuavano incessanti. T. si sentiva paralizzato, incapace di spostarsi, di fare un passo oltre il punto su cui pendeva quella spada. La teneva d’occhio, certo. Era la sola cosa che riusciva a fare. Per tenerla d’occhio trascurava tutto, libri da leggere, musiche, film da vedere, perfino le cose che gli avrebbero dato un po’ di consolazione non lo attiravano più. Da tempo aveva smesso di preparare qualcosa per la cena, compito che si era preso volentieri. La moglie era preoccupata e continuava a sperare che il cielo guardasse giù e mandasse almeno per un giorno quel po’ di sole che avrebbe chiamato T. di nuovo in strada. Fino a quando avrebbe retto la sua pazienza nemmeno lei poteva saperlo, la pazienza va e viene. È eroica la pazienza e, quando si mette di mezzo la paura che il tormento duri all’infinito, sfodera armi che non sappiamo maneggiare bene. Pericolose, colpiscono a destra e a manca.
E venne il giorno in cui il cielo guardò giù e mandò un vento così violento che tutte le nuvole di colpo se ne andarono ad ammassarsi verso nord lasciando che il sole brillasse dalla mattina al tramonto.
Fu in quel giorno che tutte le persone si rimisero in strada e si salutavano come uscite fuori da una malattia che le aveva tenute prigioniere. Anche T. uscì e prese la strada verso nord dove il cielo era rimasto di un grigio plumbeo. Era sicuro che là avrebbe trovato tutta la forza per riprendere il suo programma perché con un sole così splendente non avrebbe potuto andare alla ricerca di coloro che gli avevano fatto torto, di coloro ai quali aveva fatto torto lui, di coloro con i quali sentiva un debito di gratitudine. Con un sole così e le anime libere dal peso che le aveva imprigionate per giorni e giorni, il suo proposito sembrava ridicolo, quanto meno fuori luogo. Ma cosa vuole T., avrebbero detto i suoi interlocutori. Il passato è passato e adesso goditi il cielo che c’è.
Ecco perché T. doveva andare verso nord, là dove le nuvole si erano ammassate e avrebbero ancora potuto riprendersi tutto lo spazio del cielo.
Verso mezzogiorno anche la moglie di T. decise di uscire. Sola. Attratta dal grigio plumbeo del cielo non illuminato dal sole, si diresse anche lei verso il colore che amava, non il grigio melmoso delle giornate di pioggia, ma il grigio blu, il blu profondo che precede un temporale, o che resta ancora per un po’ a temporale finito, solcato dall’arcobaleno. In quel grigio plumbeo non c’era traccia di arcobaleno, ma il suo sguardo venne catturato dal faggio che in quell’aiuola di città aveva cominciato a rosseggiare. Bene, si disse, quando la pazienza comincerà a venir meno, ci sarà sempre un albero da contemplare e, perché no, da disegnare.
Il folle piano di T.
di Marco Palamenghi
Alla fine ho deciso. Inizierò da quelli che abitano più lontano, in altre città, per avvicinarmi pian piano a casa.
Lo farò senza fretta, con calma, valutando di volta in volta l’approccio giusto. Non tutte le persone sono uguali, e i torti fatti e subiti sono differenti tra loro.
Non posso svilirli trattandoli tutti allo stesso modo. Voglio agire con dignità.
Il caso ha fatto si che le due liste siano composte esattamente da 23 nomi ciascuna.
Il primo di ogni lista abita a M., dove ho frequentato l’università e vissuto per qualche tempo.
L’ultimo di ciascuna lista è qui, in casa mia: sono mia moglie e mio figlio, e sono presenti in entrambe le liste, appaiati, come una persona sola. Ad entrambi devo chiedere scusa, perché non sempre sono stato un marito e un padre all’altezza, ma allo stesso tempo entrambi mi devono chiedere scusa, per non aver sempre apprezzato quanto ho fatto per loro e per non essere stati una moglie e un figlio adeguati.
Avevo pensato di contattare via via le persone per email, posta o telefono. Oppure su facebook, come spesso succede di questi tempi. E poi, organizzare con ciascuno l’occasione di incontro.
Ma invece, credo che userò l’effetto sorpresa, per studiare le loro reazioni, capire cosa pensano veramente, senza che l’ipocrisia dell’incontro annunciato crei una barriera alla loro benevolenza o al loro pentimento.
Solo così saprò se hanno compreso questo mio bisogno di fare i conti con il mio passato, con la mia vita, nel bene ricevuto e nel male fatto. Solo così anche loro potranno raggiungere la consapevolezza per avviare un analogo percorso.
Inizio quindi con la lista dei torti fatti, mi sembra giusto partire dalla mia richiesta di perdono, troverei arrogante partire subito con una richiesta di scuse.
Mi iscrivo a tutti i social media che conosco e, con un po’ di pratica, imparo a scandagliare il web in cerca di informazioni, immagini, indirizzi di S., la prima persona con cui voglio parlare.
Non prestargli gli appunti del corso di E. era stata una vera carognata. Chissà cosa penserà ora di me, chissà come reagirà nel vedermi, soprattutto quando saprà perché l’ho cercato.
Dal suo profilo facebook ho ottenuto informazioni su dove vive, i locali che frequenta, cosa pensa politicamente, che tipo di persona è diventata, o perlomeno, fa credere di essere.
Gli piacciono i film di Massimo Boldi e le canzoni dei Pooh. Insomma… un po’ una delusione… magari è in parte anche questo colpa mia….
Usando un po’ di ferie e inventando scuse a casa vado a M. un paio di volte.
Lo intercetto, lo seguo, lo spio.
E poi, prendo il coraggio a quattro mani e mi siedo al tavolino dove sta prendendo un Negroni da solo, mentre aspetta qualcuno che non sono certo io.
“Ciao S.! Ti ricordi di me?”
“Mmmmh… ma certo, sei T., facevamo ingegneria assieme! Che sorpresa, cosa ci fai a M.”
“Sai com’è. Gli anni passano e avevo voglia di tornare dove ho trascorso un bel periodo della mia vita…
“E in una città così grande, guarda che caso, mi incroci.”
“Beh, non è proprio per caso, ti stavo cercando”
“Ah. E perché?”
“Volevo chiederti scusa”
“E di che cosa?”
“Per quella volta che non ti ho passato gli appunti per l’esame di A.”
Leggo nei suoi occhi stupore, confusione e poi, dal profondo gli sgorga una inarrestabile, sonora, risata. Ha le lacrime agli occhi dal ridere, non riesce a smettere e nemmeno a parlare.
Mi sento profondamente offeso. Sono li, che mi umilio, chiedo scusa e lui ride, manco fossi una macchietta di “Natale a Miami”.
Mi alzo, giro sui tacchi e me ne vado senza salutare.
Che delusione, sento una rabbia irrazionale crescere dentro di me. Il torto fatto è cancellato, resta solo il rancore per una persona che ha dimostrato la sensibilità di un cammello.
A quel punto, visto che chi ha subito un torto mi irride, meglio provare con la lista dei torti subiti. Quella almeno mi da il diritto di chiedere che si scusino.
Ho individuato C., abita anche lei a M… Anche con lei frequentavo ingegneria. Non eravamo amici, ma solo conoscenti, con qualche corso frequentato assieme.
Ad un appello di esame le avevo chiesto di cedermi il suo posto nella lista, per essere sicuro di non perdere il treno per tornare a casa. Non aveva voluto, e così avevo dovuto rimandare di un giorno il rientro a casa e dalla mia ragazza.
La intercetto, la seguo, la spio.
Decido per l’approccio diretto sul posto di lavoro. Fa la sportellista in banca. Mi metto in coda, aspetto il mio turno.
“Ciao C.! Ti ricordi di me?”
“No. Chi è lei?”
“Sono T., facevamo ingegneria assieme!”
“Oh! un sacco di anni fa! Non l’ho nemmeno finita… era una tale palla…. Che operazione deve fare? Prelievo o versamento?”
“Veramente non devo fare nessuna operazione. Volevo solo che tu ti scusassi con me per quella volta che all’appello di esame ti avevo chiesto di cedermi il tuo posto nella lista, per essere sicuro di non perdere il treno per tornare a casa. Non avevi voluto, e così ho dovuto rimandare di un giorno il rientro a casa e dalla mia ragazza”
“Ma sei scemo! (è passata dal lei al tu, forse è un passo avanti) Vieni qui a rompermi i coglioni (no, non è un passo avanti) mentre lavoro, per una cazzata simile! Ma fatti ricoverare! Fatti vedere da uno bravo, ma bravo davvero!”
“Ma come! Invece di chiedermi scusa mi offendi, mi dai del pazzo!”
“Dimmi che operazione vuoi fare, altrimenti chiamo la sicurezza e ti faccio buttare fuori!!!”
Me
ne vado furibondo! Armato di buone intenzioni mi sono messo in questa nobile
impresa, come un paladino di re Artù alla ricerca del Graal, e ottengo solo
derisione e insulti. Ma chi si credono di essere? Possibile che non sappiano
riconoscere la nobiltà delle mie intenzioni!
Sono passati 23 anni, ne ho contattati 2 all’anno, era necessario fare le cose con calma.
Ho impiegato così tanto tempo perché è stato più complicato di quanto avessi preventivato e trovare la soluzione giusta ogni volta è stato difficile. Ad ognuno ho voluto dare una chance, ma nessuno l’ha colta.
E oggi sono alla fine della lista. Tocca a mia moglie e a mio figlio.
No, non parlerò con loro, perché loro una chance l’hanno avuta tutti i giorni da sempre. E non l’hanno mai colta. Come tutti gli altri si metterebbero a ridere, dandomi del pazzo o dello scemo. Cosa che, d’altra parte, non perdono occasione per farmelo capire.
Negherebbero l’importanza dei torti fatti e, a differenza degli altri, sopravvaluterebbero i torti subiti, ritenendo insufficienti le mie scuse. Mi umilierebbero e offenderebbero come e più degli altri.
Farò
con loro come ho fatto, in questi lunghi 23 anni, con tutti gli altri.
Alcune gocce di veleno nel minestrone e anche loro smetteranno di ridere di me, dei miei buoni propositi, della mia voglia di fare i conti con il passato, del desiderio di capire e di essere capito.
Gli altri 44 li hanno preceduti. Hanno avuto una chance, ma non l’hanno colta.
C’è chi è morto in un incidente stradale, chi per una rapina finita male, chi cadendo dalle scale, chi andando a caccia, chi di una malattia fulminante….
Quella minestra la mangerò anche io. Ho compiuto la mia missione.
E, in fin dei conti, ho capito che mi sbagliavo.
Sono proprio io l’ultimo della lista, e anche il primo, e il secondo e….
Sono io che ho fatto i più grandi torti a me stesso, io che non mi sono mai perdonato per le occasioni sprecate.
Ora pace è fatta.
Ho veramente fatto i conti con me stesso e con il mio passato.
Vizi capitali
di Rossella Ghizzani
Questa è la storia di T., un uomo non più giovane e non ancora vecchio, e dei ventitré anni che visse – ma non sapeva di aver ancora da vivere – dopo aver deciso che doveva fare una cosa ben precisa: chiedere scusa a tutti coloro ai quali riteneva di aver fatto un torto.
Aveva in mente solo un paio di nomi, il giorno in cui gli venne questa idea: S., al quale si era rifiutato – una trentina d’anni prima – di prestare gli appunti del corso universitario che lui aveva seguito diligentemente, al contrario dell’amico che invece a lezione c’era andato secondo l’umore del giorno; D., al quale aveva portato via – non per una volontà precisa, ma era andata così – la donna con la quale stava da parecchi anni, come fossero sposati; F., una collega che a un certo punto, non più d’una decina d’anni prima, aveva sostituito nel ruolo che quella da tempo sperava di assicurarsi: non che le avesse fatto le scarpe, come si dice, ma è un fatto che di quello che lui sapeva i capi stavano decidendo si era ben guardato dal parlarle, e così la sua responsabilità e il suo stipendio erano migliorati. Il suo, non quelli di F.
Torti molto diversi fra loro, com’è evidente, di quelli che possono essere ridimensionati, liquidati addirittura, da un così è la vita. Così è la vita: nei rapporti di amicizia come nelle faccende sentimentali e nei posti di lavoro.
Ma T. aveva deciso che se sentiva una ragione per chiedere scusa non avrebbe dovuto star lì a pesare la gravità delle sue azioni, né a valutare le conseguenze che effettivamente ne erano derivate. Perché era convinto che altrimenti avrebbe potuto tranquillamente concludere di non aver poi fatto succedere il finimondo, di non aver rovinato l’esistenza a nessuno eccetera eccetera, e dunque non c’era motivo di scusarsi. Né del resto le conosceva davvero, quelle conseguenze:
S. s’era laureato anche lui, alla fine; D. non si era suicidato perché la sua donna l’aveva lasciato, non era passato un anno che era già con un’altra; F. ci lavorava ancora in quel posto, e la sua carriera l’aveva fatta comunque.
Ma non era questo il problema. La questione riguardava lui. Il suo bisogno di chiedere scusa. Indipendentemente dall’esito che il suo gesto avrebbe avuto, se avvertiva di aver fatto un torto, piccolo o grande che fosse, quale che fosse l’ambito di relazioni nel quale s’era compiuto, lui sentiva di dover tornare dalla vittima, se la vogliamo chiamare così: ricordarle quel periodo, quel fatto, se nel vederlo non le fossero tornati subito alla mente. E chiederle scusa. Non si trattava di ottenerne il perdono, o meglio: se qualcosa del genere fosse accaduto ne sarebbe stato contento, ma nel suo proponimento di riavvicinare la tale o il tal altro non doveva giocare alcuna valutazione preliminare delle probabilità che ciò avvenisse.
La lista si era andata allungando, e per ogni nome T. aveva cominciato a rintracciare recapiti, numeri telefonici, indirizzi e-mail. Anche se escludeva di risolvere la cosa a distanza. Quei dati dovevano servirgli solo per stabilire il primo contatto, buttar lì un pretesto per rivedersi, ipotizzare il giorno e l’ora in cui sarebbe andato. Perché, non ne sapeva esattamente la ragione, ma gli pareva essenziale che fosse lui a recarsi dall’altro, a casa sua, o comunque nel luogo in cui viveva. Alcuni infatti non stavano nella sua città. O non ci avevano mai abitato, o si erano trasferiti.
Era deciso. Avrebbe cominciato con uno a caso, facendo un sorteggio magari, poi via di seguito. Senza tener conto del tempo che era passato dal fatto. E qui un dubbio, o piuttosto un malessere, lo prendeva: aveva già annotato un paio di nomi di persone che avevano continuato a vivere nella sua stessa città, così come ne aveva appuntato almeno uno – ma sapeva che altri se ne sarebbero aggiunti – al quale il torto l’aveva arrecato di recente. Molto di recente. Decise di fare un elenco a parte per questi, così vicini, nello spazio e nel tempo, e di rimandare l’approccio con loro. Non di escluderlo, questo no, avrebbe guastato l’intero suo proposito, ma di non prevederlo nell’immediato.
Era tutto pronto dunque. Appena finita l’estate avrebbe cominciato. Dal primo.
Ancora qualche bagno, un po’ di sole, la festa dell’ospite di fine agosto e poi sarebbero tornati in città, e lui si sarebbe fatto sentire dal primo della lista.
Ed è stato proprio lì, attorno ai fuochi e alle grigliate di pesce sulla spiaggia, fra chitarre e fisarmoniche, che ha incontrato P. Erano sei, forse sette anni che non lo vedeva. Da quando aveva lasciato il lavoro che faceva per passare a quest’altro che pochi giorni dopo lo attendeva.
Erano diventati amici, lui e P., che pure era molto più giovane di lui. Proprio per questo forse: un’amicizia in cui c’era qualcosa del rapporto tra il fratello maggiore e quello più piccolo. Niente di paterno. T. aveva aiutato P., lo stimava, gli piaceva la sua passione per il lavoro ben fatto. Era stato questo ad accomunarli.
Ebbene, non appena i loro rapporti di lavoro erano cessati, P. non s’era più fatto sentire. T. l’aveva cercato, gli aveva proposto cene, occasioni per fare viaggetti, cose da fare insieme come una volta, ma P. niente. Non sono pochi quelli che, come cambi lavoro, tagliano di netto: la loro cordialità non era che interesse, è evidente. Ma da P. non se lo sarebbe proprio aspettato. Ne era rimasto ferito. Confuso prima, e poi ferito, appunto.
Avrebbe potuto fingere di non averlo visto, o limitarsi a un saluto da lontano. Invece gli era andato incontro, senza deciderlo, come fosse la cosa più naturale da fare, l’unica cosa possibile: l’aveva abbracciato, non badando al sorriso imbarazzato di quello, l’aveva fatto sedere al tavolo dove stavano sua moglie, i suoi figli, i suoi amici, aveva offerto a P. e alla ragazza che lo accompagnava grigliata e vino bianco. Il chiasso copriva le voci, non s’era neanche posto il problema di rievocare vecchi tempi, di scambiarsi le domande di prammatica, cosa fai adesso, come ti va eccetera. Solo qualche battuta su quelli che c’erano lì intorno, un commento su come andavano le cose, la politica, il lavoro, cose così.
A fine serata si erano salutati, una stretta di mano, un arrivederci senza alcun cenno al quando.
E qui, per T. era nata l’idea di un’altra lista da scrivere: la lista di quelli dai quali gli sembrava di averlo ricevuto, il torto, di quelli che l’avevano fatto restar male, o l’avevano fatto davvero soffrire.
Andare anche da questi: per sapere – senza la minima recriminazione, senza alcuna pretesa di ottenere spiegazioni e tanto meno scuse – la ragione per cui quella volta avevano detto, avevano fatto… O non avevano detto, non avevano fatto.
Tutto qui. Anche se non sapeva se sarebbe stato sempre bravo come con P. perché certe cose gli bruciavano ancora. Ma comunque voleva provare. Sentiva di non poter mettersi a pensare questo sì e questo no. Se uno di quelli che in qualche modo l’avevano offeso, o addolorato, gli veniva in mente, il suo nome doveva metterlo, in ogni caso.
A fine settembre le due liste erano abbastanza lunghe. La prima, quella dei torti fatti, soprattutto. Anche perché, rileggendola, si era reso conto di avervi incluso anche nomi di persone alle quali non aveva ragione di chiedere scusa, ma che sentiva ugualmente di dover raggiungere per dire un grazie. Non scusa ma grazie. Grazie perché in una particolare situazione gli erano state vicine, magari senza fare o dir nulla di speciale: gli si erano fatte sentir vicine, ecco. Oppure perché, anche senza averne precisa intenzione, gli avevano dato un’indicazione sul come fare una data cosa, o sulla direzione da prendere a un certo punto della sua vita, un incoraggiamento insomma, esplicito o meno che fosse stato. E a queste persone lui non aveva saputo manifestare la sua gratitudine: per sbadataggine, o pudore, o… avarizia. Quell’avarizia del cuore che non si sa o non si vuole riconoscere come tale e dalla quale ci si ritiene comunque esenti, come potesse riguardare sempre e solamente gli altri. Sicché quei grazie, in fondo, erano riparatori. Per questo si era ritrovato a includere i nomi dei destinatari nella stessa lista delle scuse.
Alla fine, seppure non complete, né l’una né l’altra, si è detto che le due liste andavano chiuse. Il rischio, se no, era di contentarsi di averle scritte e di aggiungervi un nome oggi e uno domani, senza mai mettere in pratica il proponimento da cui erano nate.
E dunque, T., appena tornato in città, cominciò.
Dopo quasi vent’anni, per un motivo o per l’altro, T. non aveva fatto molti passi avanti.
Alle scuse aveva rinunciato presto. Un numero non trascurabile di persone contattate si erano del tutto dimenticate di lui. Di lui, come se non l’avessero mai conosciuto. Questo implicava che T. dovesse inerpicarsi in verbose spiegazioni volte a ricostruire date, luoghi, fatti alla fine delle quali lui stesso smarriva il senso e l’interesse per ciò che si era proposto di fare. Non erano stati pochi i generici e cortesi – ma non si preoccupi, è passato tanto tempo, mi dispiace ma proprio non mi ricordo – dai quali aveva preso le distanze, bisogna ammetterlo, con un malcelato senso di frustrazione che finiva per irritarlo. Che faccio ora, borbottava fra sé e sé, questi qui li passo sulla lista di quelli che il torto me l’hanno fatto? Tutto ciò aveva avuto un forte impatto negativo sulla sua volontà e sulla fermezza della decisione presa. Qualche tentativo aveva continuato comunque a farlo, a volte anche senza rispettare la suddivisione delle liste: capitava infatti che il suo proposito di chiedere scusa si trasformasse in un grazie, perché la persona contattata, pur non riconoscendolo e quindi del tutto dimentica di qualsiasi relazione con T., lo accoglieva con benevolenza, qualche volta addirittura con calore. Senonchè qualche grazie, accolto magari con sufficienza, gli provocava spiacevoli reazioni per cui, alla fine, era costretto a chiedere scusa. In coscienza, né T. né altri avrebbero potuto affermare che non ci avesse provato. Era inevitabile però, T. lo sapeva, che – messo in pratica – il suo desiderio di chiedere scusa o di dire grazie si sbriciolasse in un gesto asettico. Non sono capace di empatia, c’è poco da fare, si diceva rammaricato: alla fine mi sono creato un’esigenza nata da un costrutto cerebrale del tutto privo di una vera partecipazione emotiva.
Aveva immaginato forse che quegli esperimenti di riparazione lo assolvessero e gli rendessero giustizia, ma non era andata così. Non si sentiva appagato, e dopo tanti anni continuava a cercare il bandolo di quello stentato esperimento.
C’è poco da fare, pensava, non è andata come avevo desiderato, e ormai, potrei sbagliarmi, ma credo di essere arrivato alla fine. Bisogna che lo trovi, il modo per far tornare i conti, prima che sia troppo tardi.
Qualche giorno fa ho ascoltato per radio un prete, uno di quelli impegnati in trincea, affermare che la vita deve essere sperperata.
Non va tenuta per sé, diceva quell’uomo di fede, va donata, sperimentata, azzardata.
Mi sono rimaste in testa quelle parole, e sovente si mischiano al monologo interiore che incessante, contenuto solo dai limiti imposti dalle mie necessità, mi accompagna e ricama il mio pensiero di punti nuovi. Se non lo faccio adesso, non avrò un’altra occasione. Sento un bisogno spudorato di dilapidare quel che resta di me, per libera scelta e senza tirare in ballo altri. Non è stata una buona idea provare a rappacificarmi con me stesso facendo le somme come se la vita fosse un pallottoliere. Totale dei grazie da proferire, somma parziale delle scuse da porgere… Non funziona così, penso ora. E come mai ho tenuto una contabilità così esatta soltanto dei momenti in cui, nell’incontro con gli altri, si è generata una frizione, uno strappo, o comunque qualcosa è andato storto?
La verità è che da tutta la vita porto nel cuore una forma d’avarizia che sempre mi ha nuociuto.
Penso questo ora. Sono solo, un po’ per scelta e un po’ per caso, e me la cavo, certo. Riesco a procurarmi tutto quello che mi serve, perfino un po’ di compagnia, se proprio ne ho voglia.
E ho il tempo. Per scavare, per tentare di capire, per reinterpretare; tutto il tempo di cui ho patito il desiderio durante gli anni lunghi del lavoro, delle distrazioni, del bisogno di riposo, delle curiosità, degli eccessi, dei torti subiti e di quelli inflitti. Gli anni in cui si attendono le cose che devono ancora accadere, in cui si lotta, nello strenuo tentativo di piegare il corso degli eventi alle proprie aspettative.
Si stringono i denti e si alza la voce, con un gran dispendio di energie. Dalla mia prospettiva, quella in cui i giochi sono davvero fatti – nessuna boccia sul panno verde del tavolo – tutto è diverso, e ogni giorno rinnovo l’incessante lavorio della mente nello sforzo di comprendere se fosse reale quello che è accaduto prima, o se vero sia quello che penso adesso. Quest’abbondanza di tempo, poi, a ben vedere è un falso: ho intere giornate per me, ma non credo di avere un futuro. Quello che davvero ho è la libertà. Al punto della vita in cui mi trovo posso dichiararmi senza preclusioni, ecco il motivo per cui ho cominciato a scrivere questo piccolo memoriale: desidero vuotare il sacco. Chiunque potrà leggerlo, chi mi ricorda e chi no, non ha importanza.
Importante è non dover sparire senza capire: mi piace immaginarmi mentre spendo l’ultimo dei respiri a mia disposizione, appagato dalla sicurezza di aver conciliato il prima e il dopo, avendo conquistato la sintesi ultima, valida solo per me e per questo assoluta, fra ciò che è stato e ciò che avrebbe potuto essere, se solo non fossi stato così parco di me.
Ogni tanto mi fermo davanti allo specchio. Riconosco lo sguardo e la ruga in mezzo alla fronte.
Mi fa compagnia da quando avevo poco meno di quarant’anni.
Adesso la mia ruga preferita è nascosta in mezzo a quelle che il tempo le ha ricamato intorno, formando una mappa sottile che disegna il contorno degli occhi, rivela le guance scavate e incornicia la bocca, più piccola che prima e un po’ sopraffatta dal mento, da qualche anno più appuntito e prominente.
L’ho sempre fatto, mi sono sempre scrutato davanti allo specchio, cercando me, non la mia immagine riflessa.
Lo facevo fin da piccolo, fissandomi gli occhi nella testiera nera e lucida del letto dei miei genitori. Mi mettevo a pancia in giù, le braccia conserte sotto la faccia e mi fissavo, finché quegli occhi scuri che mi guardavano non cominciavano a farmi paura.
È sempre stato così, sono sempre partito da me, mi sono usato per conoscere gli altri e la realtà che mi circonda. Come tutti, è l’ovvia obiezione. Ma per quanto mi riguarda, l’affermazione va presa alla lettera. La condanna della mia esistenza, quella che adesso mi fa trascorrere lunghe ore a riflettere, è non aver mai saputo davvero quanto sentimento contenessi, quanto ne avessi a disposizione o ne potessi spendere, a chi donarlo, come. Ogni volta è stato il rigore della logica a farmi scegliere. Con il termine sentimento, forse improprio, intendo quella componente delle relazioni fra persone, che pur non giustificandosi con una motivazione razionale – il lavoro, lo sport, un interesse comune, il sesso – rappresenta, nel bene e nel male, lo stimolo a cercarsi, l’emozione nel vedersi o, più semplicemente, rallegra rapporti di per sé strutturati per ragioni pratiche o infuoca casuali scambi d’occasione.
Simpatia, antipatia, empatia, ira, nostalgia e perché no, il tiepido, pannoso amor materno. È questo che sempre mi ha fatto difetto: sapere dove fossero dentro di me queste parole, riuscire a riconoscerle e sentirle, come guizzi dentro il petto. Mai ho saputo quante ne avessi e come dosarle.
Non ho saputo distinguere neanche il nero della voragine del dolore, salvo poi ammettere a distanza, da solo, la sua vera entità, senza spartire con nessuno alcuna emozione.
Provengo da una famiglia in cui mai sono stati nominati i sentimenti o detti gli stati d’animo, e da quando ho cominciato a gestire da solo le mie relazioni, ho sempre pensato che le parole proferite non potessero riuscire a descrivere una condizione interiore, bella o brutta che fosse, senza svilirla, senza restituire agli altri niente più di un superficiale compendio che avrebbe reso un’immagine distorta di me e violato con volgarità la profondità del mio sentire. O non sentire. Questo ha ristretto la cerchia dei miei interlocutori al numero minimo di uno, anche se, negli anni della maturità, ho ammesso intorno a me legami che comunque non ho avvertito mai come tali. Ho sempre dovuto compiere grossi sforzi di adattamento, adeguare il mio stile di comunicazione e la qualità stessa delle parole scelte, a un modo distante dal mio per nulla sintonico con il tentativo di essere me. Credo che per questo sia finito il mio secondo matrimonio, per l’incapacità di nominare il sentimento che ci univa. Potevo riconoscerlo dentro di me, ma mai ne ho fatto parola con la mia compagna.
Lei, del resto, deve essere stata a lungo impegnata a cercare di sanare le ferite che negli anni le avevo inferto, e a un certo punto deve aver perso interesse per me.
Sì, da un certo punto in poi deve avermi visto nella mia estraneità di uomo: un signore di mezz’età, piacente, giovanile, simpatico… un Tal dei Tali indisponente e sbruffone che aveva disatteso ogni accordo e tradito la complice alleanza che per anni ci aveva resi forti, imbattibili, a tratti immortali. Ma questo posso dirlo solo ora. Ogni giorno rinnovo i miei riti con scrupolosa attenzione. Mi alzo sempre alla stessa ora, né troppo presto né troppo tardi, indosso una vecchia giacca da camera color beige profilata di marrone che qualcuno deve avermi regalato molto tempo fa, e lentamente scendo in soggiorno. Apro le imposte, accendo la radio, preparo il caffè, faccio mangiare Seba, il mio cane, e fumo la prima sigaretta della giornata guardando fuori. Poi piano piano risalgo, lentamente mi lavo, mi vesto e poi riordino. Ho bisogno che tutto sia al suo posto, prima di potermi dedicare alle altre mie attività. Questa mattina, mentre rassettavo la camera, mi ha colpito al cuore il ricordo del gesto che faceva Clara, la mia seconda moglie, quando sistemava i cuscini sul letto rifatto. Non è stato un pensiero, ma una crepa. L’ho sentita aprirsi dentro di me; mi ha inondato una tenerezza infinita per quello scampolo di quotidiano e per un periodo della vita in cui, ma lo so solo adesso, ero un tutt’uno con me stesso. Li metteva vicini Clara, i cuscini. Attaccati, come se ogni mattina volesse ribadire la promessa di una notte da trascorrere insieme e il piacere di un’intimità familiare che avrebbe protetto il nostro sonno, il calore dei corpi, la soddisfazione del riposo.
Da qualche anno, lo ammetto, mi sono rimasti solo i gesti. Non nutro più alcun interesse per gli oggetti della casa. Ho bisogno che siano in ordine, ma non mi avvolgono più, non rappresentano più la fortezza in cui potermi rifugiare e trovare riposo. È tanto tempo che non godo più delle cose.
Adesso mi viene in mente quando Clara metteva sul letto le lenzuola pulite.
La sera mi distendevo nudo, fresco di doccia, sulla stoffa profumata, morbida e liscia. Mi voltavo sul fianco sinistro e la cercavo, per abbracciarla, per condividere quel momento di puro godimento domestico.
Eppure adesso so che a causa dei miei timori, delle reticenze, della poca abitudine a compromettermi davvero in una relazione amorosa, tutti i nostri anni insieme, fino alla fine, sono stati segnati da solchi sempre più profondi di non detto che sono diventati grumi, poi macigni, alla fine pietre sepolcrali.
Dopo aver riordinato, decido il da farsi. Se il tempo è bello, se non c’è vento, non fa troppo freddo, non minaccia pioggia, esco. Nonostante sia vecchio da un po’ e abbia ormai una certa dimestichezza con questa stagione della vita, ancor oggi mi fa penare rendermi conto di come le distanze, per me, siano dilatate e sempre più difficili da colmare.
Ho studiato con precisione i percorsi che mi sono accessibili, e fatto in modo di poter contare sulla possibilità di fare tappa. Ho censito panchine, muretti, recinzioni, che possano sorreggermi quando i dolori alle ginocchia si fanno insopportabili.
Non sto mai fuori a lungo, al massimo un’ora. Pane, giornale, sigarette. Tutto il resto mi si recapita a domicilio e per fortuna posso procurarmi senza difficoltà libri o giornali di mio interesse.
La cattiva notizia è che ogni giorno è più faticoso convincermi a uscire e solo raramente riesco a ritrovare il piacere di stare all’aperto: a volte sembra che l’aria voglia sopraffarmi con i suoi refoli leggeri, interferendo con il ritmo affannoso dei respiri. Spesso rimango a casa. Se c’è il sole, trascorro più tempo vicino alle finestre oppure, se il cielo azzurro, bugiardo, mi tenta con promesse di tepore primaverile, azzardo qualche passo sui ciottoli sconnessi del giardino di casa mia, il posto di cui si accontenta Seba quando non ce la faccio ad andar fuori e nessuno ci viene a trovare per fare due passi.
Quando c’era Clara, lo tenevamo in ordine il giardino. Lei ci teneva, e durante l’estate insisteva perché mangiassimo all’esterno. Così si sta un po’ insieme come quando ceniamo al ristorante, diceva. Mangiare in giardino ci permetteva di indugiare più a lungo a tavola, parlando, scambiandoci verità, bugie, propositi mai attuati, desideri … Era brava Clara, riusciva a creare un’aura speciale che era diventata il tratto peculiare del nostro stare insieme.
La aiutava il cibo, sapeva cucinare molto bene, e quella sua ostinata volontà di tessere la trama dei giorni, facendo in modo di ritrovare sempre qualcosa, un particolare anche minimo, un commento, un complimento, un gesto che, anche solo per un attimo, facesse scoccare una scintilla nei nostri occhi. Ogni volta che ci riusciva, traghettava entrambi fuori dallo stagno in cui eravamo caduti negli ultimi anni, e dava a tutti e due un buon motivo per continuare. Una cosa che non le ho mai chiesto, me ne accorgo solo ora, è quanto sforzo le costasse quell’operazione di traino.
Ci sono altre domande che non le ho mai rivolto, perché se lo avessi fatto, mi sarei costretto ad affrontare l’asprezza delle rocce delle sue richieste e la scivolosità dei ghiacciai del mio silenzio. Non le ho mai domandato, per esempio, se avesse mai perdonato il mio rifiuto. Non le ho concesso di donare la vita, e neanche di poter essere madre di un bambino non nostro. In realtà non ho mai proferito queste parole, non in questi termini almeno. Se devo essere sincero, è più facile che abbia affermato il contrario, manifestando il desiderio di essere padre. I no, i divieti e i rifiuti, io li agivo, innalzandole di fronte le barriere invalicabili e acuminate della mia incapacità.
Non mi sembra che siano peccati da poter perdonare.
Eppure lei ha sempre scelto me, fino a quando deve avermi visto come un cuore in inverno un po’ patetico, arroccato su se stesso e inabile alla profondità di un vincolo d’affetto.
Credo che sia successo quando scoprì che la tradivo. All’inizio negai, poi dovetti sottomettermi all’inconfutabile verità. Incerto sulla decisione da prendere, mi piegai alla sua forza, e per non spezzarmi dovetti trovare parole e gettarle, a casaccio, contro il suo incalzare senza tregua. Pretendeva chiarezza, accordi cristallini, scelte dichiarate e indiscutibili. Non la abbracciai mai, né le spiegai qualcosa o le rivelai il mio sentire. Come sempre, la costrinsi al compendio dei fatti. Rimasi, e questo fu quanto. Non che non mi pesasse la scelta. Ma rimasi, in onore alla vita che fin lì ci aveva attraversato insieme.
Deve averne sofferto, poi essersene fatta una ragione, e alla fine aver deciso di cercare la sua strada, ammettendo che potesse portarla lontano da me.
Da parte mia ho coltivato una ricca vita interiore, articolata, sonora, a tratti roboante, che sempre più, negli anni, mi ha impedito un sereno confronto con il mondo circostante e mi ha reso sterile.
Questi ultimi anni di assoluta solitudine, a ben guardare, ricalcano il mio stile.
Tutto avviene nella mia testa. Lo sforzo di capire, la soddisfazione, la frustrazione, il dolore, la gioia del ricordo. Se mi guardo indietro, quello che trovo è la somma delle mie assenze. Una presenza sempre esercitata per difetto. Sono sempre arrivato in ritardo, e sempre per conto mio, all’essenza delle cose, come una pellicola su cui i fotogrammi appaiono asincroni rispetto al sonoro. Ho sempre compreso dopo, e ogni volta attraverso la sofferenza, senza inibizioni o riservatezze, distillando gocce cristalline di autentico dolore.
Ho avuto un fratello, nipoti, amici due, autentici. Un padre scomparso prematuramente, una madre devota, tenace e combattiva. Una prima moglie acerba, amata come una sorella, che mi offrì un amore privo di giudizio come mai più avrei ricevuto. Insegnanti, colleghi, superiori, vicini di casa. Conoscenze. Una seconda moglie. Amanti. Un corollario di parenti. Persone di cui adesso ho bisogno, per la mia salute, per la spesa, per il futuro che non ho.
E con ognuno, nessuno escluso, ho commesso l’errore fatale dell’esercizio della distanza.
Mi sono sempre favorito, ho sempre sostenuto l’esigenza della soddisfazione delle mie necessità, in nome di una tutela ego centrata funzionale a rendermi autosufficiente, capace di assolvere ogni tipo di mandato, risolvere qualunque problema, sostenere ogni ordine di spesa, arrogante e a tratti impaurito, convinto di non poter contare su altri che me stesso. E poi la ricerca, l’abitudine a scavare, un minatore armato di piccone e lanterna che per sempre agognerà la totale comprensione, miraggio dorato e ingannevole, lussuoso pretesto per ritiri solitari, spesso consumati a discapito di malcapitati congiunti.
Da qui, dallo spiraglio di luce che mi rimane prima che le imposte siano definitivamente chiuse, vedo tutto quello che lascio dietro di me.
Immagini, proiezione privata ed esclusiva d’istanti di una vita trattenuta.
Sono state molte le occasioni in cui di me si diceva che non c’ero. Feste familiari, ma anche lutti, e pranzi quotidiani, calde sere d’inverno o domeniche estive. A volte di me si diceva che non c’ero anche quando ero presente. Poco importa se la mente mi riporta l’ipotesi della colpa condivisa, pensiero insinuante, fastidioso, pretestuosa chiave di lettura di anni e momenti remoti.
Voglio essere solo al giudizio. È adesso che guardo, e quello che vedo è un giovane uomo accartocciato su se stesso, impegnato a fondo in una ricerca astratta: il sé, unico, la cui affermazione pareva impraticabile.
Dal punto di osservazione in cui mi trovo adesso, uno dei peggiori stati d’animo è il rimpianto. Di questo si tratta. Faccio i conti con domande alle quali non so dare risposta. Perché non sono stato in grado di contenere le mie contraddizioni, perché non mi sono mai fidato, perché non ho mai spartito davvero la mia vita?
Unica soluzione, sempre, la fuga.
Eppure in cuor mio, di tanto in tanto, avverto un’ondata fremente d’amore.
L’ho detto. Mi colpisce a tradimento quando mi vengono in mente ricordi di Clara, ed è vera tenerezza quella che provo per i volti dei miei nipoti, le rare volte in cui li incontro, per quei corpi di giovani uomini forti eppure così evidentemente all’incognita della fragilità.
Dal mio punto di osservazione sono in grado di vedere tutta la strada che hanno davanti, la vedo tutta, ora che la loro vita s’incammina e la mia volge al termine.
In segreto, coltivo affetto per le persone che hanno percorso con me un tratto di strada. Ne sono geloso, non lo disperdo, ma quella fonte di ricchezza s’inaridisce. Non si coltiva da soli l’amore per gli altri.
Del resto, lo ammetto, la distanza era la mia corazza contro la possibilità di sbagliare. Se le avvicini, le persone imparano ad attendersi qualcosa da te, ti aspettano, diventano fedeli, e più aumenta la somma di questi atteggiamenti, più il margine possibile di errore s’innalza.
Ho sempre sbagliato, e ogni volta che accadeva, la massa di dolore si faceva sempre più spazio dentro di me.
Con Clara era diverso. Lei sembrava comprendere anche quando il mio comportamento era onestamente indifendibile.
Clara. Ha saputo danzare al ritmo dei miei passi, fino a quando, ballando, le ho pestato i piedi. Quando ho smesso di fare anche quello, quando non l’ho neanche ferita più, l’ho perduta.
Sono stato avaro, pur consapevole che il bene prezioso gelosamente custodito era destinato a scomparire.
Come in una fiaba, la condizione affinché tutti potessero vivere felici e contenti era che dilapidassi i miei gioielli, proprio come diceva la voce del prete che ho ascoltato alla radio. Altrimenti era inevitabile che fossi condannato al gelo della solitudine, e che per sempre si agitassero dentro di me i nomi e i volti di tutte le persone che, come senza volerlo, ho amato.
Sì, senza volerlo, come se questo non facesse la differenza.
Senza impegnarmi, compromettermi, sporcarmi, senza farlo sapere.
Come se l’amore fosse un tutt’uno con la distanza e il rifiuto, come se il mio posto fosse sempre un po’ all’esterno. Un po’ discosto dalla tavola imbandita, un po’ laterale nelle fotografie di gruppo, un po’ troppo avanti, da solo, nelle camminate in montagna. Gli altri, all’opposto, vedevano un egocentrico pieno di sé, convinto di avere sempre ragione e di essere sempre al centro dell’attenzione.
Mentre scrivo, deciso a lasciare almeno questa traccia di me, Seba, il mio cane, mi è seduto vicino.
Ogni tanto lascio andare una carezza sul pelo folto che gli ricopre il dorso, e ogni volta lui alza lo sguardo verso i miei occhi e mi ricambia. Struscia il muso sulla mia gamba, muove piano la coda in segno di riconoscenza. È un bravo cane, il mio Seba. Ha adeguato il suo passo al mio, e sacrifica la potenza delle sue zampe al mio incedere stentato, senza allontanarsi mai.
Ci unisce una reciproca dipendenza priva di perché. Seba non si aspetta nulla da me, è felice se anch’io lo sono, e nei giorni di tormenta aspetta che mi passi, attende con pazienza il gesto che gli indichi il segnale di tregua. Da parte mia, la sua presenza mi sollecita un sentimento genuino.
Non mi giudica mai, il mio cane, non vorrebbe che fossi diverso, gli è sufficiente che io ci sia. Il mio amore silente forza le catene e si manifesta, riscaldandomi il cuore e le ossa e muovendo le dita, che di tanto in tanto arruffano il pelo del suo dorso.
La mia ultima possibilità, un regalo della vita affinché potessi finalmente viverlo, l’amore che sento e che sempre ho tenuto imprigionato fra le sbarre delle mie paure, nascosto nella cella del timore di non essere all’altezza, sepolto fra i rovi del calcolo distaccato.
Può essere lui, il mio Seba, a indicarmi la via che mi aiuti a ricomporre i miei pezzi sparpagliati?
Più di ogni altra cosa mi addolora pensare che me ne andrò lasciando dietro di me una scia di delusione. Quanti, che profondamente ho amato, quando sapranno della mia scomparsa riconosceranno la perdita di qualcuno che li ha amati?
Il dolore di questo pensiero non si può lenire con generiche scuse, o distribuendo tardivi ringraziamenti.
Di più ancora mi fa male sapere che la mia vita è servita solo a me.
Per questo intendo adesso lasciare queste poche righe, perché gli altri sappiano tutto ciò che in una vita non ho detto, e per mostrare ai pochi che leggeranno l’errore che ho commesso, perché non diventi anche il loro, perché ne facciano tesoro e lascino correre la voce: va sperperata la vita, non tenuta per sé.
T, stremato, posa la penna, scosta il corpo dal tavolo e si abbandona sulla spalliera della sedia. Un gesto da niente, che pure Seba registra muovendo appena la punta della coda. Prima di cedere al sonno, T. gli rivolge uno sguardo pieno d’amore.