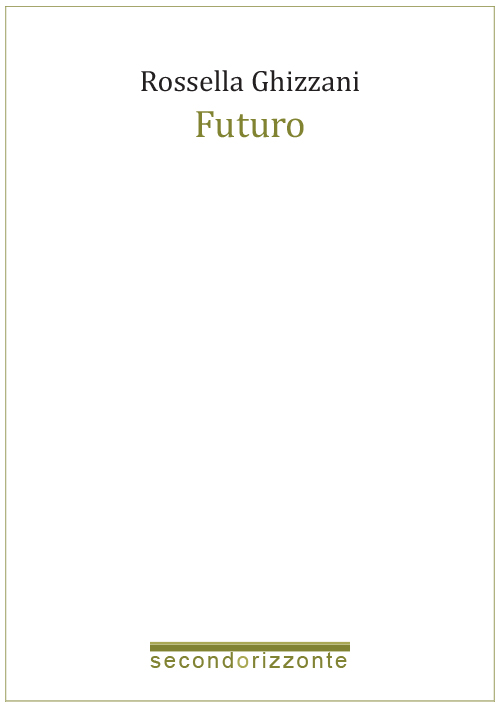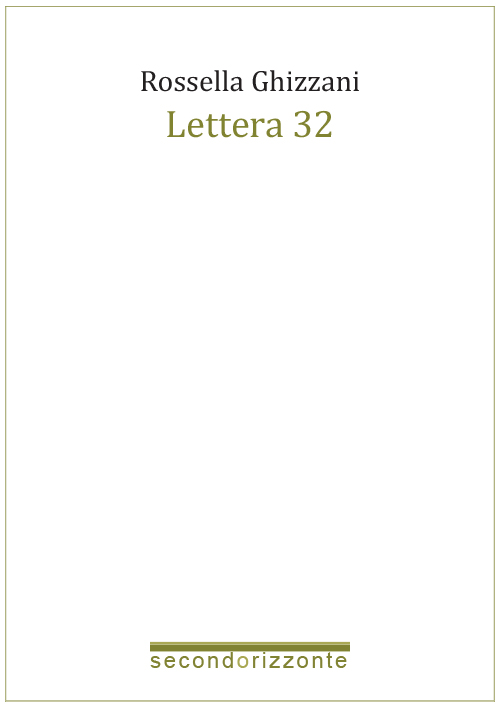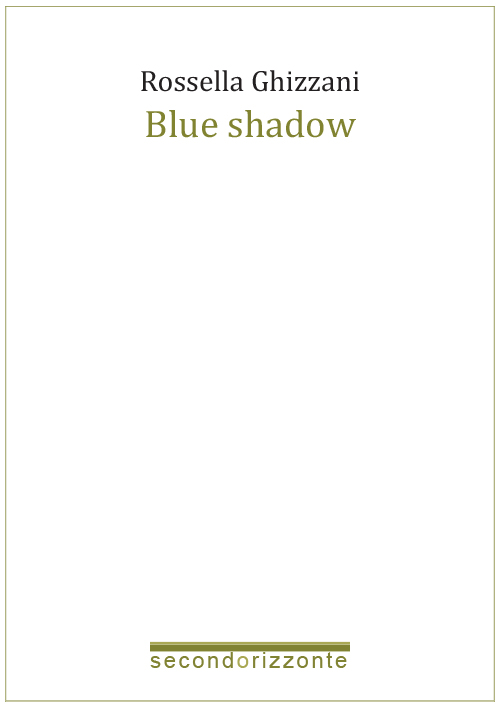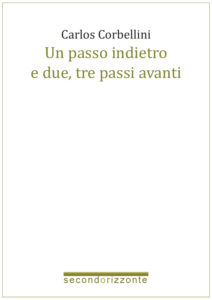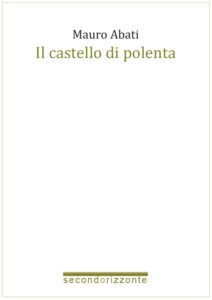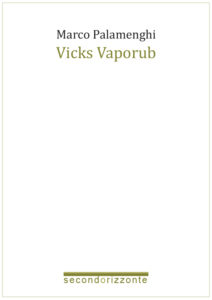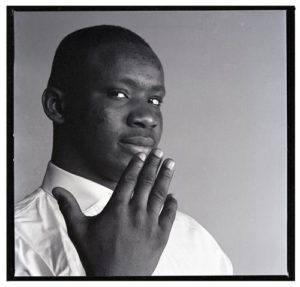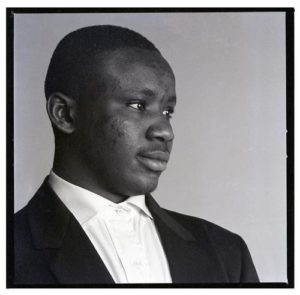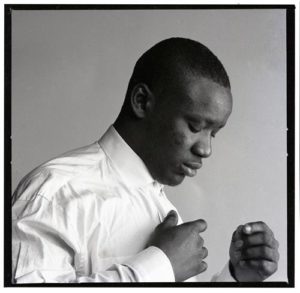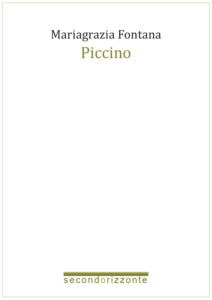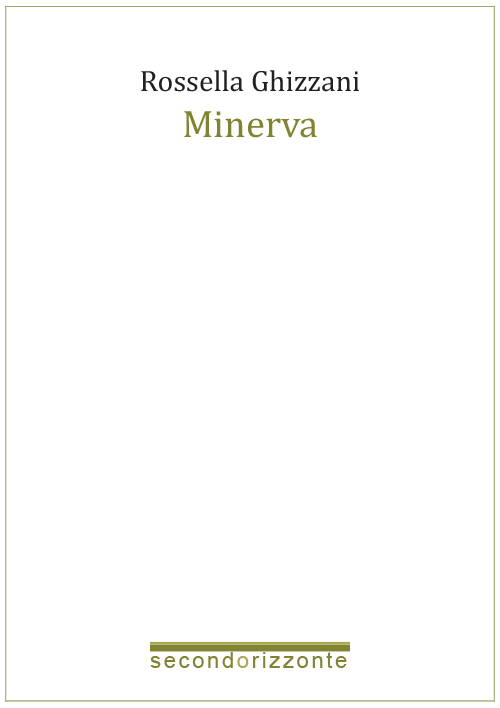
Non si butta via niente! hai detto, sbattendo la porta di casa, mentre lo scalpiccio dei passi già slabbrava il tuo profilo, annacquato nella nebbia gelida.
Ancora ghiaccia questa mattina di inizio marzo; la luce scialba si appresta a depositarsi sulla terra con cattive intenzioni. Come se il cielo scoprisse i denti e le gengive: pronto alla lotta, mi è capitato di pensare.
Era accaduto altre volte. Uscivi carico di rabbia, troppo addolorato per sopportare la mia inaccessibilità e timoroso di assistere alla reazione che la voce e il tuo corpo avrebbero prodotto, se ti fossi concesso di esprimerti.
Camminavi per ore. La strada ti depositava verso sera sulla porta di casa esausto e svuotato, pronto a ricominciare da capo.
Chissà perché, permettevo che accadesse.
Entrambi conoscevamo ormai il copione a memoria.
Ci ritrovavamo in cucina. Io versavo il vino in un calice dal quale sorseggiavamo entrambi; ti preparavi una sigaretta e quando accendevi la tua, davi fuoco anche alla mia, sostenuta fra l’indice e il medio, in attesa.
Ci dicevamo mesti che era l’ora di lasciarci andare ciascuno per la sua strada.
Un brivido sottopelle segnalava a entrambi il pericolo imminente. Ragionavamo su chi avrebbe tenuto il cane, scandagliavamo ogni possibilità solo per arrivare al punto in cui gli occhi dell’uno o dell’altra si sarebbero riempiti di lacrime. Il cane appoggiava il muso sulle ginocchia di uno dei due, lo sguardo malconcio, come se le parole nell’aria lo intridessero dell’amarezza che aleggiava nella stanza.
Più tardi mi sarei alzata e avrei messo su qualcosa per la cena. O lo avresti fatto tu.
Più tardi, saremmo andati tutti e tre a dormire nello stesso letto.
Questa mattina era diverso. Si sarebbe consumato tutto il giorno, senza assistere al tuo ritorno.
Fuori dalla finestra nessuna sorpresa. Questo cielo oggi non avrebbe prodotto niente più che due tonalità, il bianco e il grigio. Non vedo altro. Non le facciate delle case di fronte, non la strada che ti ha portato via, non un pezzo di cielo o un albero. Sfumati insieme, appena un po’ mescolati, questi due soli colori offrono una via d’uscita a ciò che avviene alle mie spalle. Rimanere poggiata ai vetri e guardare fuori è un modo, ora, per cercare impronte diverse su cui modellare questa giornata.
Nelle stanze, dietro di me, avverto la fatica leggera dell’orma che hai lasciato. La stessa che ricorda il mio corpo, da poco riaffiorato dal sonno della notte appena trascorsa. Il cane sta, accucciato con il muso rivolto alla porta, in attesa.
Ecco, ogni cosa non avvenuta si concentra in questa mattina.
E’ quindi questo che è accaduto?
Il gesto banale scatena la furia dolorosa, rivelandone a un tratto la potenza.
Non credevo che sarebbe potuto davvero accadere.
Non lo voglio sapere.
Mi stacco con fatica dai vetri chiusi, trovo la forza di voltarmi e di guardare ancora dentro le stanze della nostra casa. Non ci conoscevamo affatto quando siamo venuti a vivere qui.
La nostra intimità creata da zero, come lana lavorata ai ferri. La prima catenella si palesa come dal nulla e poi gli aghi lunghi che convincono il filo, lo esortano, lo arpionano affinché si faccia intrecciare un punto via l’altro fino a diventare tessuto.
E fra punto e punto una prossimità amica, un calore che incoraggia. Ci si abbandona alla relazione e si costruisce il nido.
Da lì provengono i nomignoli, i giochi ripetuti ogni giorno, la possibilità di una comunicazione che trascende la logica del pensiero compiuto e si affida al solo sentimento, alla complicità di ciò che avviene al riparo da tutto e da tutti. Si ride per qualcosa che solo noi sappiamo, si scambia uno sguardo d’intesa, si pronuncia un’unica parola e per l’altro è come un intero discorso, perché già sa. E anche gli oggetti ne risentono, vivono di vita propria, assumono un ruolo nella casa e nella quotidianità perché ciascuno rappresenta qualcosa e porta con sé il ricordo di un evento preciso che si è vissuto insieme, forse all’apparenza insignificante, ma fondamentale nel punteggiare la storia che via via si va costruendo.
A casa nostra, ad esempio, ci sono sempre stati fiammiferi di ogni tipo, forme e materiali diversi.
Sei tu che ci tieni di più, io come sempre sto un passo indietro, sempre in attesa della fine, non posso affezionarmi troppo.
Porto nella vita questa abitudine a non sentirmi riconosciuta nella mia completezza, temo sempre che giunga il momento in cui su tutto prevarrà il rifiuto.
Rimango in attesa, acquattata nel mio antro. E’ il mio modo per metterci alle strette. Non mi ostino nel conflitto. Anzi. Passivamente accetto, reagisco, partecipo, ma tu non mi trovi più. Dell’attesa di ogni giorno ti chiedo conto, come se dipendesse da te.
Per questo, per cercarmi, per trovare entrambi, insceniamo sovente le prove generali di un addio.
Per sentire l’amore che ci lega e che non riconosciamo più.
Non ho mai capito come tu abbia potuto tenermi così vicino e al tempo stesso tanto distante.
Non deve essere stato facile. Non per te, che da sempre oscuri i timori più profondi mettendo in scena un personaggio che ti salvaguarda: un bell’uomo simpatico, appena un po’ pieno di sé, facile alla battuta, brillante, affermato nel mondo del lavoro per il ruolo importante che ricopre nella sua professione.
Privo di amicizie e completamente solo: della tua famiglia, da molto tempo, non è rimasto nessuno.
Non per me, addestrata a non fidarmi, indisponibile a mettere la vita nelle mani di un altro, abituata a contare solo su di me.
Nella distanza trovano riposo le nostre fragilità, penso.
Lasciare un pertugio da cui continui a fluire un vago senso di estraneità, anche dopo tutti gli anni trascorsi insieme, permette a entrambi la spudoratezza della confidenza.
Ciascuno di noi conserva i segreti dell’altro con la leggerezza con cui potrebbe portarli sulle spalle uno sconosciuto cui per caso ci si è svelati. Quel vago senso di alterità ci tutela, ne abbiamo bisogno per credere che l’altro, alla fine, possa presto dimenticare l’impudenza della confessione.
Torno a guardare fuori. Il cielo si è fatto più ampio; rovescia a terra una luce immota, stantia, che tracima dai vetri delle finestre e allaga le stanze. Fa freddo. Sul marciapiede di fronte, una donna e un uomo procedono lentamente, i movimenti rigidi. Sono anziani, penso. Lei precede, lui si attarda per chiudere la cerniera del suo giaccone, ma stenta a trovare l’incastro. E’ forse il silenzio dei passi dietro di sé che la ferma. Si volta, torna indietro, lo raggiunge e piano piano piega il busto, aggiunge le sue dita incerte a quelle del compagno, le teste vicine, lo sguardo concentrato sul quel meccanismo banale così ostico alle loro mani esitanti. Infine ce la fanno, sollevati riprendono il cammino.
Nella distanza, penso, si smarrisce la dimestichezza che serve quando occorre essere in due per avere la forza di uno solo.
In casa si è fatta strada una luce polverosa. D’improvviso tutto è cambiato.
Mi aggiro fra le nostre cose, ora mute al mio passaggio. Il cane mi segue, mesto, attento a ogni mio gesto.
Cammino a fatica, mi sembra di muovermi nell’acqua.
Il mio desiderio di liberarmi dei fiammiferi ti ha messo fuori gioco: stamani ti ho offeso, penso. Ho tradito la nostra intimità.
E dentro di me, dove ha preso forma quel desiderio?
Oltrepassare il limite dell’accordo tacito mi avrebbe fornito l’unità di misura per comparare la mia paura ai tuoi passi sbandati in giro per la città. So farlo da sempre, penso. Mi sottraggo per tempo al rischio di essere esclusa, tento una sconnessa via d’uscita in attesa di osservare la reazione che provoca.
Buttare via i fiammiferi può definire l’entità della distanza, devo aver pensato.
Private del senso che la nostra unione gli attribuisce, queste bustine possono manifestare solo i variopinti colori delle immagini stampate sulla striscia di cartoncino sottile, ripiegata nel mezzo, che trattiene il foglio di cartone spesso nel quale i fiammiferi sono intagliati.
Sono solo fiammiferi, ho detto.
Non si butta via niente! hai gridato disperato, mentre uscivi di casa. Intendevi dire che non erano solo fiammiferi. Era il nostro patto, stabilito la prima sera trascorsa in questa casa.
Avrò sempre almeno un fiammifero con me, per guardarti e per mantenere accesa la fiamma che tiene in vita il nostro focolare.
Come se stessi giocando a shanghai, lentamente raccolgo una a una le bustine sparse per terra.
Mi concentro sul movimento delle mani per fare ordine nei miei pensieri. Fino a questa mattina erano sistemate tutte in una scatola di legno, un talismano. E’ lì che le ripongo.
E’ solo per me questa buona intenzione, penso, e mi sembra una rivelazione.
Il nostro cane mi sta vicino, fermo, non ostacola il mio lavoro, non ha voglia di giocare ed io non so consolare la sua malinconia. Gli sto vicino, manifesto il mio interesse e gli offro le mie carezze.
Forse la stessa cosa vale per noi?
Impareremo a colmare così quella lontananza che tanto ci ferisce? Mantenere le distanze per passione e ammettere il limite imposto da ciascuno all’altro.
Non ho la facoltà di cancellare il tuo destino né di scivolare dentro la tua pelle; non puoi evitarmi prove e difficoltà: non possiamo assumerci la responsabilità della vita dell’altro.
Non ho altro a disposizione per ritrovare il ricamo dei nostri giorni trascorsi, per riconoscere il senso compiuto del cammino fin qui percorso.
Seduta sul pavimento vicino al cane e con attorno i nostri Minerva, scopro il desiderio nuovo di una vicinanza leale che lasci liberi entrambi. Come accade in ogni nuovo incontro, questo pensiero fa risuonare dentro di me emozioni e parole che finora non avevo percepito; così rivolto la terra della distanza per scoprire come sia possibile coltivarvi il seme dell’appartenenza.
Se torni ho un gioco nuovo da proporti, inventare insieme il nostro futuro imperfetto.
Le bustine di Minerva sono tornate al loro posto. Ormai radente al suolo, la luce si frantuma in scaglie scure che inducono la nostra casa a rannicchiarsi.
Nel buio, il cane abbaia al suono del campanello.