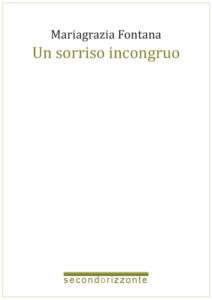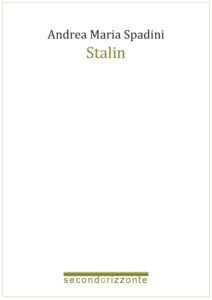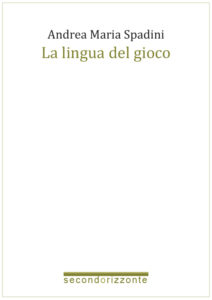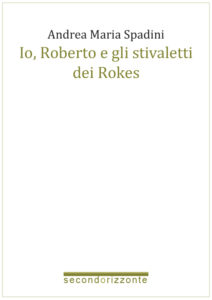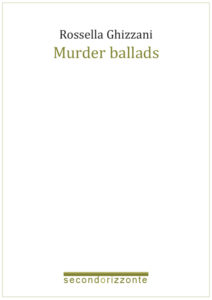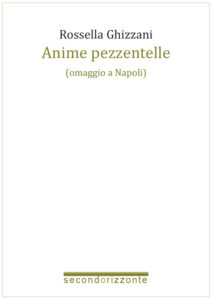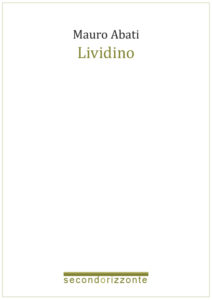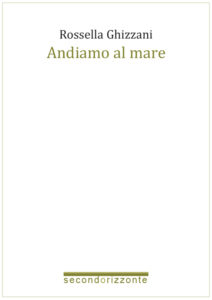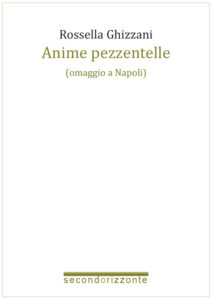
Antefatto.
Della notte prima della partenza, ricordo un sogno.
Mi trovo in un luogo pieno di luce, dove non si può discernere la separazione fra dentro e fuori. Con me ci sono altre donne, sono serena in mezzo a loro.
Sono lì per scrivere, sto bene, posso dedicarmi alla scrittura per tutto il tempo che mi è necessario, senza altri impegni, senza fretta, senza obblighi.
Indosso una sottoveste di raso, chiara, di un colore avorio.
Mi sento pacificata e molto, molto bella; sono parte della luce.
Del risveglio, ricordo la piacevole sensazione di alterità.
Adesso so che nei giorni in cui ho soggiornato a Napoli la percezione di me stessa è stata definita da quella mancanza di separazione di cui il sogno segnava una traccia.
Deve essere stato questo a rendere possibile che la città mi abbia attraversato.
Senza che ne fossi cosciente, e senza sceglierlo, le ho accordato il consenso di manifestarsi.
D’improvviso piazze, vicoli, strade, persone, volti, scorci mi richiamavano alla mente brani di romanzi e di testi teatrali di autori napoletani che non sapevo più di rammentare e che si sommavano a ciò che gli occhi osservavano. Ho potuto così vedere anche ciò che non era palese, costruendo dentro di me una rete di conoscenza, una mappa che, senza delineare confini, mi ha mostrato percorsi possibili, fuori e dentro di me.
Avrei dovuto dedicare tempo e attenzione ai pezzetti di carta di recupero che via via riempivo di frasi minuscole, appunti, stralci di immagini che parevano volteggiarmi intorno con la casualità distratta di ritagli di giornale sollevati dal vento e sparpagliati davanti ai miei occhi. Volteggi repentini che lo sguardo afferra e pone a dimora, per scriverne più tardi.
Avrei dovuto farlo subito, mentre ero ancora lì, mentre mi assordava il frastuono del traffico in continuo movimento, frastagliato dai richiami sonori dei clacson e delle voci, un sottofondo mai muto che sembra provenire dalla facciata delle case, dal manto stradale, dall’aria stessa che si respira in città.
Avrei dovuto svuotarmi le tasche e ripagare la generosità con cui questa città si è lasciata scoprire, compiacente e un po’ sfacciata, impudica, capace di mostrare insieme la sua bellezza e l’anima nera che la attraversa.
Mi è sembrato che non avesse occhi che per me, che abbia cercato il mio sguardo sfoggiando i suoi tesori – ma questo lo sanno fare tutti – e mostrandomi le sue debolezze.
Napoli mi ha concesso l’intimità degli incontri speciali, raccontandomi in confidenza qualcosa di me.
UOMINI E CANI
Era chiaro. Il ragazzo accasciato sul marciapiede non possedeva niente.
Indossava abiti riportati dalla furia di vite trascorse ai margini, passati di corpo in corpo, sudari raccattati a casaccio dalle bocche spalancate dei cassonetti per l’immondizia, assai numerosi in città.
Sembrava prestato anche il cartone troppo corto su cui si appoggiava, né sdraiato né seduto, il dorso un po’ sollevato, sostenuto da un gradino; la spalla sinistra abbassata a facilitare l’abbraccio in cui avvolgeva il sonno del suo cane.
Suo, come suo avrebbe potuto essere un figlio.
Del resto l’animale gli si affidava, senza riserve. Gli si consegnava, ogni muscolo rilassato, senza difese e senza dubbi, sicuro di lasciargli, per il tempo breve del suo riposo, l’incombenza di vigilare su entrambi.
Quell’attestazione di fiducia pareva inchiodare il ragazzo alla propria responsabilità.
Lo stanava, arpionato alla fiocina acuminata di un sentimento d’amore che non sospettava di poter onorare, e di quello si nutriva, proteggendo se stesso e il suo cane.
A destra, la mano e il braccio inscenavano sovente la mossa della questua, ma non sempre, non con costanza ed attenzione; così come il volto, solo di tanto in tanto rivolto dolente ai passanti.
Con quell’animale addormentato racchiuso nel suo abbraccio, il ragazzo sembrava acquisire il potere di esercitare la sua libera volontà. Da quella posizione livellata al suolo rivendicava la sua porzione di vita, di spazio occupabile, di luce e di relazione persino. C’era, si mostrava e si lasciava guardare, uno fra altri, e niente nel suo atteggiamento proponeva vergogna, chiusura, riluttante presenza. Aveva da fare, doveva vigilare il riposo del suo cane, e la bestia compiacente gli si donava, perché del suo sonno il ragazzo potesse fare esperienza, scoprendosi atto alla cura, al rispetto, all’affetto.
Deve essere stato questo a restituirgli dignità. Non possedeva niente il ragazzo, neanche la misura del suo valore, forse giocato d’azzardo e perduto, e niente sapeva dell’amore che covava nel cuore, pure germogliato e lasciato annerire di freddo e di sete per non vederlo umiliare. Nemmeno il cane di questo sapeva, e neppure gli importava. Era semplice La grammatica delle sue relazioni, articolata in regole chiare leggibili tutte nello sguardo che strusciava in faccia al suo padrone. E lui, il giovane mendicante, teneva con sé il cane e di giorno in giorno saziava la sete di quel germoglio gelato. Imparava i gesti di molte premure che apertamente venivano nominate e liberamente scambiate, perché fra loro, paritariamente e con lealtà, si era pattuito il reciproco assistersi, sostenersi, tutelarsi.
Vicino al suo cane, il ragazzo stava, come chiunque altro in quel momento su quell’angolo di via, davanti alle vetrine dei negozi, alle facciate scrostate delle case, più esposto degli altri alla fanghiglia residua formatasi dalla pioggia dei giorni precedenti e incastonata a bella vista fra i ciottoli del selciato.
Esisteva, incontestabile presenza mescolata ad arte con i passi della gente, lo stridio incauto delle ruote, il transitare distratto di altre vite, altre storie, altri pensieri.
Nessuno avrebbe di certo potuto escluderlo dall’immagine riprodotta di quell’angolo.
Il ragazzo e il suo cane ne facevano parte, ne rivelavano un dettaglio prezioso, costituivano una parte essenziale della scena.
Spesso il suo sguardo, ora amorevole, si rivolgeva all’animale addormentato e la mano sembrava richiamata da una necessità impellente verso quel corpo riverso fra le sue braccia.
Bisognava controllare che dormisse tranquillo il cane, e carezzarlo, il palmo della mano avanti e indietro sul costato, le dita aperte a scorrere nel folto del pelo, per accompagnargli i sogni e nutrirsi del suo tepore.
Era chiaro, non possedeva niente il ragazzo, a parte il sorriso che gli sfuggiva dal viso quando guardava il muso assopito del suo cane.
GIAN BURRASCA
A precederli era stato il chiasso del loro vociare.
Non correvano, neanche giocavano. Facevano scorribande, rumorosi e prepotenti, nella piazza antistante al sagrato della chiesa, una delle più importanti della città.
Sembrava che fossero ruzzolati fuori dai vicoli circostanti, un po’ per volta, incerti e guardinghi, e che si fossero ritrovati lì.
Da soli avevano attraversato la strada insicuri come uccellini sgusciati fuori dal nido, insieme assumevano la forma di uno stormo organizzato e agguerrito, pronto alla caccia.
A contarli saranno stati una decina, tutti maschi, e sembrava che nemmeno uno tacesse.
Portate dal vento, le loro voci si chiamavano, si rincorrevano, contornavano la scena di una sonorità sguaiata che faceva eco ai loro gesti e riempiva la piazza.
Avevano una bicicletta e un pallone, cui tiravano calci con convinzione esasperata. Imitavano le espressioni e le movenze dei calciatori famosi che di sicuro guardavano alla televisione. Si sfilavano le magliette, incuranti del vento e del cielo buio, gonfio e teso come un ventre, pregno di gusci di temporale, e correvano in tondo, ciascuno proteso a soverchiare l’altro, una questione d’onore che avrebbe confermato il potere del più forte.
Di tirar calci alla palla si erano stufati presto. Avevano bisogno di una sfida più definita, che consentisse risultati precisi e mettesse in gioco il coraggio e la forza di ognuno.
Allora c’era da saltare al volo sulla bicicletta in corsa, prendere velocità e lanciarsi a tutta forza contro la scalinata che conduce alla chiesa e al portico che la circonda.
Via via che uno si sfilava dal gruppo, gli altri restavano compatti, incitandolo o deridendolo con grida sempre più alte, eccitate dall’euforia del rodeo e un poco intimidite dall’ apprensione per l’esito incerto della prova, che avrebbe stabilito la sorte dell’amico e quella di quel pomeriggio domenicale.
Un attimo prima dell’impatto ogni sfidante serrava le mascelle e le leve dei freni, governando con le gambe e le braccia lo sbandamento delle ruote. Contraeva i muscoli, per evitare l’urto ed effettuare una virata stridente che arrestava la corsa e lo depositava sull’asfalto, il volto rosso e sudato, disarcionato dalla bicicletta che da sola urtava sferragliando contro i gradini.
Facevano tutto rapidamente, con avidità, dovevano liberare quell’energia arrabbiata, trattenuta a stento nelle magliette troppo strette e nei calzoni, continuamente tirati verso l’alto, le mani alla cintola, con un gesto impreciso che rivelava l’inesperienza della loro minima età.
Disseminati nella piazza, si erano improvvisamente ricomposti in gruppo quando, all’unisono, uno aveva scovato lo scheletro malandato di un ombrello – raggiera di spade acuminate atta a ferire – e gli altri avvistato un barbone addormentato.
L’uomo, avvolto in un trapuntino lurido che gli lasciava scoperto solo il viso, dormiva – abbattuto al suolo dalla stanchezza, dalla fame o dall’alcol – seminascosto tra due colonne del portico.
Non avevano avuto bisogno di parlarsi, era chiaro, quello che c’era da fare ora era accumulare punti al tiro a segno.
Si lancia l’ombrello, vince chi fa centro.
Sul portone della chiesa il mendico accovacciato, affetto da sindrome di down, doveva aver captato l’eccitazione che i bambini spargevano sul sagrato, seminata con gesti ampi delle braccia che mentre gettano il seme a terra auspicano un buon raccolto.
Si era sollevato dalla posizione con cui implorante tendeva la mano e ora saltava sul posto, a gambe unite, di continuo, la faccia spalancata in un riso sfasciato che urlava lo sgomento e l’incitazione.
I bambini anche gridavano, si auguravano l’un l’altro vittoria.
Paura ed umiliazione per quel fagotto accasciato che stentavano a nominare uomo.
Non avrei davvero saputo come farlo, ma le gambe mi conducevano verso quella nidiata minacciosa. Adesso bisognava interrompere quella scena in crescendo, palesarsi a sorpresa sul palcoscenico e introdurre un elemento di novità, un impedimento che smascherasse quella ghigna da fiere e riportasse alla luce i loro visi bambini.
Prima che li raggiungessi, li incrociò il passo claudicante di una donna. Li richiamava, con parole in lingua. Doveva conoscerli uno ad uno, alzava benevolmente il suo bastone per attirarli a sé, li convinceva.
La riconobbero, gettarono l’ombrello spezzato, formarono di ancora uno stuolo per starle intorno e scortarla fin dentro la chiesa, dove rimasero con lei.
Contemporaneamente una ragazza, scesa velocemente da una macchina fermata in corsa sulla piazza, saliva rapida i gradini e lesta prendeva per mano il mendico, che ancora vociante si lasciava condurre via.
Come a rispettare un ritmo che non avevo compreso, come se davvero avessi assistito al cadenzato svolgersi di una scena teatrale.
Sul sagrato della chiesa era rimasto il sottofondo rumoroso del traffico, fra le colonne del portico il corpo dell’uomo ancora immobile e lo scheletro sbrindellato dell’ombrello.
Nella piazza, le prime gocce di pioggia benedicevano le spoglie dimenticate di quell’infanzia malmenata, e il vento le ruzzolava per aria per poi seminarle ancora, farle diventare più forti e vederle fiorire.
ANCORA BAMBINI
C’è il sole oggi! Il cielo è azzurro, le nuvole sventolano, bianche come il bucato appeso ai fili tesi fra i vicoli.
La giornata ideale per visitare il Monastero di Santa Chiara e il suo portico maiolicato.
Venite, per i bambini dell’ospedale Cardarelli, signora, lo volete donare il sangue?
Cortese, la voce si introduce fra i miei passi. A parlare è stata una giovane donna, bella, il volto sorridente. Un foulard colorato le avvolge le spalle e smarrisce l’uniformità nera del suo abbigliamento.
Impossibile non fermarle gli occhi in faccia.
Signora, la volete fare una donazione per i bambini del Cardarelli?
Quella seconda persona plurale rivolta al mio aspetto e alla mia età marca il rispetto della distanza e pure stabilisce una familiarità, una vicinanza, la ricerca di un pertugio che possa farla germogliare.
Non la si può in alcun modo liquidare con il rifiuto garbato riservato ai seccatori in genere. La ragazza non intende vendere niente, non mi imbroglia.
Sorridendo chiede in pegno un po’ del mio sangue, come se glielo dovessi, per quell’accento accomodante e marcato che ritma la prosodia del suo domandare, per le strade della sua città, per le piazze, per i volti che mi sono venuti incontro, per la bellezza di cui mi hanno nutrito e per le immagini di cui mi sono riempita gli occhi.
Ma può bastare? Perché proprio in questo momento mi sembra che quella richiesta – un po’ del mio sangue – si faccia spazio dentro di me e vada ad aderire perfettamente con la matrice profonda di un desiderio? A cosa risponde quella domanda, da dove proviene la disponibilità imprevista a mettere in gioco il mio corpo?
Una freccia di Cupido scoccata all’improvviso all’inizio di un giorno qualsiasi, che di speciale vanta la qualità di vacanza e la bellezza del luogo in cui mi trovo.
Cosa rende possibile qui un atto che tante volte ho immaginato di compiere senza mai lasciarne seguire un esito concreto?
Qui l’esposizione cui sottopone la città mi appare evidente, il concetto generico di bisogno si trasforma, rendendo visibile la trama del tessuto e insieme il suo rovescio.
Mi sembra che la commistione, la miscela di bellezza e bruttura, forza e debolezza, speranza e rassegnazione, pervada gli incontri, i giochi dei bambini, ogni scorcio, allungando i suoi tentacoli verso la diffusa, vociata quotidianità che tracima dai vicoli, si riversa nelle strade eleganti e le confonde.
Confusamente penso che quel dono possa compromettermi, erodere la separazione fra me e la città, rendermi parte di essa.
Qui avverto come concreta la possibilità fisica, tangibile di dare vita. Non di generare, no. Piuttosto di salvare, richiamare dalla morte, infondere forza vitale.
Un alito sparuto che pure possa riaccendere la scintilla del respiro. Una carezza capace di sollecitare la contrazione sincrona degli atri e dei ventricoli, resuscitando lo scalpiccio delle pulsazioni.
Il corpo si nutre di questa eventualità, acquista potenza, mi soverchia e infrange lo schermo vetrato del mondo di parole che mi avvolge.
Non ho il tempo di investigare a fondo la mia volontà. Sto già salendo i gradini che conducono al camper dell’Avis parcheggiato poco distante e ora porgo il dito da pungere per la prima verifica della mia idoneità.
Dentro di me si conferma il desiderio profondo di accondiscendere alla richiesta che mi è stata rivolta.
Sì, glielo devo un po’ del mio sangue a questa città.
Il volto dell’uomo corpulento che con gesto preciso mi infila l’ago nella vena sembra velato dal manto di un sorriso.
Mi guarda, mentre il sangue colora di rosso la cannula infilzata nella sacca di raccolta.
E così signora, vi volete imparentare con i napoletani?
Non mi pare un’affermazione qualunque. Al contrario, quelle parole sembrano colmare e dare sostanza a quel mio sentire sospeso.
Metto in serbo l’emozione di quel pensiero, mentre si avvia uno scambio qualsiasi di battute sulla sua professione, che interdetto si arresta quando lui mi guarda ancora.
Questo è il lavoro. Poi facciamo altro. Prima persona plurale, noi.
Pure mi sembra certo che si parlasse solo di lui, ma quel noi lo sdoppia, come se la sua individualità potesse duplicarsi e scomporsi permettendogli azioni diverse che lo rendono superiore all’unità.
Non ci vuole niente per sentirgli dire scrivo, e ancor meno per chiedergli vorace cosa.
Mentre il sangue defluisce lentamente, si appoggia al lettino su cui sono distesa e parla.
Storie, sono quelle la sua passione. Adesso ne sta scrivendo una nuova.
E’ difficile, dice, e racconta.
Un camorrista, un delinquente feroce che nella vita non aveva avuto riguardo per niente e per nessuno, uno che aveva commesso crimini tanto efferati quanto pregni di malvagia volontà.
Impunito, aveva lasciato la sua città e da anni viveva in America.
Incastrato per reati fiscali e processato, si fa difendere dal miglior avvocato della città, scoprendo in seguito che questi è figlio suo, un figlio che non aveva mai saputo di avere.
Quando la giuria emetterà il suo verdetto, gli sarà inflitta la peggiore delle pene.
Mentre mi libera dall’ago svela il sorriso e mi domanda qual è, secondo me, il castigo peggiore che possa toccare. Non rispondo.
Quell’uomo sarà condannato per sempre all’amore.
Non trovo parole da dirgli. Trattengo le sue, che lui ha liberato soave, sicuro, intonandole con quel suo accento melodioso. Le accantono nello spazio compreso fra diaframma e cuore, le lascio attecchire.
Dopo, quando riconquisto le strade della città, è una festa.
Mi sento la pelle cosparsa di un brulichio diffuso, anche il corpo fa festa, deborda dalle paratie ossute del mio costato, si espande, spalanca il passo vincolato dalle redini attaccate alle anche e lascia sbocciare lo stomaco, che si dilata e reclama cibo, lo pretende, lo chiama, lo implora.
Mi sono fatta spora, nettare, polline. Sperimento l’incastro perfetto.
Come in sogno, non c’è confine che mi distingua, anch’io mi sdoppio e mi moltiplico, mi riproduco infinite volte fino ad occupare lo spazio che mi contiene, ne divento parte, come fossimo un tutt’uno.
Sulle maioliche delle colonne del portico di Santa Chiara si rincorrono le luci e le ombre di questa giornata assolata.
Mentre le guardo i miei pensieri si specchiano nei volti dei bambini in guerra sul sagrato della chiesa e ne fanno tutt’uno con quelli, mai visti, ricoverati all’Ospedale Cardarelli.
Per tutto il giorno, per me la città si fa cornucopia e mi dispensa i suoi beni, in segno di prosperità.
Per tutto il giorno i miei passi rimangono sospesi a mezz’aria, e stento a sopportare il peso della condanna che mi grava sul cuore, obbligandomi per sempre all’amore.
SALONE DI BELLEZZA.
Ora che ho preso un po’ di confidenza con la città, posso permettermi di entrare nei Quartieri Spagnoli. Lo faccio con garbo, chiedendo permesso, non voglio intralciare la vita sporta direttamente sul vicolo, esternata nella strada, affacciata senza riserbo dalle porte a vetri delle casse basse, esposte sul marciapiede.
Sono aperte le case. Ne tracimano gli odori del pranzo, il sonno inquieto dei lattanti, l’amore delle giovani coppie, il lamento intermittente dei malati, i passi strascicati degli anziani. E’ tutto lì, senza che niente disegni confini, senza separazioni, a vista.
Mi imbarazza guardare dentro, eppure senza volere lo sguardo inevitabilmente coglie lo scorrere dell’intimità riposta in quelle stanze il cui soffitto mi sembra così vicino al suolo.
Mentre cammino, il fuori e il dentro si confondono, la distanza annullata dall’andirivieni dei bambini, dalle voci che si spingono all’esterno, dai dialoghi frammentati rimbalzati dalle soglie alla sosta rumorosa di motocicli il cui soffermarsi è come una visita, un passaggio breve, uno scambio di battute rapido su qualcosa che avviene e che necessita accordi, domande, impegni.
Mi paiono palloni, le parole lanciate dalla casa e rinviate dalla strada. Accolte e rimandate dal selciato al pavimento, una schiacciata, un calcio, un lancio preciso delle mani.
Assisto allo svolgersi di relazioni di confidenza come avvenissero al riparo dalle indiscrezioni degli estranei.
Mi incuriosisce la bottega di una giovane donna che racconta storie non scritte né narrate, solo ricamate sulla copertura di stoffa degli ombrelli. Su ciascuno dei triangoli uniti a formare la calotta sferica che ripara dalla pioggia, applicazioni e cuciti a segnare la traccia inconfondibile di un paesaggio, della biografia di attori e cantanti famosi, di fiabe conosciute in tutto il mondo.
Mentre mi racconta, questa volta a parole, la storia dell’arte familiare che le è stata tramandata e che porta avanti con passione, mi guardo riflessa in uno degli specchi appesi alle pareti del suo negozio. Non mi piacciono i miei capelli, appesantiti dalla pioggia e come spessiti dal tempo trascorso fuori, nelle strade e nelle piazze continuamente esposte agli sfiati dei tubi di scappamento.
Desidero lavarmeli. E se andassi da un parrucchiere?
Non se ne parla. Qualcuno che non conosco, figuriamoci. Non mi faccio toccare la testa da uno sconosciuto. E l’igiene? La prevenzione di malattie contagiose?
No, non se ne parla.
Ma non c’è verso. Questa città si insinua dentro di me, mi accoglie e mi scioglie, dilegua le reticenze della mia volontà e mi prende. Acconsente ai miei desideri, li prevede e li esaudisce come se mi intuisse, se sapesse qualcosa di me che desidera farmi imparare. Liberato dalle briglie della fermezza e della determinazione, il corpo galoppa, va in avanscoperta, annusa, assaggia e già scorge, sull’altro lato del vicolo, un basso adibito a salone di bellezza.
Vi si accede da una porta a vetri dalla cui soglia digradano tre scalini. Si entra scendendo in un locale unico, decisamente ridotto nelle dimensioni, con i soffitti a volta, organizzato in quattro zone: il banco dell’accoglienza che ha anche funzioni di cassa, i divanetti per l’attesa, i lavabi e la consolle con grandi specchi per l’asciugatura e la messa in piega.
Non c’è nessuno, sono l’unica cliente. L’uomo seduto dietro il banco, informato sulle mie necessità, dà indicazioni alla parrucchiera. E’ piccola di statura, in carne. E’ lei che, senza proferire una parola, mi fa sedere al lavabo e con gentilezza mi lava i capelli. Spalanca le dita delle mani e le infila nel groviglio che le porto, avanti e indietro, a destra e a sinistra, sopra e sotto, non trascura niente, paziente e accurata, decisa a riportare ordine in quel guazzabuglio. Mentre ricevo le sue cure, percepisco il piacere di quella pulizia meticolosa, non temo nulla, mi distendo, la lascio fare, sapiente e morbida com’è.
Accennando semplici gesti, ora mi fa accomodare all’asciugatura. Sollecita da dietro il busto per farmi piegare in avanti, ancora usa le mani per restituire una forma alla mia chioma incapricciata. Si aiuta con creme, balsami, unguenti che massaggiano la cute e lucidano i capelli. Da quella posizione non posso vedere altro che i miei piedi. La sagoma della parrucchiera si smarrisce, rimaniamo d’intesa legate attraverso i miei crini e i suoi polpastrelli. E’ come se le avessi consegnato una parte di me, con quella fiducia un po’ sfrangiata con cui a volte si affidano intime confidenze a sconosciuti di passaggio.
A ciocca a ciocca li convince, li sollecita, chiede loro volume, luminosità, leggerezza.
Me ne fa dono, forse intuendo il legame sotteso fra l’intrigo di quei filamenti ingrigiti e la massa dei miei pensieri.
Sospinta da una sua lieve pressione sull’omero, lascia che risollevi il busto e che i nostri sguardi si incontrino nello specchio.
Lei mi incrocia con un’occhiata in tralice, benevola, sapiente, che mi richiama alla mente la complicità di incontri sbandati eppure generosi, scambi d’occasione che pure germogliano negli occhi l’affetto di chi si è dato senza riserve, sia pure senza conoscersi o parlarsi.
Il mio, grato, le sorride, perché fra me e lei si frappone una capigliatura che mi è ignota e che pure mi somiglia, pare dare sostanza a quel mio sentire svagato.
Sembra che poggi appena sul cranio, libera, semovente, vaporosa.
Anche lei piega la bocca al sorriso e un cenno del capo risponde al grazie che le lascio, come se le risultassi straniera. Le pare forse inefficace, del tutto inutile cercare parole.
Quando risalgo alla luce ombrosa del vicolo mi ritrovo nei piedi passi aerei.
Il peso ora lieve dei capelli, imprime un ritmo incorporeo al mio cammino e lascia svaporare i pensieri, che si dileguano. Nemmeno io, adesso, necessito di parole.
Mi accontento dei profumi, dei rumori, delle strade e della gente.
Cammino, appesa ai fili grigi sospesi sulla testa, burattino sorridente in volo sulla città.
FACCIA GIALLA
Sì, deve essere così, questa città mischia.
In lingua, viene usata l’espressione me lo ha mischiato, mi mischia, per affermare di essere stati contagiati.
Questo modo di dire mi richiama alla mente l’intimità ancestrale di corpi che si uniscono, si incrociano, si accavallano, tanto profonda da farmi pensare al legame di carne e di sangue, aprioristico e inviolabile, che lega il feto al suo utero materno.
Napoli mescola così, senza riguardo per gli anticorpi e le difese immunitarie, annulla le distanze, le separazioni, confonde il piano reale con quello fantastico, il sacro con il profano, l’arte e il sudiciume, il mondo dei vivi e quello dei morti.
Eppure non manca di rispetto, no. La morte è onorata, considerata e tenuta alla giusta distanza, in una relazione paritaria nella quale ciascuno ha il suo peso e il suo ruolo.
La devozione per i defunti – forse un poco intrisa di superstizione – si fonde con la vita di tutti i giorni, riferita sulla facciata delle case dai tabernacoli, ove dimorano foto di cari estinti amalgamate ai panni stesi, ai motocicli in sosta, ai sacchetti della spesa o dell’immondizia. Anche la venerazione per i santi, disseminata sotto forma di statue e immagini allocate nelle numerose nicchie sparpagliate sugli angoli dei muri della città e abbellite dai più stravaganti ornamenti, mi sembra intrisa di familiarità, la stessa che ritrovo nel modo affettuoso con cui i napoletani si rivolgono a San Gennaro, appellandolo faccia gialla, per il colore del volto della statua che lo rappresenta.
Nel Quartiere Sanità lo raccontano i teschi del Cimitero delle Fontanelle, e l’antico culto delle anime pezzentelle. Allineati in bell’ordine, puliti, qualcuno lucido, altri poggiati su morbidi cuscini, contornati di lumini e fiori o riposti in teche di legno o di vetro, nelle quali dimorano soavi in compagnia di piccoli pupazzi, animali di peluche, monete, centinaia di teschi rammentano di essere stati a suo tempo adottati da fedeli che pregavano per le loro anime poverelle, in cambio di una grazia. Si trovavano in sogno, unico mezzo di comunicazione fra vivi e morti, la povera anima che chiedeva suffragi per alleviare le pene del suo purgatorio e il povero devoto che a lei si affidava per ottenere una benedizione o i numeri da giocare al lotto. Se l’anima prescelta non esaudiva le richieste, veniva abbandonata al suo destino. Così il miracolo, fatto di per sé straordinario e superiore alle possibilità comuni, spogliato dal suo significato diventa cosa quasi terrena, che si contratta, si baratta, si fa oggetto di patto e di scambio e pone sullo stesso piano la dimensione sovrannaturale e quella umana.
Entrare nella profondità di quella vecchia cava di tufo mi provoca la sorpresa dirompente di trovarmi in un ossario dove ciò che altrove rimane celato per decenza, pudore, ritegno, perché non si guarda l’effetto prolungato dell’azione della morte, qui viene esposto senza riserve.
E’ proprio questa esibizione a purificare quelle ossa da qualsiasi accezione macabra; l’ordine che gli è stato attribuito, quelle file composte di tibie e di crani sovrapposti sembrano il risultato di un compito eseguito con scrupolosa perizia. Le mani che vi hanno provveduto devono averlo portato a compimento con delicatezza, facendo attenzione che nemmeno uno dei teschi ruzzolasse a terra. Per ciascun avranno cercato il punto esatto di equilibrio, facendo combaciare ossa frontali e temporali e completando poi con quelle lunghe.
A ciascuno il suo posto, un lavoro ben fatto che infonde pace e serenità.
Cosa, penso, riesce a tessere questa tela che intuisco e che, mi sembra, unisce gli opposti e li mette in relazione?
Mi ritornano in mente le persone che ho incontrato per caso, camminando, e con cui ho scambiato quattro chiacchiere. Così come, immediatamente, le loro voci hanno intonato la premura dell’accoglienza, indagando un mio possibile bisogno, senza riserbo alcuno hanno anche nominato le meraviglie della loro città insieme alle ferite, ai rischi, alla presenza di attività ai margini della legalità, quando non decisamente pericolose ed illegali.
Come a dire questo è, questo siamo, se vuoi questo possiamo donarti.
Così penso, forse è la capacità di comunicare che mischia, sono le parole il veicolo della trasmissione per contagio che la città opera fra i suoi opposti.
Qui la parola stabilisce una relazione che rende concreto il sostantivo comunanza e ammette a partecipare.
E’ innegabile. Come nessun’altra città che conosca, qui l’ombra determina e contiene lo svelarsi della luce, che mi regala immagini allestite ad arte per scavare nella profondità del mio animo.
Quando riparto, porto sulle spalle compassione e in mano la misura della vita.
novembre 2016