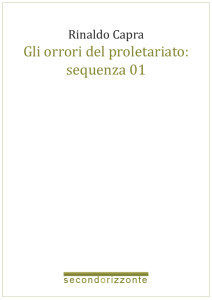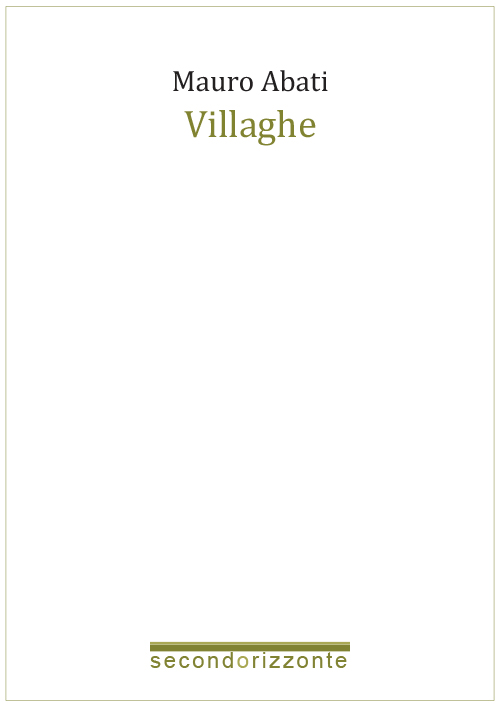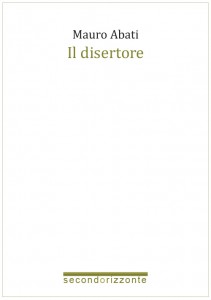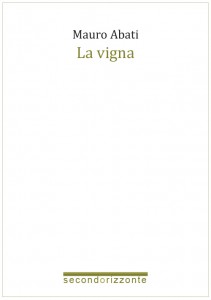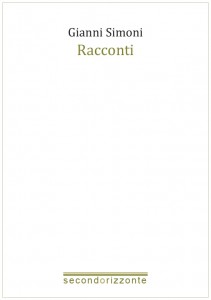“Abbiamo bisogno che, insieme al pensiero, passi fra noi anche qualcosa della massa sterminata di cose ignorate e taciute, cieche e mute, impensate e impensabili, che si stende fuori dal mondo dei segni, cose che siamo tutti i momenti, che capitano da tutte le parti, come meteoriti sulla terra, e che ignoriamo o subito dimentichiamo, le cose reali che nel mondo dei segni qualche volta entrano facendo un segno negativo, un meno, o meno ancora, uno scarabocchio.”
(Luisa Muraro, Il Dio delle donne, Milano, Mondadori, 2003)
Sedici era il numero dei piani e anche il civico della via, che in quel tratto s’infrangeva contro l’arcata d’ingresso del condomino per proseguire poi il suo corso lineare, arginato da comuni marciapiedi su cui affacciavano, uno accanto all’altro, ordinari giardini di villette a schiera.
Passare sotto quel volto mi faceva pensare all’attraversamento di un ponte levatoio che, inesorabilmente, si sarebbe chiuso dietro di me.
Immaginavo lo sforzo rumoroso degli argani che sollevavano il pesante impalcato dietro le mie spalle, isolandomi dal giorno che lasciavo fuori, dal colore del cielo, dal sistema regolato di relazioni, impegni, sentimenti – la consuetudine del mio vivere quotidiano – per consegnarmi a una normalità del tutto diversa, a un instabile equilibrio di cemento armato su cui, ad ali spiegate, la sorte precipitava planando, dirompente, come meteoriti sulla terra.
Lo chiamavano al femminile – è un condominio ma è denominato Torre – per la sua altezza, o forse per richiamarlo al pensiero comune come simbolo d’incrollabilità.
Anche in questa Torre, come nel racconto biblico della Torre di Babele, lingue diverse confluivano e si confondevano, portate dalle storie di donne e uomini provenienti da tante parti della Terra.
A un certo punto ho cominciato a pensare che quel nome, Torre, derivasse dall’immagine dell’arcano numero sedici del mazzo dei tarocchi, Le maison Dieu.
Un luogo in cui si creano accadimenti, dove lo stare insieme provoca rovesciamenti e scambi, dove la solidità delle mura non garantisce e non tutela dalla fragilità combinata di così tante vite, ignote le une alle altre ma non ignare le une delle altre.
Un paese, un piccolo paese sviluppato in verticale, senza un centro, senza una piazza; solo vie strette, parallele che non si intersecano mai.
Un organismo pulsante con le radici in Africa, in Italia, in India, nelle baracche del campo nomadi di una qualunque periferia, nell’Europa delle guerre.
Al crepuscolo, a guardarla da fuori, la luce di ogni finestra raccontava una storia, un mondo, una musica, il profumo di una cena i cui sapori, come una scintilla, sapevano risvegliare d’improvviso frammenti di passato radicati nella memoria.
Dietro ogni finestra, persone.
Erano, o erano state, ricche, povere, operaie e operai, nullafacenti, artisti, bottegai, sindacalisti, infermieri, profughi, dipendenti pubblici, laureati e analfabeti.
Per qualcuno di loro, l’abitazione precedente all’appartamento nella Torre era stata una baracca, una roulotte, una grande dimora signorile di Casablanca, una casa berbera scavata in un pozzo, una casa di pietra con il tetto spiovente, una tenda, un garage, il sottopasso di una ferrovia, una stanza in casa d’altri.
Alcune, prima di abitare alla Torre erano giovani, non lavoravano, avevano i figli piccoli ed era stato il matrimonio e la nascita del primo bambino a portarle lì.
Altri, prima della Torre avevano un’impresa, una sartoria, una bottega di restauro, una tappezzeria, un negozio da barbiere.
Alcuni facevano i turni in un’acciaieria, altri avevano giocato d’azzardo e non smettevano di farlo.
Molti avevano portato le proprie esistenze alla Torre per rovesci, per una grandine inaspettata e inconsueta che li aveva colti di sorpresa senza dar loro il tempo di salvare il proprio raccolto.
Persone. Colleriche, collaboranti, miti, provocatorie, pretenziose, accomodanti.
Sole, o affollate numerose in appartamenti sotto dimensionati.
Sole, o con nidiate di bambini nati uno dopo l’altro come fossero ciliegie, come se la nascita di uno si lasciasse dietro la scia del piacere e del desiderio di partorirne subito un altro.
Bambini. Felici, incompresi, curati e abbandonati, malvestiti, malnutriti, rivestiti di capi firmati all’ultima moda, violati, coccolati. Nella portineria e nel parco adiacente al condominio, una concentrazione che stordiva.
Donne, anziane e sole, i cui appartamenti contenevano immutati gli arredi di quando ciascuna provvedeva alla cura di una famiglia numerosa. Tante stoviglie, tanti armadi, letti, lenzuola, tovaglie, coperte, asciugamani.
Gli oggetti costituivano la loro corazza, sentinelle inamovibili di un passato nel quale erano state forti, madri, bussole e perni del farsi della storia, anche quando la storia si era rivelata sbagliata.
I corridoi lunghi, piastrellati di linoleum nero, erano illuminati da una luce fioca, al neon, che ricordava i garage sotterranei e suggeriva una vaga percezione di insicurezza.
Posso sentirne i rumori e ascoltarne i suoni, rievocarne gli odori, riprovare nelle narici e nello stomaco la stretta che talvolta i miei sensori ergevano, in difesa dai miasmi che esalavano dai vani ascensore, dalle rampe delle scale, da dietro le porte di alcune abitazioni.
Quel bagliore dimesso rendeva opaca la tinta rossa delle porte, la diminuiva di una tonalità cromatica e produceva stonature nel brulichio sommesso delle storie.
Erano le storie ad accogliermi. Prima che le porte allineate si aprissero, mi sapevano suggerire inquietudine, benevolenza, segreti e menzogne o l’esplicita, cruda verità.
Gli odori, mescolati al sentore di vita di cui quegli anditi di passaggio ribollivano, sapevano orientarmi.
Una mappa che mi consentiva di avere il tono di voce adeguato, l’espressione del volto appropriata, la padronanza dei gesti: la porta sarebbe stata aperta o socchiusa a spiraglio, avrei o non avrei dovuto togliermi le scarpe prima di entrare, mi sarei seduta o non l’avrei fatto, avrei evitato di guardare negli occhi il mio interlocutore o la forza dello sguardo mi sarebbe servita per annodare il primo filo di un legame.
Quello che accomunava ogni ingresso, era lo sferragliare della chiave nella serratura: ciascuno chiudeva con quante più mandate possibili la porta rossa del proprio alloggio.
Centoottantasette appartamenti abitati da circa seicento persone.
Seicento persone occupate a nutrirsi, lavarsi, parlare, dormire, ballare, piangere, innamorarsi, separarsi. A nascere, vivere e morire.
Ero lì per quello, per le persone, era quello il mio lavoro.
Avevo il compito, affidatomi dalla Cooperativa per cui lavoravo, di coordinare il gruppo di lavoro sul disagio adulto che gestiva alla Torre il servizio di Portierato Sociale, di sollecitare le relazioni fra gli abitanti di quel castello affinché riscoprissero il senso del buon vicinato; di garantirne la sicurezza, di mediare nei conflitti, di ripristinare un sistema di regole condiviso che rendesse positivo, proficuo, benefico il con-vivere, il co-abitare, lo stare insieme e sostenesse le famiglie e le persone più bisognose. Il mio campo di azione quella società scomposta che si rivelava a tranci dietro la porta di ciascun appartamento. Ognuno un mondo a parte, lo spicchio isolato di un globo frammentato in tanti pezzi, la cui unità, in parte, dipendeva anche da me.
L’estensione della superficie della placca dei campanelli e il numero delle cassette della posta bastavano da sole a testimoniare che non fosse cosa semplice.
All’ultimo piano, le cantine.
Non erano chiamate soffitte ma cantine.
Sopra le cantine il tetto, dalla cui prospettiva cambiava del tutto la visione del posto in cui mi trovavo.
Era esposta ai venti la Torre, correnti ascensionali che la rendevano gelida d’inverno e molto fresca in estate. Abitarla, soffermarvisi, frequentarla ogni giorno, faceva sentire appesi a lunghe soste al margine di un’autostrada.
Nessuna sicurezza, nessuna certezza. Lo spostamento d’aria provocato dai mezzi pesanti in circolazione scuoteva le vesti, faceva volare via gli effetti personali, disperdeva nell’aria frammenti di parole, emozioni, brani interi di esistenze.
Alla Torre, il numero stabilito di residenti, combinato in ordine casuale con quello dei visitatori, con la molteplice disomogeneità degli abitanti e con l’intreccio, in continuo mutamento, dello scoccare di relazioni diverse, rendeva possibili serie infinite di composizioni.
Lì poteva accadere di tutto.
Poteva accadere che la nebbia si impadronisse di un pomeriggio d’inverno e nascondesse la Torre agli sguardi, mentre la morte, furibonda e silente, alzava il sipario sulla scena che aveva saputo allestire. Toccava a noi scoprire i resti mortali, e il nostro sguardo rendeva la scena reale, circoscritta all’esame del medico necroscopo e ricondotta alla liturgia del rito funebre. Negli occhi restava quel che non avremmo voluto vedere, sulla lingua il retrogusto acre della paura e del disgusto e, sotto la suola delle scarpe, tracce che solo cento e mille e mille passi avrebbero potuto cancellare.
Poteva accadere che le parole del dolore e della sottomissione, pronunciate a brandelli e storpiate nella mia lingua, mi fossero sussurrate nel segreto, e nel segreto, con il coraggio che a volte unisce una donna a un’altra donna, si trasformassero nelle parole incerte della forza.
Accadeva anche che la Torre pretendesse i suoi martiri, come se non le bastasse mai, come se la sua cattiva fama avesse bisogno di lustrarsi, di rinvigorirsi, di non cambiare, mai.
Quando mostrava i denti, la Torre mangiava i bambini.
Li sputava fuori dalle finestre dei piani più alti, o li nascondeva nei recessi più bui.
Li esibiva, danzatori scheletrici di balli popolari, agghindati a festa e ammaestrati al sorriso, o li segregava, obliati alla vista, al pensiero e all’obbligo scolastico.
Quando le lacrime delle donne e degli anziani avevano lavato l’infamia, quando lo sguardo degli uomini aveva abbassato con mano aperta, come una carezza, gli occhi sul volto del corpicino ritrovato, le persone riprendevano a respirare, tutte insieme, così forte da asciugare le ferite e blandirla, la Torre, che allora si acquietava, lasciando che a mostrarsi fossero i suoi tesori.
Conservava preziosi, la Torre.
Correnti sotterranee di creatività diffusa, saperi, talenti, curiosità.
Racconti. Moltissimi racconti di tante vite diverse che, nella mia esperienza, da narrazione divennero materia, concretezza di oggetti da toccare, proteggere, spostare, quando dovemmo svuotarla, la Torre, e accompagnare altrove tutti i suoi abitanti.
Non dipendeva dalla volontà dei residenti, dalla stabilità della struttura, da niente che avesse visto la luce all’interno dell’edificio.
Fu deciso nei palazzi, quelli statici e protetti del potere.
Dovemmo tutti imparare ad ammettere che davvero lei sarebbe rimasta e noi no: gli abitanti, io, i miei colleghi, tutte le persone che con la Torre avevano a che fare.
Nonostante tutto, lasciarla sola un po’ ci dispiaceva.
Come nell’arcano numero sedici, le vite delle persone che la abitavano ruzzolarono giù per i suoi numerosi gradini, si dispersero nei suoi anfratti, racimolarono quel che c’era e trasmigrarono altrove.
Ci furono reazioni diverse. Molti si adattarono, qualcuno contrattò, altri si affievolirono fino a scomparire. Qualcuno pianse e si disperò.
Tutti lasciarono la propria casa. Erano ben arredate, spoglie, pulitissime, disordinate, sporche, colorate o con le pareti coperte dal grigio depositato dagli anni.
Ciascuna un mondo a parte, lo spicchio isolato di un globo frammentato in tanti pezzi la cui unità, adesso, non interessava più.
Rimase sola, la Torre.
Fu imbrigliata, ogni suo accesso blindato, imbavagliata da reti e paratie di ferro che con il tempo si sarebbero arrugginite e le avrebbero inflitto ferite.
E’ ancora lì.
Ad andarle vicino e piantarle gli occhi addosso, quello che si vede è un animale possente, imprigionato, furioso e dolente.
Le serrande delle finestre, ormai cieche, sono tutte abbassate.
Lo prevedeva la procedura: una volta svuotato, ogni appartamento doveva essere sommariamente ripulito dalle tracce di chi vi aveva abitato e reso inaccessibile alla luce, al vento, al fruscio del traffico cittadino, alle campane di mezzogiorno, al vociare dei giocatori del campo da calcio e ai rintocchi metallici del dondolio delle altalene.
La procedura prevedeva che, una volta svuotato, ogni appartamento venisse dotato di una porta blindata, massiccia, bella e inviolabile, utile a imbrigliare il pulviscolo impalpabile delle storie, rimasto sospeso in ogni stanza, e a scoraggiare le occupazioni abusive.
Adesso la Torre pare immersa nel silenzio che le si è fatto intorno, nutrito dal vuoto enorme che ancora contiene e sparge intorno a sé, isolata dal frastuono della città che pure la comprende.
Nel periodo in cui l’ho frequentata, la Torre è stata la mia piattaforma di lancio e un’àncora di salvataggio. Mi ha aiutato a conservare la mia identità quando mi sembrava di averle smarrite tutte, è stata la mia chiave d’accesso alla città, che ho imparato dapprima a conoscere guardandola dall’alto, dalla cima del tetto della Torre.
Con lo scorrere del tempo, il legame costruito con l’edificio nel suo complesso si è scomposto, lasciando germogliare rapporti minuti fondati sulla conoscenza delle persone, sulla comprensione empatica, sulla disponibilità ad ammettere senza giudizio.
La Torre mi ha insegnato a modificare la mia visione sulle “cose che siamo tutti i momenti, che capitano da tutte le parti, come meteoriti sulla terra, e che ignoriamo o subito dimentichiamo, le cose reali che nel mondo dei segni qualche volta entrano facendo un segno negativo, un meno, o meno ancora, uno scarabocchio”.
Da quel gigante di cemento armato ho imparato un sistema complesso di mondi che ha orientato la mia ricerca attraverso l’esperienza diretta, perché “abbiamo bisogno che, insieme al pensiero, passi fra noi anche qualcosa della massa sterminata di cose ignorate e taciute, cieche e mute, impensate e impensabili, che si stende fuori dal mondo dei segni”.