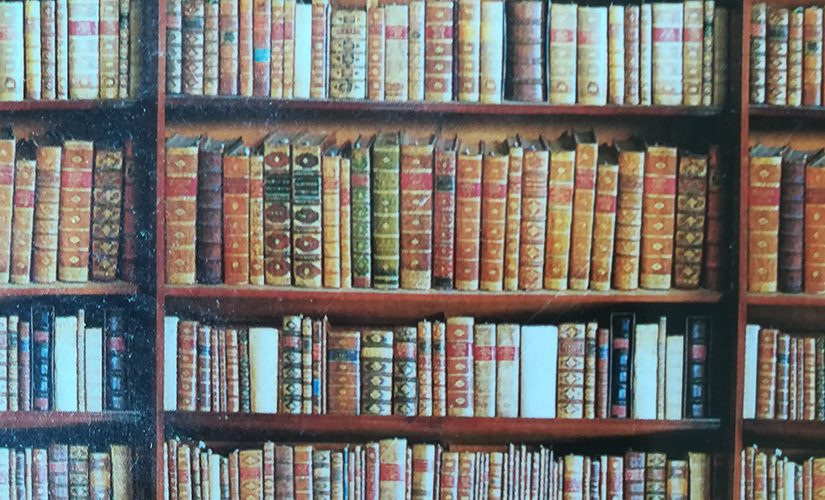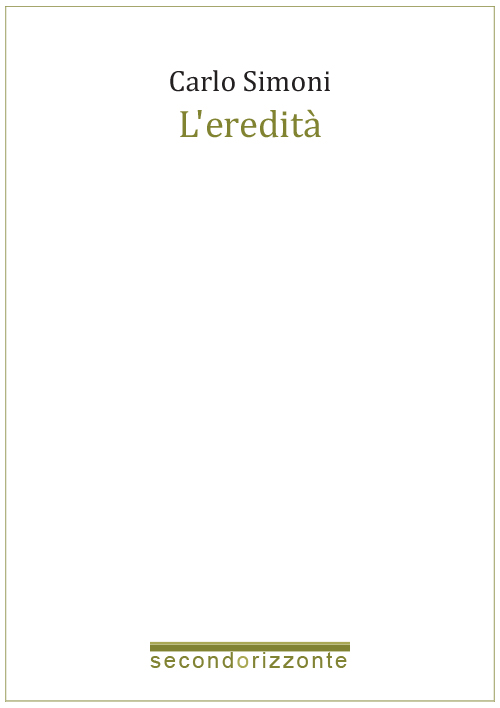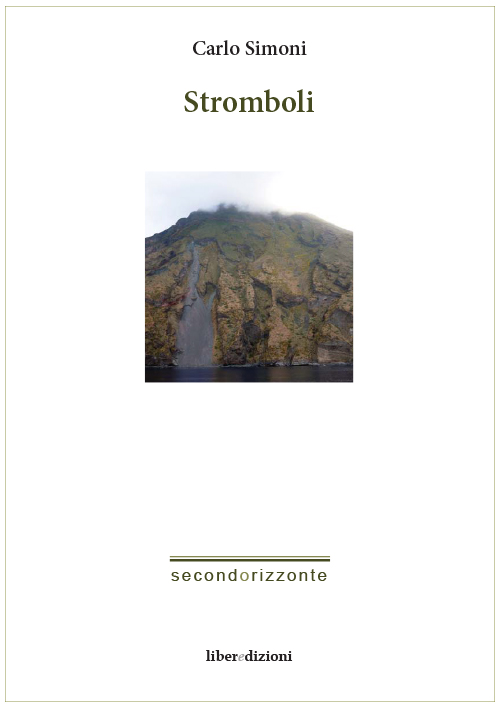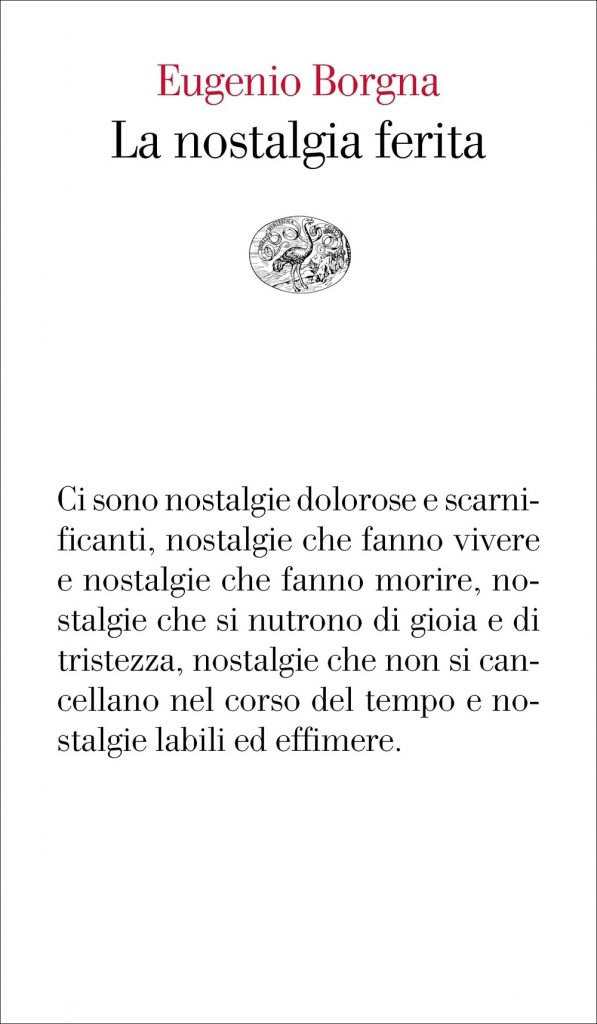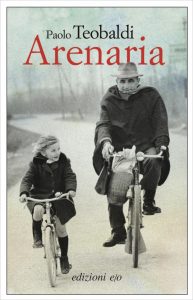Rachel Cusk, Transiti, Einaudi 2019 (pp. 196, euro 17)
Una scrittura, una narrazione all’altezza dell’epoca? Forse in questo modo si potrebbe definire l’obiettivo – e, a seconda dei giudizi, il risultato – del lavoro di Rachel Cusk, che fin dalle prime pagine ci propone giudizi precisi sul nostro tempo, appunto. “Quest’epoca di scienza e incredulità (in cui) abbiamo smarrito il senso del nostro significato”, e la vita scorre per molti “priva di storia”, in una sostanziale solitudine e nella assillante “paura di non essere desiderati”. Al punto che, a chi si aggira nel deserto della depressione, può accadere “di commuoversi fino alle lacrime di fronte alla preoccupazione per la sua salute e il suo benessere espressa dal lessico degli slogan pubblicitari e delle confezioni alimentari”. Ma nulla è più lontano dalle intenzioni dell’autrice del costruire una teoria circa il mondo in cui viviamo: quello che dice lo riporta, non lo presenta mai come l’esito del suo pensiero, ma sempre come il frutto della sua attitudine ad ascoltare gli altri, le persone fra loro diverse che la vita quotidiana le fa incontrare. In ciò proseguendo la strada intrapresa con Resoconto (in questi Appunti lo scorso 9 dicembre), ma dando ancora più spessore a un senso di irrealtà che permea l’esperienza, “come se vivessimo in una vetrina”, dove la vita “è una messa in scena, ma nello stesso tempo è reale”. Una realtà nella quale tuttavia molti degli adulti fra i quali ci muoviamo a mala pena riescono a nascondere la loro natura di bambini mai davvero del tutto cresciuti, e perfino gli studenti di un corso di scrittura creativa danno l’impressione di non “credere a sufficienza nella realtà umana per costruirci sopra delle fantasie”. Né maggiore consistenza paiono avere i matrimoni, che sembrano funzionare “come si dice che funzionino le storie, grazie alla sospensione dell’incredulità” e si reggono secondo uno dei “resoconti” raccolti, “non tanto sulla perfezione, quanto sull’elusione di determinate realtà”, come ad esempio i sentimenti del compagno. Ma non si tratta solo di esperienze coniugali: tutta la vita è dominata da una sorta di rimozione, dalla tendenza a “sottovalutare ciò che ci ha formato di più, e a replicarlo ciecamente”.

E lo scrivere? è forse il segno di un destino diverso, più consapevole, più responsabile? Pare di no: “Tutti gli scrittori sono in cerca di attenzione (…) Il fatto è che nessuno – sostiene un collega nel corso di un incontro pubblico – si è preso cura di noi quando eravamo piccoli e adesso gliela facciamo pagare. Se uno scrittore nega, per quanto lo riguarda, una componente di vendetta infantile in ciò che fa, è un bugiardo. Scrivere è solo un modo di farsi giustizia con le proprie mani”.
Ma lei, l’autrice, in proposito come la pensa? O meglio: come la pensa la protagonista, voce narrante del romanzo (del tutto somigliante all’autrice stessa, si giurerebbe comunque)? Lo dice, con chiarezza: ritiene un bene “il fatto che ogni lettore si avvicina al tuo libro come un estraneo che devi convincere a restare”, persuasa com’è della necessità di un “fondamentale anonimato del lavoro di scrittura”. Ed è un impegno mantenuto, questo: il personaggio di cui meno sappiamo, alla fine, è proprio lei, la narratrice, anche se il suo sguardo è pagina dopo pagina divenuto il nostro. Uno sguardo distaccato abbastanza per riportare con scrupolo le storie udite, ma partecipe in misura tale da permetterle di far di quelle storie l’occasione di riflessioni, di interventi in prima persona sommessi quanto penetranti, che solo il contatto stabilito con l’estraneo del momento pare aver reso possibili.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.