“La vita cresce dalle parole, la morte dimora nel silenzio. Per questo dobbiamo continuare a scrivere, a raccontare, a mormorare versi di poesie e imprecazioni e così tenere lontana la morte, per un po’.”
(Jón Kalman Stefànsson)
“La vita cresce dalle parole, la morte dimora nel silenzio. Per questo dobbiamo continuare a scrivere, a raccontare, a mormorare versi di poesie e imprecazioni e così tenere lontana la morte, per un po’.”
(Jón Kalman Stefànsson)
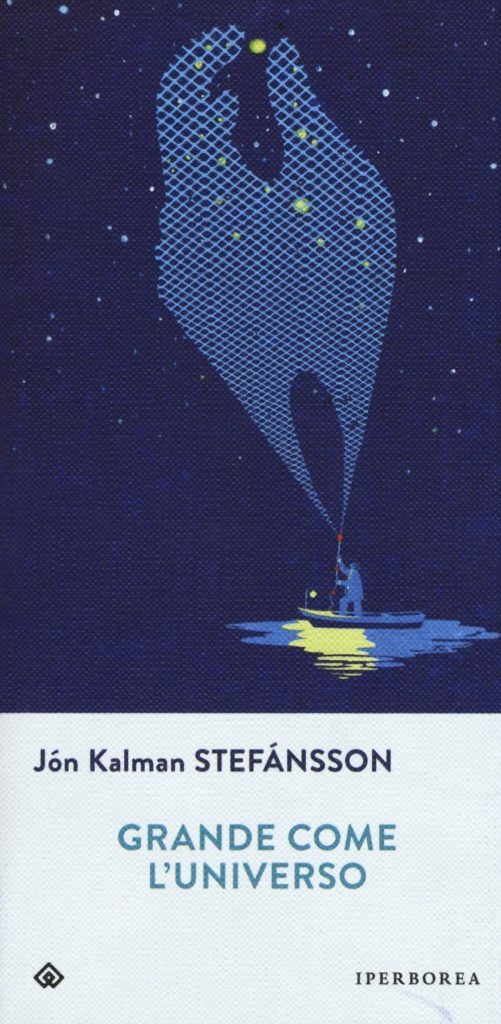
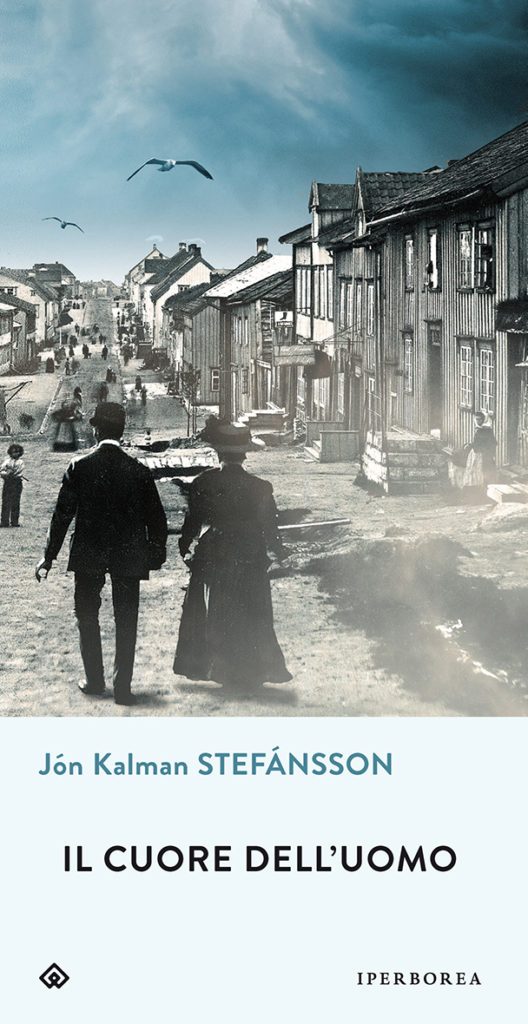
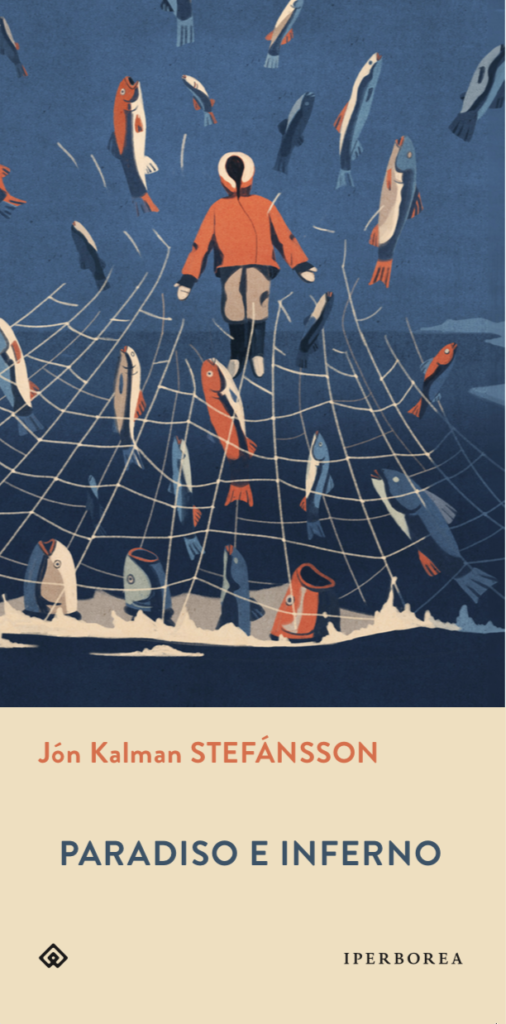
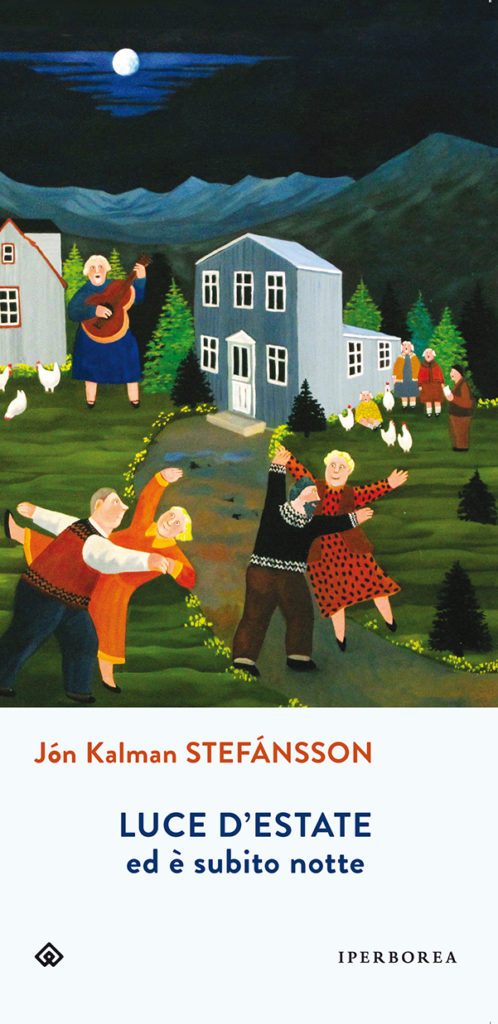
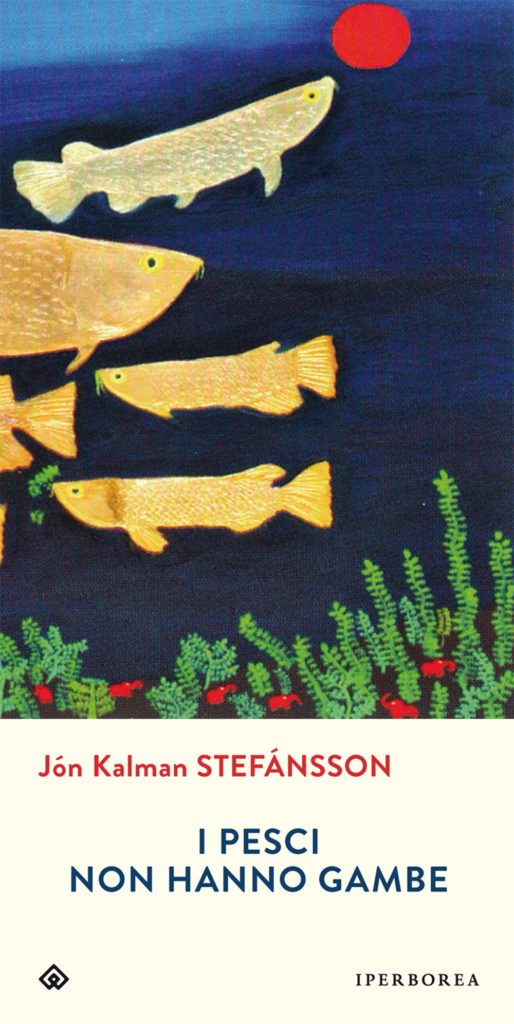

Jón Kalman Stefànsson, Luce d’estate ed è subito notte, Paradiso e inferno, La tristezza degli angeli, Il cuore dell’uomo, I pesci non hanno gambe, Grande come l’universo (Iperborea 2011-2016)
Racconta di donne e uomini comuni, donne che guardano il mare in attesa dei loro uomini, pescatori, e di villaggi sperduti fra ghiacci e nevi, “agli estremi confini del mondo”, in quel “paese inospitale”, in quella “grande isola solitaria” che è l’Islanda.
Eppure, lo sentiamo fin dalle prime pagine: parla anche di noi, Jón Kalman Stefànsson, perché sa, e non smette di dircelo, che le cose della vita, quelle che davvero contano, non sono poi molte e soprattutto non cambiano. Non che la storia non conti – “non siamo indipendenti da ciò che ci circonda e da coloro che in realtà controllano tutto: le forze della finanza, gli interessi delle società, l’incantesimo meraviglioso del capitalismo” – ma alla fin fine le questioni sono quelle: la vita e la morte, così vicine fra loro; la domanda insopprimibile di un senso dell’esistenza, che il “pantano della quotidianità” offusca ma non può cancellare; lo spazio delle donne in un mondo in cui la verità è maschile. E la solitudine, che “è come un uccello che torna sempre a posarsi sul cuore”; il silenzio che erige muri fra padre e figlio, fra marito e moglie; una Natura – non solo l’ambiente, ma anche il corpo, che di colpo invecchia – estranea e impassibile, spesso ostile.
Può accadere, leggendo i romanzi di Stefànsson, di veder poco a poco delinearsi un volto che ci è familiare, quello di Leopardi, e non è solo l’ovvio ricordo dell’Islandese delle Operette morali a richiamarlo, ma anche lo sguardo che lo scrittore posa sugli animali che “non pensano alla morte” perché “credono che la vita sia eterna” e non sono afflitti, come gli uomini, dal sentimento della caducità (“chi piange a un funerale, piange nondimeno la propria morte e quella del mondo, perché tutto muore e alla fine non resta niente”), non soffrono di quell’infelicità che solo la prerogativa dell’essere umano di “illudere se stessi” può alleviare. Ma d’altra parte “chi non sfrutta le proprie capacità non potrà mai essere felice, piuttosto vivrà nell’ombra della persona che non è mai diventato ma sarebbe potuto diventare”: seguire il proprio desiderio dunque, e affidarsi a quella che è la “sostanza della vita”, non temere il rischio dell’amore, “l’unica risposta verosimile alla morte”. Sono pieni di storie d’amore e disamore, di abbracci di corpi e di separazioni laceranti questi romanzi, trascinati da una forza vitale che non risolve mai il fondo di angoscia che abita l’esistenza ma ha guadagnato la consapevolezza che pessimismo e ottimismo non sono poli opposti e irriducibili ma sfumature cangianti di uno stesso sguardo, modi di stare nel mondo che la vita combina incessantemente.

La suggestione e la densità di questi temi non raggiungerebbero il lettore se il racconto non lasciasse continuamente spazio a lampi di riflessione, e la scrittura narrativa non assumesse a volte il passo dell’epica, o ancora più spesso s’aprisse a momenti di liricità che testimoniano della vocazione dello scrittore, autore di raccolte di poesie prima che di romanzi. Da sempre convinto, comunque, che “il potere e la ricchezza non si accompagnano mai alla letteratura e forse è per questo che rimane così incorrotta, a volte l’unica resistenza degna di questo nome”. Anche di fronte al disgregarsi di quella socialità che abbiamo trovato nei romanzi ambientati in un’Islanda di fine ’800, con la trilogia aperta da Paradiso e inferno, e appare invece solo un ricordo nella saga familiare che – con Grande come l’universo – giunge agli anni recenti della crisi, quando “questa nazione che in pochissimo tempo era diventata un modello, un esempio per l’Europa, poco dopo si è rivelata campionessa dello scatto ma un totale fallimento nel fondo”, e nelle piccole comunità in cui, un tempo, “la vita diventa(va) più grande”, manca l’aria, al punto che “chi ama l’Islanda a volte deve allontanarsene”.
Oggi tanto più occorre allora non dimenticare che “la vita cresce dalle parole, la morte dimora nel silenzio. Per questo dobbiamo continuare a scrivere, a raccontare, a mormorare versi di poesie e imprecazioni e così tenere lontana la morte, per un po’.”
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora
Dal Giornale di Brescia del 24 febbraio 2018.
Clicca sull’immagine per visualizzare l’articolo.
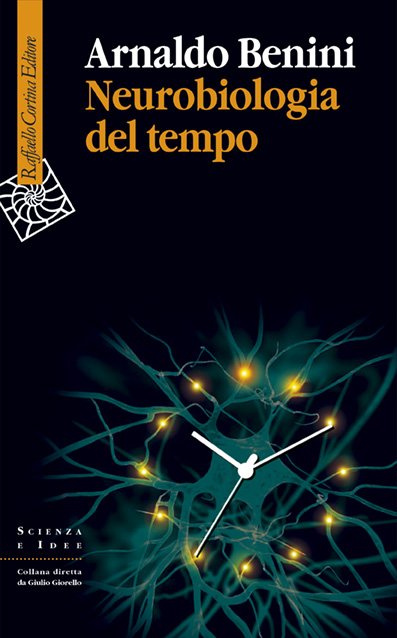
Arnaldo Benini, Neurobiologia del tempo, Raffaello Cortina Editore 2017

Carlo Rovelli, L’ordine del tempo, Adelphi 2017
“Che cos’è dunque il tempo? Se nessuno m’interroga, lo so; se volessi spiegarlo a chi m’interroga, non lo so”.
Il dilemma di Agostino non trova soluzione nei libri degli scienziati che pure si interrogano sul tempo. È se mai la domanda a cambiare: non che cos’è il tempo? ma: esiste, il tempo?
Il neurobiologo ne è convinto, pur ammettendo la dimensione soggettiva del tempo: “ Il tempo non è un attributo dell’Universo che noi percepiamo, ma è in noi”, afferma Benini, fin qui nella scia di Agostino si potrebbe pensare. Senonché, prosegue, “ le neuroscienze lo hanno localizzato nel cervello”, e qui addio Agostino e il suo tempo come estensione dell’anima.
Quel che conta, comunque – sempre secondo il neurobiologo – è che, pur essendo prodotto della manipolazione continua che il cervello ne fa, il tempo “è reale”, non se ne puo’ dubitare: “dal momento che i sistemi nervosi che lo realizzano, nell’uomo e in molte specie animali, sono componenti dell’Universo”, “il tempo è una caratteristica reale dell’Universo”.
Ma ci sono i fisici per i quali, “da Einstein in poi, il tempo è un’illusione ostinata”. È con Rovelli in primo luogo che polemizza Benini, e lo cita esplicitamente: “Il tempo non esiste. È necessario imparare a pensare il mondo in termini non temporali, sebbene questo risulti difficile sul piano dell’intuizione”. Ma è possibile prescindere dall’intuizione? Dalla concreta esperienza vissuta? Il fisico sostiene appunto sia una necessità, se si vuol capire il mondo: “la distinzione fra passato, presente e futuro non è altro che una persistente cocciuta illusione”, affermava già nella sesta delle sue Sette brevi lezioni sulla fisica (Adelphi 2014) lo stesso Rovelli, per ribadire la convinzione, lasciandosi alle spalle anche Einstein, nel libro del 2017: “per descrivere il mondo non serve la variabile tempo”, nelle equazioni delle fisica attuale non compare il tempo. Ma questo, avverte Rovelli, non autorizza a sposare la tesi dei filosofi cosiddetti eternalisti – e viene in mente un celebrato pensatore bresciano – i quali sostengono che “fluire e cambiamento siano illusori”: all’opposto, occorre pensare che “la migliore grammatica per pensare il mondo sia quella del cambiamento, non quella della permanenza. Dell’accadere, non dell’essere”. Eraclito versus Parmenide, insomma (c’è chi, nota di passaggio Rovelli, ha pensato “che sia per sfuggire all’inquietudine che ci causa il tempo che Parmenide ha voluto negarne la realtà”). E dunque – ammette il fisico – “se per tempo intendiamo null’altro che l’accadere, allora ogni cosa è tempo: esiste solo ciò che è nel tempo”.
E qui ci ritroviamo, o almeno sentono di esser tornati a casa quanti non riescono a rinunciare a pensare che “la nostra vita si svolge, nasce e muore, nel tempo, e nulla si può capire della vita se non si abbiano presenti le esperienze del tempo che si snodano in essa senza fine” (Eugenio Borgna, Il tempo e la vita, Feltrinelli 2015). Il tempo come carattere inscindibile della vita dunque, e il fisico sembra convenirne, in fondo: fatti salvi gli assunti della fisica, il tempo “è la sorgente della nostra identità. E del nostro dolore”. Ecco il punto: adeguarsi a pensare che il tempo non esiste ha il sentore di una rimozione, perché “il tempo è il nostro supplizio. L’uomo cerca solo di sfuggirvi, cioè cerca di sfuggire al passato e al futuro sprofondando nel presente, oppure di fabbricarsi un passato e un futuro a modo suo” (Simone Weil, Quaderni IV, Adelphi 1993).

Forse – ma sono gli scrittori, i letterati a dircelo – conviene credere che il tempo può smettere di perseguitarci se ci convinciamo che il tempo siamo noi, il suo trascorrere è il nostro stesso esistere. Si tratta allora, per ognuno di noi, di farcene una ragione: “per fermarmi nel tempo devo muovermi col tempo” (Italo Calvino, Ti con zero), perché “il tempo è la sostanza di cui son fatto. Il tempo è un fiume che mi trascina, ma io sono il fiume; è una tigre che mi sbrana, ma io sono la tigre; è un fuoco che mi divora, ma io sono il fuoco.” (Jorge Luis Borges, Nuova confutazione del tempo, in Altre inquisizioni).
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora
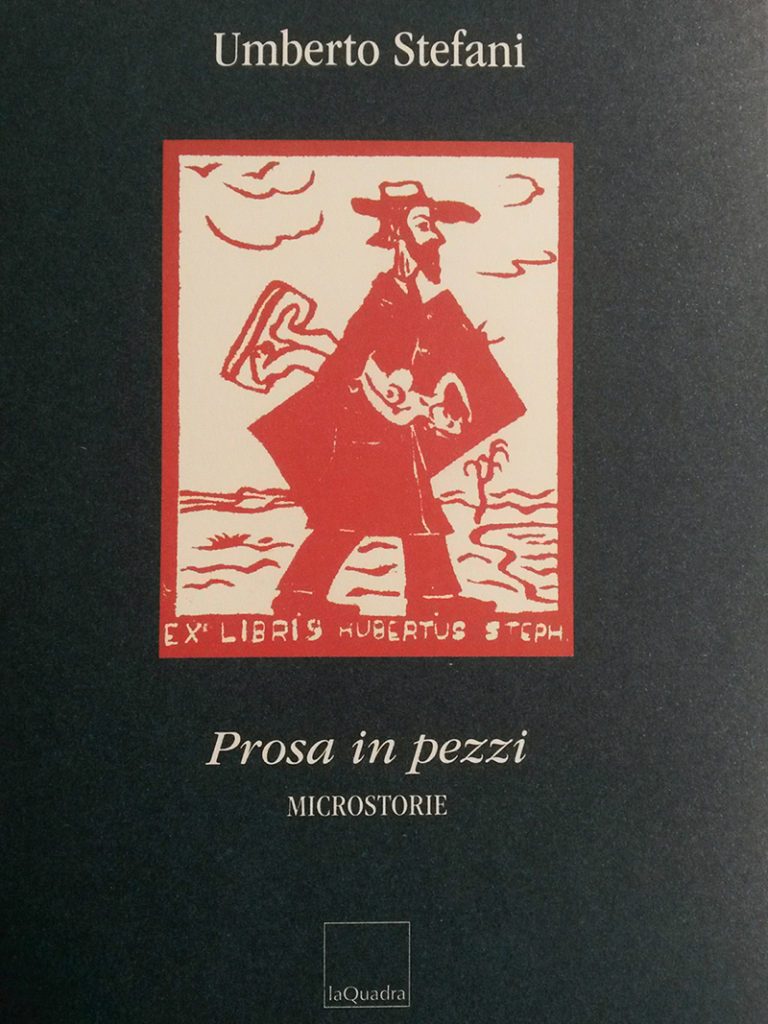
Umberto Stefani, Prosa in pezzi. Microstorie, La Quadra 2017 (pp. 148, euro 15)
Il racconto gode di possibilità infinite, anche della possibilità di configurarsi come “prosa in pezzi”.
Il romanzo invece, nella sua organica continuità, rischia di restare gravato da un approccio ottocentesco, dissonante con le trasformazioni radicali che la nostra vita, il nostro mondo hanno subito.
Questa nota, che l’autore premette ai suoi racconti, torna alla mente a lettura ultimata, ma l’impressione è – nonostante la frammentarietà del discorso – di aver letto un’autobiografia per racconti e, insieme, un’autobiografia preterintenzionale: nonostante Umberto Stefani abbia scritto questi pezzi in un arco di tempo che va dal 1983 alla fine del 2017, è la loro unità a imporsi, la loro sequenzialità: un senso complessivo che emerge solo a cose fatte, come avviene – qualcuno ha detto – per la vita, che lascia trasparire la sua trama solo quando la si è vissuta, e sono allora gli altri a potervela leggere. Ma attenzione, il libro si chiude con un’affermazione inequivocabile: “Ora so di avere cominciato a vivere”. Parole che non smettono di risuonare ora che Umberto ci ha lasciato.
Tanto più leggendoli ora, balza in primo piano la lucidità con la quale l’autore ha raccolto i pezzi che aveva scritto. Lucidità derivante dalla consapevolezza che proprio chi scrive di sé è “costretto a tradire intenzionalmente la veridicità dei fatti”: al di là dei propositi di attenersi alla più assoluta sincerità con cui iniziano autobiografie che hanno creato il genere, il racconto traccia poi la sua strada, non sempre coincidente con quella percorsa davvero. Così in questo libro: non perché l’autore ci racconta frottole, ma perché seleziona – drasticamente: proponendoci poco più di cento pagine – ciò che ha vissuto, come l’ha vissuto, non scegliendo momenti eccezionali, da proporre come memorabili per la loro esemplarità, ma episodi e occasioni in cui sente essersi manifestata la pluralità degli Io che lo hanno abitato, che abitano ognuno di noi, i personaggi di cui siamo fatti, che mettono in scena le attitudini, i desideri che pur senza continuità ci hanno guidato e ci guidano.
Ecco allora il personaggio che guarda: l’eccentricità rivelatrice della vitalità visionaria di un vecchio; la singolarità irripetibile, non omologata e non omologabile, di una commessa di negozio straniera;
oppure le rondini, recuperando, in questo caso soprattutto, lo sguardo penetrante e insieme fantasioso del Palomar calviniano. Il personaggio che guarda non ha dismesso solo i suoi pregiudizi ma anche ogni volontà di spiegare: quello che gli sta a cuore è vedere ciò che la quotidianità piatta, la familiarità che acceca, il modo di pensare diffuso non lasciano distinguere. Non si tratta della rivelazione di significati nascosti tuttavia, ma della possibilità stessa di cogliere significati altri, ulteriori, in ciò che a prima vista sembra del tutto usuale.
Diverso, ma a suo modo legato al personaggio che guarda è quello che dice no, che si oppone, che oppone la propria diversità, e a Santo Domingo – che è come dire: a quel paese – ci manda l’avvocato avido e imbroglione che lo perseguitava e rischiava di costringerlo a una resa avvilente, ma soprattutto sa tenere invita quell’isola di resistenza che può essere (ed è stata) la piccola libreria che nei piccoli libri di piccoli editori sapeva vedere grandi autori: era la libreria del libraio lettore, l’Ulisse di Umberto Stefani, che se non poteva portarli dov’era lui, dov’eravamo noi, aveva il coraggio di andarli a trovare i suoi autori, il coraggio di non temere la delusione sempre possibile dell’incontro: andare da loro intanto che erano vivi, come Bohumil Hrabal nella sua birreria di Praga.
C’è anche il personaggio che non si limita a guardare e a defilarsi , ma passare dalle parole alle cose: sembra, perché i libri che custodisce nella sua casa sono essi stesse cose, con la loro inconfondibile materialità, e le cose via via raccolte – oggetti, immagini – e conservate sugli stessi scaffali su cui sono i libri, non sono a loro volta solo cose, perché sono “cariche di narrazione”: si badi, non narrazione di imprese compiute, ma di momenti di essere; testimoni di piccole epifanie che hanno saputo dare consistenza al presente intanto che era ancora tale, intanto non si era ancora fatto passato. E dunque non sono documenti di una propria eccezionalità da certificare, ma della propria umana unicità: da vivere, da continuare a vivere, appunto, grazie anche a quelle cose che si tengono lì, fra i libri.

Infine, incontriamo in queste pagine il personaggio che, cercando la solitudine non troppo rumorosa nella quale aveva sperimentato – nella prima giovinezza – la propria capacità di pensare, di meditare, come faceva Walser nelle sue passeggiate, adesso, ad anni di distanza, la vuole ritrovare, adesso che non vive più solo ma con una donna, e un bambino, e nel mentre vive lo smacco di non averlo ritrovato, quell’Io che bastava a stesso – o così aveva lasciato credere – scopre che non c’è Io che non sia fatto dell’altro. Sia questo altro la donna con cui si condivide la vita, sia il padre che non c’è più e continua ad esserci, come tutti i padri. Il padre che non sapeva riconoscere i proprio fantasmi ma avrebbe voluto aiutare lui, il figlio, a liberarsi dei suoi. Solo adesso lo si capisce, adesso che lui è morto. Solo adesso ci si può chiede re “perché è così difficile disfarsi della presunzione di credere che siamo noi gli artefici unici della nostra condizione”. Non è, questa, una domanda di quelle che trovano risposta, ma il solo porsela – ci aiuta a capire Umberto – può donare la sensazione di aver finalmente cominciato a vivere. Non a vivere nel senso di saper stare al mondo, come si dice, avendo finalmente dismesso la propria diversità, quella che – anche se è stata fonte di sconfitte e infelicità – ci ha permesso di avere un’idea di chi eravamo: a vivere nel senso di “quel viaggiare alla ricerca di qualcosa di cui non si sappia il segno” ma che si sa coincidere con “la conoscenza di sé e l’incontro con l’altro”; quel vivere che non teme di concentrarsi nello “sguardo lancinante sulla propria nascita e la magica possibilità di morire a se stessi per rinascere continuamente”.
“La libreria è stato il luogo della mia migliore sincerità” diceva Umberto aprendo il suo Dalla Mitteleuropa, pubblicato vent’anni fa: “Da allora – aggiungeva – qualcos’altro ho scritto, con l’unica motivazione della scrittura stessa. Di ciò a suo tempo”, concludeva.
Quel tempo è arrivato, alla fine: il tempo per dire, come leggiamo in uno dei racconti, che “la sincerità – quella con se stessi, in primo luogo, credo si possa aggiungere – è condizione prima i tutti i sentimenti”.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora
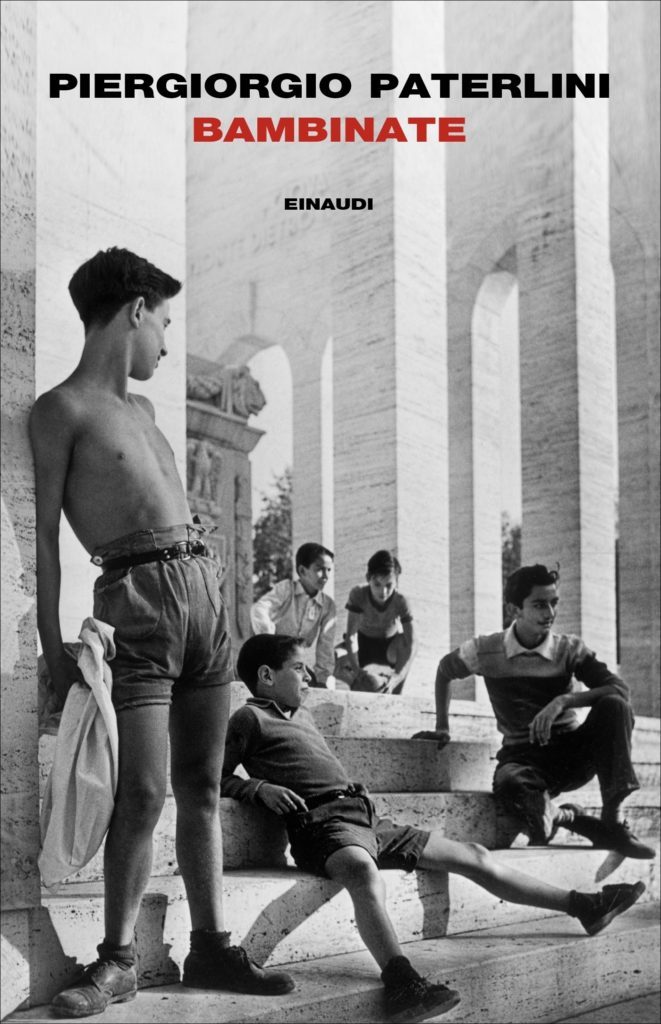
Piergiorgio Paterlini, Bambinate, Einaudi 2017 (pp. 140, euro 16,50)
Una storia di ordinario bullismo? Bambinate – che l’autore presenterà in libreria venerdì prossimo – è qualcosa di più, e di diverso.
Non solo perché la vicenda si svolge in un’epoca in cui il vocabolo bulli esisteva ma i giornali non avevano ancora diffuso il suo derivato, ma anche perché la persecuzione da parte dei compagni delle elementari ai danni del più debole fra loro pone il problema non a caso richiamato dalle citazioni che aprono le parti di cui si compone il romanzo, a partire da quella di S. Agostino che afferma, molto prima di Freud, che l'”innocenza infantile” non esiste. Ma qui non si tratta solo di smentita del mito di quell’innocenza: la storia propone un esempio di cattiveria gratuita, di sadismo di branco. Partendo da quello, il romanzo si sviluppa attorno alla “cicatrice indelebile” che il fatto lascia nell’anima del protagonista. Testimone dell’episodio, non partecipe attivo ma di fatto, nella sua inazione, complice, e per questo gravato da un senso di colpa che a lui, a differenza di quel che accade al più crudele dei compagni, il capobanda, non permette di dimenticare, tanto più di dimenticare di aver dimenticato: “odiavo soprattutto Ermes che ci aveva trascinati in quella ferocia e odiavo me stesso per non essermi ribellato” a quella “vigliaccheria” che “ormai mi aveva sporcato per sempre.”

Veder trasparire nello sguardo del proprio figlioletto lo stesso sguardo, incredulo prima che terrorizzato, della vittima di quel rito persecutorio rende impossibile ogni rimozione. E l’invito a partecipare a una cena di classe, e quindi a tornare al paese dopo cinquant’anni, suona come un richiamo ineludibile ad una resa dei conti troppo a lungo rimandata, e che si risolverà in un modo drastico, imprevedibile.
Non ci sono scorciatoie: né quella del pessimismo antropologico (il male è innato negli uomini, fin dalla più tenera età: che ci vuoi fare?) né quella del sociologismo facile (è la cattiveria della società che si esprime nei comportamenti devianti dei ragazzi). Le scelte, comprese quelle che non si è saputo fare, anche se risalgono all’infanzia impongono un prezzo. Il protagonista di Bambinate decide di pagarlo.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora

Giorgio Montefoschi, Il corpo, Mondadori 2017 (pp. 221, euro 19)
La vita accade mentre si susseguono giorni fatti degli stessi gesti e delle stesse parole, degli stessi tragitti e degli stessi incontri.
Più che la monotonia sembrano essere la continuità, la familiarità dei volti e dei luoghi, il tratto predominante: c’è un che di rassicurante negli elenchi di vie e piazze di Roma che i personaggi percorrono. Una topografia, e una toponomastica, precise, puntigliose, come le puntuali descrizioni di quel che si beve e si mangia. Insieme, o da soli.
La vita accade al di sotto di questa continuità, ed emerge, nella sua realtà, solo quando una malattia seria interviene a turbarne il ritmo. L’imprevisto sembra tuttavia potersi riassorbire, lasciando che l’esistenza riprenda a scorrere come sempre. L’infarto, a Giovanni – avvocato sessantenne, ammogliato, agiato – non cambia la vita. Eppure scava, impercettibilmente: gli sarebbe cresciuto dentro l’innamoramento per la compagna del fratello se non gli fosse capitato quell’accidente?
È Serena, la moglie, ad avvertire i cambiamenti che covano, e a dirne – con un tono che appare coerente al nome che porta – al marito, il quale invece va avanti, adeguandosi al trantran quotidiano come alla fatalità – così sembra volerla interpretare – di un amore che ribalta la sua famiglia e quella del fratello.

È tutta qui la storia. Un adulterio. Come in tanti romanzi. Ma più della vicenda, è lo sguardo del narratore a farci proseguire nella lettura: non giudicante, descrittivo, divagante spesso, e pure capace di far risaltare il vuoto che si annida, e cresce, nelle vite. Non enunciandolo, ma rendendolo percepibile nel fare di personaggi che sembrano sfuggire a se stessi, che sanno e non vogliono sapere, che agiscono come non sapessero.
Non c’è angoscia, ma un rattenuto – e non sappiamo fino a che punto consapevole – senso di liberazione nella constatazione che alla fine il protagonista – dopo un altro malore, in convalescenza nella località di montagna da sempre frequentata – non può non fare: “Si sta bene qui al Rid, mormora Giovanni. Ma lo sa che il tempo è finito”.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora

Trascrizione dell’intervento pronunciato nel corso della XVI edizione di Dies fasti, giornate organizzate dagli studenti del Liceo Calini di Brescia il 15 e 16 novembre 2017. Tema prescelto quest’anno, “Il domani”.
Mi trovo a parlare di domani a chi ha cinquant’anni meno di me, e immagino che cinquant’anni vi sembrino un periodo lunghissimo: un’epoca storica più che un arco di vita. Si tratta in effetti di un intervallo di tempo in cui sono successe molte cose, il mondo è cambiato, e sta cambiando (in modo ancor più radicale, probabilmente, di come è avvenuto nella prima e nella seconda rivoluzione industriale).
Non è facile pensare che cinquant’anni siano un’entità temporale che possa riguardare se stessi, se si ha meno di vent’anni. Eppure, posso dire che non è molto diverso neanche per me che ne ho quasi settanta: anche a me pare irreale che sia passato mezzo secolo da quando avevo la vostra età (e anche da quando, di poco superati i vent’anni, da precario, per un paio d’anni ho insegnato in questa scuola storia e filosofia.
Dal Corriere della Sera (Brescia) del 10 gennaio 2018
«Io, bambino, accolto nel gruppo dei suonatori. Io, piccolo, in mezzo a loro, avvolto nel suono del bassetto, delle chitarre e dei violini. Ero troppo piccolo per suonare, e sentivo di essere privilegiato rispetto gli altri bambini nel poter stare lì, ai piedi di mio papà che suonava. Il violino».
Nel primo ricordo che Daniele Richiedei ha del Carnevale del suo paese, Bagolino, a occupare la scena è la musica, l’esperienza dell’essere immersi nella musica: un po’ come accade a chi, come lui oggi, suona in complessi musicali e in orchestre.
Continua a leggere Figure e paesaggi / Da «sonadùr» al Carnevale a concertista

David Szalay, Tutto quello che è un uomo, Adelphi 2017 (pp. 402, euro 22)
Che siano giovani turisti o maturi professionisti, uomini affermati o pensionati più o meno agiati, i protagonisti delle nove storie che fanno questo libro non hanno comunque, o non vogliono, un luogo stabile nel quale stare.
Una condizione, la loro – non esclusi quelli che pure si trovano dalla parte dei “vincenti” – che appare metafora di una pervicace incapacità di stare nella vita. Che cerchino rifugio nella cultura, nel successo professionale, nel potere e nella ricchezza, o che vivano invece in posizioni marginali – per età, vicenda biografica, scelta deliberata – appaiono tutti afflitti da una sorta di inettitudine alla vita, e all’amore inteso come incontro che dia significato all’esistenza. Il loro desiderio è il desiderio maschile per vie diverse vocato al fallimento e, sempre preoccupato di sfuggire a un vero coinvolgimento, alla frustrazione. Ma è la loro stessa vita, più in generale, a rivelarsi priva di senso quando all’improvviso si rendono possibili “passeggere immersioni nella trama dell’esistenza”, sporadici, folgoranti ma effimeri momenti di lucidità. Insensata o comunque sfuggente sempre, o sprecata addirittura, secondo l’età: vicina eppure come al di là di un vetro resistente, e sporco, reso opaco da giorni e anni passati in una non innocente e ostinata inconsapevolezza (“non capiamo la vita mentre accade”) e, ad un tempo, in un ininterrotto sforzo di fuggirne, come non fosse, quella che si è vissuta, che si vive, la vita vera. Hanno un bel dirsi, questi uomini, che “è tutto qui. Non c’è nient’altro”, e “la vita non è un gioco”: è fatta delle cose che succedono qui, adesso”, e di quel che si sta vedendo, e può donare, sia pure fuggevolmente, il “piacere di percepire le cose”. Non basta: anche quando la loro corsa lascia ormai intravedere l’approdo per tutti inevitabile non riescono a credere alla propria morte: scoprire di essere invecchiati è uno choc, fonte di rimpianto bruciante, di depressione, di un’esperienza vertiginosa di isolamento.
Dopo aver stentato, renitenti, a crescere, a diventare adulti, subito si ritrovano vecchi. E soli.
Affrontare la realtà del trascorrere del tempo e della caducità può tutt’al più suscitare il pensiero che proprio la transitorietà, di tutti e di tutto, l’impermanenza, sia l’unica realtà eterna. Non fosse che, anche questa intuizione, all’ultimo dei personaggi che incontriamo, il settantatreenne protagonista del nono racconto, non appare in fin dei conti niente di più che “qualcosa con cui alleviare l’incubo dell’invecchiamento e della morte”. Un espediente, dispensatore di un certo conforto magari, ma incapace di nascondere, in fondo, la propria strumentalità.
Non viene esplicitato un nesso causale fra la dimensione esistenziale dei personaggi e il tramonto di un’Europa che, al di là della diversità dei luoghi in cui le storie sono ambientate, lascia trasparire l’inconsistenza di un esteso e pervasivo non luogo, ma alla fine si ha la sensazione che le storie che abbiamo letto – come fossero le varianti possibili ma sostanzialmente conseguenti dell’itinerario di un solo uomo – non potrebbero collocarsi che in una situazione qual è quella contemporanea del continente in cui viviamo.

Sensazione, niente di più. Perché Szalay non inclina all’argomentazione. Ha l’aria di raccontare quel che ha visto, che vede. Con una scrittura che dimostra di sapere il limite delle parole, e dunque rifugge da sottolineature e tentazioni di spiegazione, e per dire il di più per cui le parole appunto non basterebbero ricorre piuttosto, pur senza mai eccedere, ad espedienti visivi (a capo senza punteggiatura e disallineati, o addirittura pagine bianche).
Una scrittura facile verrebbe da dire, perché non sembra il frutto di successive reiterate limature e sottrazioni. Si direbbe nata così: da uno sguardo possibile solo da una posizione che sembra collocarsi al di là del disincanto, o della disperazione. Uno sguardo che ci si stupisce di dover attribuire a un quarantenne.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora

Eshkol Nevo, Tre piani, Neri Pozza 2017 (pp. 255, euro 17)
Tre piani, tre racconti. Uno per ciascuna delle famiglie che abitano la palazzina. Ma Perec e il condominio del suo La vita, istruzioni per l’uso non c’entra.
Niente giochi combinatori qui, ma tre storie che si tengono fra loro. Grazie innanzitutto al fatto che il loro protagonista le racconta a un tu di cui non sentiamo la voce, perché i suoi interventi vengono tralasciati, o perché è il destinatario di una lettera che non avrà risposta, o perché è morto e la moglie gli si rivolge attraverso una segreteria telefonica che sa bene resterà per forza di cose inascoltata. Sta di fatto che – un po’ questo espediente, un po’ la lingua di tutti i giorni cui lo scrittore si attiene – chi legge si lascia prendere e passa di racconto in racconto ritrovando, in vicende diverse, il contesto e il tema che stanno a cuore all’autore: il primo è quello della famiglia, del rapporto fra padre e figli; il secondo è rappresentato dal non detto che è presente in tutte le relazioni. Padri che non sono o si sospettano inadeguati, o incapaci di entrare in rapporto col figlio; segreti che resistono per decenni in un mondo, come il nostro, nel quale “non esistono più segreti” e “tutto è scoperto, fotografato, condiviso, tutto trapela, passa, è su Facebook, tutto è sbandierato, spudorato, niente più è misterioso al tuo moroso”. Ma non solo le ombre che hanno segnato la vita delle famiglie compaiono in questi racconti. Ce ne sono anche nell’intimo di ciascuno, ed è quando il personaggio se ne accorge che il racconto prende quota: quando l’inquilino del primo piano si trova a dover ammettere che anche lui, come tutti, cova dentro di sé un “piccolo criminale”, o l’inquilina del secondo sente sbriciolarsi “la fiducia nel fatto che un se stessi esiste, che esiste qualcosa di stabile in mezzo a tutto questo casino dell’essere una persona”, mentre la vedova del terzo non ha remore nel riconoscere che “il più grande segreto che possiamo nascondere al mondo” altro non è che quello della “nostra vulnerabilità”. E non si tratta né di giudicare né di essere giudicati, perché – occorre ammetterlo, ed esserne consapevoli – “la nostra anima non procede in avanti, solo in cerchi. E ci condanna a cadere e ricadere nelle stesse buche”.

Non c’è che un rimedio, allora: raccontare, raccontare tutto a qualcuno di cui ci si può fidare perché sai che ti vuole bene e ti prende per quello che sei: “se non c’è nessuno ad ascoltare, allora non c’è nemmeno la storia”. “L’importante è parlare con qualcuno. Altrimenti, tutti soli non sappiamo nemmeno a che piano ci troviamo, siamo condannati a brancolare disperati nel buio, nell’atrio, in cerca del pulsante della luce.”
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora

François Jullien, Una seconda vita. Come cominciare a esistere di nuovo, Feltrinelli 2017 (pp. 125, euro 14)
“A fine dell’anno, si vorrebbe credere al Nuovo anno, alla possibilità di un «nuovo inizio»”, “ma sulla base dello sforzo e della volontà non si va oltre l’«auspicio».
Possiamo fissare, magari simbolicamente, la data del nuovo inizio, ma sarà tutto inutile”. Non perché esso non sia possibile, ma perché può avvenire solo se non lo si immagina come una “cesura”: non si tratta di una “partita”, non si può chiedere di rifarsi giocando la “bella”, se si tratta della vita. Si può invece immaginare la “nuova vita” come una “ripresa” di quella finora vissuta: una seconda vita dopo la prima, ma in continuità e insieme in discontinuità con essa.
Che cosa significa? come è possibile? Jullien gira attorno al concetto, a prima vista contraddittorio, ci torna e ci ritorna, e in questo modo riesce a farci intravedere la possibilità. La possibilità, niente meno, che di “dispiegare la vita in esistenza”. Non si tratta di rinnegarla, la propria vita. Si tratta di “non più riperterla ma «riprenderla»”.
Quando? Adesso, perché il vivere, il vivere davvero, l’esistere, non si può rimandare a domani, essendo che “abbiamo una sola vita”.
E riprenderla, la nostra vita? “Ritornando su di essa prendendone le distanze”. E siamo daccapo: un (ri)avvicinamento che deve essere un allontanamento… Ma ecco che l’autore – quasi si rendesse conto della nostra incertezza e d’altra parte non volesse accontentarsi di una adesione generica, di una comprensione puramente formale di quel che dice – ci viene in aiuto, insistendo, spiegando di nuovo, dipanando il discorso in nuove volute: “la seconda vita non può che essere questa vita, ma al tempo stesso deve dissociarsene”. Non sulla base di un – cercato o meno che sia – evento esterno né di una – improbabile, inevitabilmente effimera – conversione, ma a partire da una “decisione silenziosamente maturata”. Di Jullien più che di altri autori si può dire che il libri che ha scritto e scrive sono in realtà un solo libro: è lo Jullien delle Trasformazioni silenziose (Cortina 2010), quello che continuamente affiora in questo che leggiamo: i cambiamenti veri sono quelli che avvengono lentamente, sottotraccia, quasi a nostra insaputa. Così anche quello che ci può portare a una seconda vita rendendocene poco a poco chiare le “configurazioni”, le coordinate. Non che non le si possa cercare, anche in quel che si legge, ma converrà allora dedicarsi alla letteratura, ai romanzi, non alla filosofia, ai saggi (eccezion fatta per questo, è bene sottolineare…).
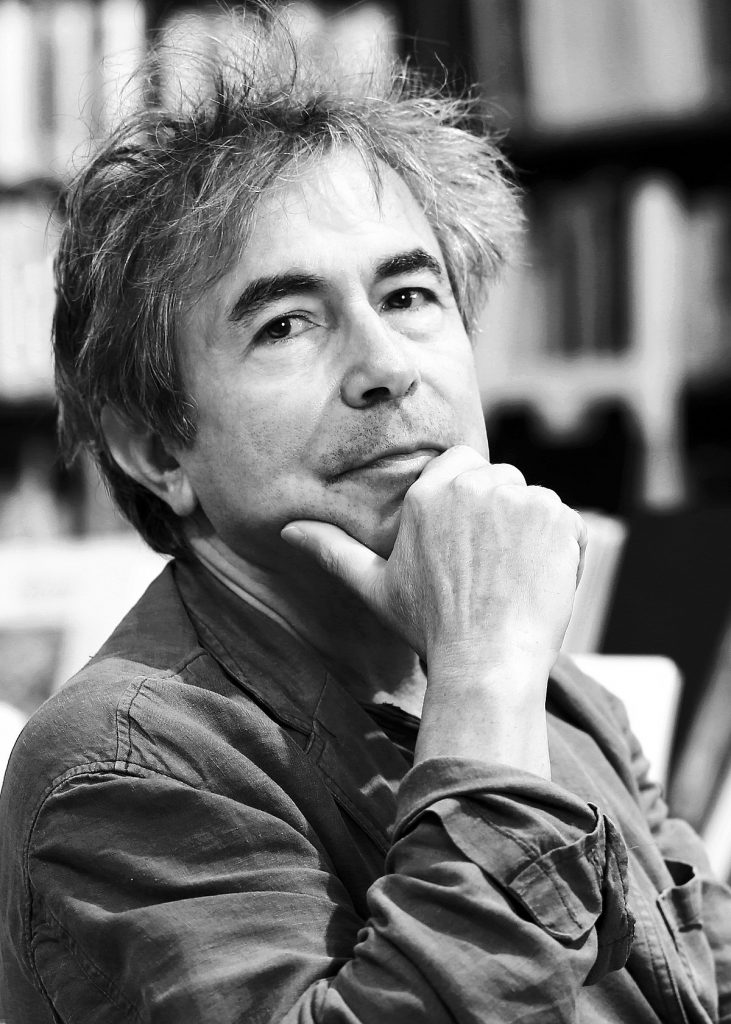
Occorre starci insomma, nella propria, unica, vita ma, anche, sottrarsi ad essa, in primo luogo da quel bisogno che ha avuto un ruolo portante nella prima vita: il bisogno del riconoscimento, anche nell’amore; il bisogno di “imporsi al mondo e stabilirvi il proprio posto”. Di questo ci si deve, ci si può sbarazzare, quando si comincia ad avvertirne il peso, a sentirlo – solo a tratti, magari – datato. Senza per questo pretendere il cambiamento qui e subito, senza immaginarsi svolte memorabili e risolutive, e senza scandalizzarsi delle ricadute nel trantran solito, mettendo in conto anzi la sua forza (e la nostra inerzia, il nostro umano bisogno di sicurezze). E tuttavia avendo ben presente che quelle che – solo retrospettivamente – consideriamo le scelte della nostra vita, le abbiamo in realtà compiute, per la parte maggiore, alla cieca. Ma non è detto che si debba continuare così, anzi: è in un secondo tempo che “qualcosa di prossimo a una scelta può emergere”. Secondo tempo, seconda vita: in italiano abbiamo solo una parola, che non distingue – come fa invece il francese, con deuxième e second – fra il secondo che sarà seguito da un terzo e il secondo che invece è soltanto il corrispettivo di un primo, ed è finita lì.
Perché è così che avviene: è solo quando si prende atto dell’unicità della propria vita – ma davvero, non in termini astratti, e non occorre essere ormai vecchi (ma certo giova non essere incatenati altri anni al lavoro in conseguenza di un incremento della media statistica della speranza di vita) – è solo quando si guarda in faccia senza tremare la fine, la propria morte, che i segni di una possibile seconda vita, germogliati dentro la prima, non possono essere trascurati una volta emersi, chiedono di ottenere la nostra considerazione, chiedono che intervenga la nostra responsabilità. Chiedono che la trasformazione impercettibile affiorata qua e là, a volte solo aneddoticamente, nei nostri giorni, sia assunta per quel che è: la traccia di un avvio, verso la “riforma” della nostra esistenza.
Le trasformazioni silenziose, ma anche Essere o vivere (segnalato in questi Appunti lo scorso dicembre): se Jullien lo si conosceva già è escluso che si possa confondere questo suo ultimo libro con i vari manuali di saggezza che ingombrano le librerie. Ma occorre anche dire che partire da qui può costituire una scoperta inaspettata, un ottimo inizio per addentrarsi nel pensiero del filosofo francese, per lasciarsene accompagnare: sulle tracce di una seconda vita.

Roberto Casati, La lezione del freddo, Einaudi 2017 (pp. 177, euro 18)
Che cosa si può imparare dal freddo? o meglio: che cosa si può scoprire, comprendere grazie al freddo?
Se è di freddo vero che si parla, come quello della regione in cui l’autore e la sua famiglia vivono per quasi un anno, e non del “freddo turistico”, del mordi e fuggi di chi pratica sport invernali, allora ci si accorge, standoci, nel gelo, venendoci a patti, che lo si guarda “con un incanto pieno di nostalgia”. È Paolo Cognetti a dirlo, Cognetti lettore di Casati: per entrambi il freddo, il bosco, la neve sono tramite di esperienza. Di esperienza di quel che è essenziale nella vita, in primo luogo: raccogliere, spaccare, accatastare legna si rivelano gesti che moltiplicano la propria adesione al mondo, alla vita vera: in questo libro ci sono anche Lars Mytting e il suo Norwegian wood (v. Appunti per i lettori 2.12.2016). Anche se i luoghi sono diversi: qui siamo nel New Hampshire, fra i boschi di cui scrissero Thoerau e Emerson, boschi tanto fitti che a un italiano non possono non richiamare le terre del Barone rampante: “potremmo andare da qui al Pacifico saltando di ramo in ramo”.

È questo freddo anacronistico, perché riporta ai ricordi dell’infanzia, perché è minacciato dal riscaldamento del clima, che porta con sé un desiderio di essenzialità, e dunque di “poca connessione”: una cartina geografica al posto del GPS, niente notizie dell’ultima ora “costruite per spezzare il filo dell’attenzione e del progetto e dello sguardo lontano.” Basta leggerli una volta alla settimana i giornali, e per il resto scrivere invece: un diario. Un diario che registra i minimi fatti ma si apre a improvvise epifanie: “Mentre cammino nel bosco mi rendo conto che a poco a poco il freddo fa rintanare la coscienza nel fondo del corpo (…). Ma in questo preciso momento in cui scompaio io il mondo irrompe; se io non esisto quasi più, esiste quasi soltanto il mondo. E’ un momento di concentrazione totale e fluida, quasi incontrollata: non devo nemmeno puntare il faro dell’attenzione sugli oggetti intorno a me, le cose e gli eventi chiamano.” Ma attenzione: la retorica della palingenesi è del tutto estranea a Casati. L’irrompere del mondo e il ritrarsi dell’io non gi fanno dimenticare che non si è portato i guanti e le mani si stanno gelando: la vita materiale, quotidiana, resta quella, anzi: si impone, e proprio questo apre a intuizioni e momenti di contemplazione inediti. Meraviglia e autoironia percorrono questa lezione, divertente e insieme capace in certi momenti di realizzare l’aspirazione a “raccontare la stasi e il cambiamento impercettibile.” O a mutare, magari riflettendo sulla casa di legno in cui si è capitati a vivere, modi di vedere che si potevano credere inattaccabili: “pensiamo sempre che costruire per il futuro vada di pari passo con il lasciare tracce solide del nostro passaggio, e invece potrebbe essere una buona cosa fare esattamente il contrario: fai spazio al futuro, cancellati. Non ingombrarlo con eredità materiali” e dunque, perché no?, “progettare delle case a orologeria.”

David Bosc, La chiara fontana, L’orma 2017 (pp. 125, euro 13)
Prima di tutto l’ammirazione, l’amore addirittura, per un personaggio: l’aver sentito che la sua esperienza ha a che fare con la propria.
Non se ne può raccontare, altrimenti, se l’ambizione è quella di trasmettere il proprio sentimento a chi legge.
La conoscenza ravvicinata, documentata della sua vicenda, in secondo luogo. Ma non basta. Ne potrebbe uscire una biografia, capace magari di evitare le tentazioni dell’agiografia e le secche della commemorazione, capace di restituire il percorso del personaggio in questione, ma non necessariamente di dire davvero chi è stato, le ragioni della sua irripetibilità.
E allora non è raccontare la sua vita, tutta la sua vita, che occorre, ma avvicinarsi a un periodo cruciale da lui vissuto, quello in cui il suo carattere, le sue paure, le sue speranze han dovuto venire a galla, mostrarsi senza ricorrere alle maschere che le avevano fino allora camuffate.
Sono gli ultimi quattro anno di vita di Gustave Courbet quelli che Bosc sceglie per raccontare il maestro del realismo pittorico e insieme il comunardo in esilio in Svizzera e l’uomo che cerca negli eccessi – siano le donne o l’alcol (che lo ucciderà) – una sorta di coerenza con la sua immagine del Grande Tutto: “Courbet non accettava né la rettitudine né la sottomissione. E in ogni caso rifiutava di farsene portavoce. Aveva visto alcuni aspetti della dismisura, diversi volti dell’incommensurabile. Per lui non aveva alcun senso dire che un animale è pieno di nobiltà, che un albero è maestoso, che la foresta sembra una cattedrale. Paesaggista? Courbet immergeva la faccia nella Natura, gli occhi, le labbra, il naso, le mani, col rischio di perdersi; e soprattutto col rischio di essere abbagliato, rapito, sollevato, liberato da se stesso, strappato al suo isolamento di creatura e proiettato, disperso, incorporato nel Grande Tutto.” E non si trattava del sentimento oceanico, dell’estasi della fusione di sé nel Mondo, perché “dipingendo cadaveri e mezze carogne, Courbet esprimeva l’assurdità della condizione naturale, la brutalità gratuita, la morte e la divorazione.” Né la sua pittura è distacco dalla storia: il suo realismo è “un contrattacco alla fiaba sociale, all’illustre modello di civiltà, alla civilizzazione”, e “lacera le scenografie dietro le quali si svolge il lavoro sporco”, “le allegorie nelle scuole e nelle stazioni, dove si vedono le dee dell’industria e dell’agricolture, gli splendori delle colonie e i prodigi della scienza.”

Coerentemente con questo intento di avvicinarsi dall’interno al personaggio, citando documenti che testimoniano delle sue scelte e degli eventi che lo coinvolgono senza mai farne il perno per la costruzione di una biografia rigorosa, dall’esterno, Bosc adotta un linguaggio che procede per immagini. Una scrittura nella quale riferire di quel che accade a Courbet e proporre le riflessioni che quegli eventi suscitano non sono piani separati. Perché non è una ricostruzione storica quella che leggiamo, ma un romanzo. Un romanzo capace di rendere più di una biografia l’essenza del personaggio di cui si occupa. Proprio perché, a tratti, il narratore, raccontando chi è stato l’altro, implicitamente racconta di chi è lui; dicendo dei tratti che hanno distinto il personaggio, l’artista amato, e che sono poi le ragioni per cui lo ama, finisca col dire di sé, di chi è, o vorrebbe essere.

Jean-Baptiste Del Amo, Regno animale, Neri Pozza 2017 (pp. 411, euro 18)
Lo si potrebbe descrivere come la saga di una famiglia contadina francese, divisa equamente in due parti. 200 pagine la prima, che tratta degli anni di inizio Novecento, e 200 la seconda, che salta agli anni Ottanta.
Fra una e l’altra la Grande guerra, che arriva a strappare i figli a genitori per i quali “la guerra è un’astrazione, una parola vuota”, “ i tedeschi una razza esotica e barbarica”, “il fronte un territorio misterioso”. Perché la loro vita è tutta lì, nel lavoro della campagna e nell’allevamento dei loro animali.
L’idealizzazione del mondo contadino pare ormai estranea ai non molti romanzi che ancora ne trattano (vedi ad esempio Cuore di bestia di Noëlle Revaz, edito da Keller nel 2013). Ma qui si va oltre, e le immagini che Del Amo ci propone, il suo lessico, aggrediscono il lettore: non a caso la critica l’ha avvicinato a Céline e Houellebecq.
La crudeltà che regola nella più completa indifferenza il rapporto con gli animali è il tema centrale, e non perché sia una novità: anche la porcilaia contadina conosceva la più completa indifferenza nei confronti della sofferenza animale, ma al tempo stesso una vicinanza per cui “nello stesso tempo, nello stesso luogo, uomini e animali nascono, vivacchiano e scompaiono”. Non è così nell’allevamento industriale, dove “i maiali pisciano e cacano tutto il giorno nell’esiguo spazio dei recinti che a malapena permette loro di muoversi, li costringe a evacuare sotto di sé, a calpestare i loro escrementi, sdraiarvisi sopra, rotolarvisi” e “gli uomini combattono contro la merda una lotta che si rinnova quotidianamente”.

Non c’è traccia di pietà in descrizioni simili, anche se non riescono a passare inosservati l’occhio del coniglio che, appena ammazzato, sembra guardare ancora, e il cane che sentendo vicina la fine va a nascondersi e, quando la giovane padrona gli passa accanto senza vederlo, “sente il suo odore e muove la coda, e muore nella sua solitudine e nel suo silenzio di animale mentre i passai della ragazza si allontanano”. Del resto, lo scrittore, intervistato, non esita a dichiarare che gli “atti quotidiani innumerevoli che vengono compiuti nell’ambito dell’allevamento suino sono di una violenza inaudita. La castrazione con l’animale vivo, il taglio dei denti e della coda”. Il fatto è che, per Del Amo, “tra il maiale e l’uomo, in molti casi, c’è davvero poca differenza”: vittime entrambi della barbarie del nostro tempo? Sicuramente, ma anche – sembra emergere – di una cieca volontà di vita: “ovunque, tutto intorno, gli animali fottono e copulano” e “lo sperma stilla, gocciola, cola”, così come, quando arriva la primavera, la linfa comincia “a zampillare dentro gli alberi, a salire pesantemente nei tronchi”. La vita, prima che la storia, sembra alimentare il destino insensato di tutto ciò che nasce, corre verso la propria rovina e muore. E la scrittura registra questa assurda ininterrotta ripetizione, mettendo a dura prova la capacità del lettore non di tollerare il peso della compassione, ma di resistere a un disgusto crescente: è una pedagogia dell’orrore quella che Del Amo si propone? Le sue dichiarazioni – forse più delle sue pagine- autorizzerebbero a crederlo: “questo non è un libro militante che vuole che la gente smetta di mangiare carne. Però, se qualche lettore, una volta finito di leggerlo, smetterà di mangiare il prosciutto, beh, io sarò felice di tutto questo”.

Massimo Tedeschi, L’ultimo record, De Ferrari 2017 (pp. 105, euro 9,90)
Il Garda, ma non quello di oggi, siamo all’inizio degli anno Trenta.
Le strade sono sterrate, percorse dai carri dei contadini – che non hanno ancora imparato a fare un vino che non dia vertigini alla testa e bruciore allo stomaco – e dalle biciclette di chi va o torna dal lavoro – nelle cartiere, negli alberghi, nelle limonaie che ancora rimangono. Poche le macchine. Giusto qualche Balilla, come quella del commissario Sartori. Italo Sartori. Trasferito sul Garda dal suo Abruzzo come Rocco Schiavone ad Aosta dalla nativa Roma. Ma non incazzato sempre come quello. Né serioso e umorale come Montalbano, anche se – come il commissario di Vigata all’agente Galluzzo – ogni volta che sale in macchina raccomanda a Bubbico, il suo autista, di non correre. Perché lui, Sartori, odia la velocità, e tollera a fatica la mania dilagante in Riviera: una mania della velocità, che si manifesta nelle gare di motociclette attorno al golfo di Salò, nel passaggio della Mille Miglia nel basso lago, nelle corse di motoscafi per la Coppa dell’Oltranza, lanciata da un testimonial d’eccezione come il poeta guerriero del Vittoriale, un’altra presenza che torna anche in questo secondo giallo di Massimo Tedeschi, dopo che , in quello precedente, Carta rossa, era apparso tutt’altro che estraneo all’intrigo che il nostro commissario aveva risolto.
Ma stavolta la sua non è un’indagine delle solite, perché il morto non c’è. Non c’è ancora per lo meno, e se qualcuno ci ha lasciato la pelle si è trattato di una fatalità, o così pare. Può capitare, del resto, quando si vola sugli idrovolanti della Reparto di Alta velocità di Desenzano e si cerca di battere il record stabilito volando ad oltre 700 chilometri all’ora, perché così vuole il Duce: per fargliela vedere, agli inglesi. E dunque Sartori è lì, fra piloti e meccanici, progettisti e istruttori di volo, che deve aggirarsi: nel covo dell’alta velocità, proprio lui che detesta la fretta, che non ama la frenesia persino quando a manifestarla è il corpo focoso della signora che puntualmente, con entusiasmo e generosità, lo accoglie nella sua villa a Portese.

Sabotaggio! urla il colonnello Bernasconi, che su questa pista cerca di indirizzare l’indagine del commissario, da lui chiamato a risolvere l’enigma di incidenti che si ripetono e possono costare la vita ai giovani piloti, ma soprattutto frenano la corsa al nuovo record e dunque rischiano di mandare a picco l’impresa (Mussolini, in visita a Desenzano, è stato chiaro: “ne ha pieni i coglioni di spendere soldi per il mio Reparto”, lamenta il Bernasconi). Senonché, i sommari interrogatori, condotti sempre con ironia circospetta dal sornione poliziotto, abile nell’arte dello gnorri, arrivano a una conclusione inattesa. Fra una mezza parola strappata a qualcuno che lavora attorno agli idrovolanti e qualche ammissione ottenuta da una giornalista francese, un console tedesco e un’aviatrice inglese – tutti turisti amanti del Garda ma stranamente curiosi degli aerei che lo sorvolano in velocità – la verità viene fuori, e come sempre è più complicata, e drammatica, di quanto potesse apparire. La figura del valente meccanico originario di Fratta Polesine, il paese di Matteotti, non è di quelle che si dimenticanoappena chiuso il libro.
Un libro che, pagina dopo pagina, si fa leggere in velocità, per restare in tema: perché si vuol vedere come va a finire. Un racconto riuscito perciò, ma non solo per la felicità dell’intreccio. Il piacere della lettura viene anche dai riferimenti puntuali al mix di “mito e meccanica, leggenda e tecnologia” racchiuso negli aerei e nelle imprese di Francesco Agello e degli altri cavalieri dell’aria; dai cenni alla cultura imperante (D’Annunzio in primo piano, il futurista Marinetti sullo sfondo), ma soprattutto dalla capacità di restituire il sapore dei luoghi, dei colori di un lago che nonostante tutto sembra – in certe stagioni almeno, in certe ore del giorno – aver saputo conservare la sua fisionomia inimitabile.
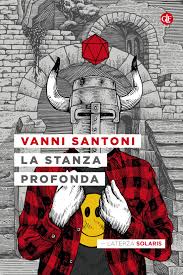
Vanni Santoni, La stanza profonda, Laterza 2017 (pp. 151, euro 14)
Nel libro precedente (Muro di casse, Laterza 2015), i rave party, le grandi feste notturne clandestine e gli sballi di musica e fumo: dovunque il posto si prestasse, capannoni dismessi, cascinali abbandonati, boschi.
In questo – prima opera di narrativa proposta da Laterza allo Strega – un garage, un ex garage anzi, da anni trasformato dalla famiglia in ripostiglio. Ma questo drastico ridursi degli spazi non ha nulla di rinunciatario, o almeno non si direbbe: qui, nel garage, gli spazi sono quelli della fantasia. O meglio: del fantasy, ambiente privilegiato dai giochi di ruolo.
Rave, giochi di ruolo: i protagonisti sono sempre quelli. Bambini negli anni ’80, quando i giochi di ruolo conoscono la loro epoca d’oro, per declinare nel decennio seguente, quando i rave sono invece pratica diffusa in tutta Europa. Per poi ridursi a nicchie, gli uni e gli altri, dopo aver risposto al bisogno di quei riti collettivi, di iniziazione in particolare, che i giovani avvertivano, e non han cessato di avvertire.

Solo che nel frattempo molte cose sono cambiate. Non solo l’aggregarsi subitaneo di masse di coetanei è un ricordo, che ha lasciato il campo alla fatica di mettere insieme anche solo un gruppetto di appassionati dei giochi di ruolo: è la cittadina toscana in cui si sono trascorse infanzia e adolescenza e alla quale si torna appunto per ritrovare gli amici con cui giocare, che non è più quella, “però non sai mica quando è cambiata così, quanto è stato graduale questo cambiamento, quando è sparito l’acciottolare dei piatti sulla sigla del telegiornale, sul jingle dell’Almanacco del giorno dopo, quando le edicole aperte e l’odore di ragù e i nugoli di ragazzi sulle bmx… Sai come l’hai trovata oggi: un paio di capannelli davanti alla stazione, chiuso il bar in cui andavate a far forca ai tempi del liceo, chiuso il negozio dei giochi dove passavate le giornate e dove nacque il gruppo”.
Il sentimento della nostalgia, a quanto pare, non è prerogativa dei vecchi: anche chi non è ancora quarantenne lo può provare. Perché si può sentire nostalgia anche per ciò di cui non si è fatta diretta esperienza: per il tempo in cui la gente stava insieme di più, ad esempio. E tutta la fatica che il protagonista fa per rimettere insieme un gruppo di giocatori non è questo in fondo? Anche se, al centro, più dei giocatori (qua e là echeggianti alla lontana profili e movenze che richiamano i ragazzi di Trainspottig) ci sono loro, i giochi, con la loro nomenclatura – inglese, non occorre dirlo – sempre in evoluzione: chi ha l’età giusta troverà in questo libro una sorta di album di famiglia, e una lingua che oggi è usuale, con il suo mix di anglicismi e slang quotidiano.
Chi invece è più in là con gli anni potrà adeguare ai propri ricordi l’esperienza del successo e del rapido crepuscolo (anche se molto meno rapido che negli anni successivi) dei giochi che hanno segnatola sua infanzia: le costruzioni, di legno, soppiantate dal meccano, di metallo, e dal lego, di plastica; il trenino elettrico trascurato per la scatola del monopoli.
Una storia minore che non è finita: i giochi di ruolo (con il loro dadi, matite, schede e manuali di istruzioni) non hanno forse aperto la strada agli immateriali videogiochi, che certamente non sono un punto d’arrivo, anche se non sappiamo a cosa preludano?
Discorsi stravaganti, da collezionisti o storici dell’infanzia? Walter Benjamin non lo credeva: fra le molte cose che riconosceva come spiragli, indici significativi, per comprendere il mondo contemporaneo e la vita che vi conduciamo i giocattoli occuparono sempre per lui un posto di prim’ordine.

Francesco Germinario, Un mondo senza storia? La falsa utopia della società della poststoria, Asterios 2017 (pp. 126, euro 16)
“Le commemorazioni legate alla «Giornata della memoria» realizzano il primato della destoricizzazione”: “agli studenti sono proposte riflessioni o ricostruzioni che esulano quasi sempre dallo svolgimento effettivo dei programmi di storia, rendendo difficoltosa la medesima collocazione della Shoah sul piano temporale”.
E i viaggi ad Auschwitz? Nella sostanza, “iniziative vissute dai partecipanti come una gita scolastica”, al massimo “come una declinazione del «turismo della memoria»”. Operazioni che contro la loro volontà finiscono per banalizzare la storia, dunque? No, peggio: “procedure esorcistiche, finalizzate a sterilizzare i contenuti politici degli atteggiamenti xenofobi correnti”.
Parte dalla scuola, e dall’insegnamento – dal non insegnamento – della storia del Novecento che in essa si pratica, questo libro, ma non è un testo esclusivamente per insegnanti, nonostante la sua tempestività e l’innegabile sintonia con i discorsi suscitati dalla proposta di accorciare di un anno le scuole medie superiori: “invece di diminuire i corsi di un anno, si tratta di far entrare un secolo in più nei programmi”, scriveva poche settimane fa Asor Rosa su “La Repubblica”.
Perché questo è il punto: il fatto che il programma di storia che si svolge non contempli, di fatto, il Novecento e, se va bene, tocchi per sommi capi la sua prima metà fermandosi alla seconda guerra mondiale, è la spia – anzi: la causa e l’effetto insieme – di un diffuso e pervasivo atteggiamento culturale, esistenziale, che induce non a un generico pessimismo sui tempi che corrono, ma al riconoscimento che quella ormai in atto è un’“apocalisse antropologica”. Una mutazione che si rivela nella separazione fra Storia e vita: il Tempo è privatizzato, è solo il tempo biografico, quello che si vive (o si immagina di vivere) in prima persona; la vita è depurata della sua storicità, a partire dalla rimozione del limite che la connota: non è fatta di esperienza, ma di consumo, e il consumo si svolge nel Presente, lo pervade, lo impone come unica dimensione della realtà e del pensiero (“unico”, per l’appunto). Il presentismo imperante “ha fagocitato le scansioni temporali Passato-Presente-Futuro; forse a essere entrato in crisi è il concetto medesimo di Tempo” (salvo poi ricevere i contraccolpi di questa riduzione al puro presente – verrebbe da aggiungere – sottoforma di insoddisfazione cronica, di infelicità, di depressione…).

E non è che la memoria – terreno diverso da quello della storia, ma pur sempre rivolto a mantenere un senso del Passato – contrasti davvero la dittatura del Presente, perché “la memoria, per essere attiva, necessita di momenti di socialità forte”, come il partito politico, che è però entrato in una crisi irreversibile negli ultimi decenni (complice lo smantellamento operato con disinvoltura, e fierezza in molti casi… – ndr.). E allora, a chi il compito di impedire che la memoria si privatizzi e la storia diventi “egostoria”? Alla scuola! “L’istituto formativo è rimasto pressoché l’unica agenzia deputata a gestire questa operazione”.
Ecco perché si è partiti dalla scuola: è lì che la scomparsa del pensiero critico – perché non ce n’è se manca la consapevolezza della storicità, e dunque della superabilità, del Presente – ha fatto le sue prove e celebra i suoi fasti.
E gli storici, quelli che per mestiere frequentano il passato, e ci si aspetta ne tengano vivo il senso anche fra coloro che storici non sono? “Tramontati i partiti, quale contenitore di sapere e di memoria storica, ed evaporata la politica, quale potente stimolo alla conoscenza, la ricerca storica è stata costretta a ripiegarsi su stessa, per ritrovare le ragioni e le motivazioni del proprio operare”. Presto dette, per altro: “rispetto alla cultura dominante della poststoria”, lo storico (se non appartiene alla maggioranza degli storici che scrivono per altri storici) è tenuto dal suo stesso “specialismo” a “volgere lo sguardo all’indietro. E, per un curioso paradosso, il principio di speranza non sorge, come nei profeti biblici, dalla constatazione della condizione presente di miseria, ma dalla riflessione sul Passato: è proprio volgendosi all’indietro che lo storico decreta la storicità del Presente”. E’ proprio indagando sul Passato, che può fare il suo dovere: “porre le domande scomode spinose sul Presente.”

Elias Canetti, Il libro contro la morte, Adelphi 2017 (pp. 393, euro 18)
“Riuscirò a scrivere il libro sulla morte solo avendo l’assoluta certezza che non sarò io a darlo alle stampe nel tempo di vivere che ancora mi resta”.
Elias Canetti, ottantaduenne, si è persuaso che il libro della sua vita, quello cui ha lavorato per più di quarant’anni, resterà incompiuto.
Anzi: allo stato di appunti, pensieri, aforismi, il genere in cui – come ammette lui stesso – ha “perseverato con coerenza per cinquant’anni, e questo proprio per via della loro incoerenza”. Il che non toglie che quelli che ha raccolto e ancora sta raccogliendo attorno al tema della morte formino un libro, “così da poter essere in seguito pubblicato”. In seguito, perché “solo in questo modo posso essere davvero sicuro che mi pronuncerò sempre con sincerità, senza riguardo per i vivi”. “Voglio dire quello che penso”, questo il proposito che percorre queste pagine, immutabile negli anni, e che trova il suo fulcro nell’atteggiamento richiamato sin dal titolo. Quello di Canetti non è un libro sulla ma contro la morte: “Sarebbe giusto chiudere gli occhi davanti alla morte? No, tre volte no! tenerli spalancati gli occhi, e maledirla, e ancora maledirla. E non cercare di rabbonirla mettendo limiti al rifiuto nei suoi confronti”. Vengono in mente, per contrasto, alcuni autori, i cui libri sono apparsi in questi ultimi mesi, che appunto tentano invece di venire a patti con la questione: da Yalom (Fissando il sole, Neri pozza) a Boncinelli (Io e lei, Guanda) a Maggi (L’ultima beatitudine, Garzanti), ricorrendo alla saggezza epicurea il primo, alle certezze disincantate della scienza il secondo, a quelle della fede il terzo. E Canetti ne ha per tutti, verrebbe da dire, perché i suoi pensieri sono anche una rassegna delle posizioni ritenute da lui illusorie, o inaccettabili addirittura: non basta pensare che intanto che viviamo la morte non c’è e quando arriverà noi non ci saremo, perché la morte è “un’ultima angustia orribilmente penosa, liberarsi dalla quale non è cosa che dipenda da noi”, tant’è vero che “teniamo conto della morte anche quando non la stiamo aspettando”.

D’altra parte, “la biologia sa definire la morte altrettanto poco quanto sa definire la vita e la peculiarità dell’essere umano”, e la fede serve solo ai credenti per facilitarsi la vita, “immaginando di rivedersi, mentre questo non sarà loro mai concesso!”
Non è solo contro la propria morte che Canetti combatte, ma contro la Morte, in generale – la sua lunga vita gli ha consentito di confrontarsi con le stragi del secondo conflitto mondiale come con quelle della guerra del Golfo – senza per questo diluire nella riflessione storica il pensiero della propria fine, della fine di uno scrittore che in un libro sulla morte ha individuato il suo compito più significativo: “Puoi fare in modo che ti diventi indifferente quanto accadrà alle tue opere? No, finché continuo a scrivere. Ma un giorno o l’altro potresti finalmente smettere di scrivere, magari quando avrai terminato questo libro? Non posso. Non potrò. Allora non farai mai pace con la morte? Mai.”
Ha 87 anni, Canetti, quando – morirà due anni dopo – ritorna sul proprio progetto e non se ne nasconde l’insensatezza, o peggio: “A poco a poco mi rendo conto che nulla è più volgare, banale, scontato e demagogico della mia battaglia contro la morte. Ho cominciato a vergognarmene, ma ciò nonostante persevero in essa, imperterrito”.
Torna alla mente un altro grande pensatore che della morte si è occupato nel libro che si può considerare riferimento obbligato di ogni riflessione sulla finitudine della vita, quattrocento pagine per sondare, spiegare, ribadire il fatto che la morte non è qualcosa ma è nulla, e non consiste dunque in altro che nel “No dell’indicibile”, che “non domanda di essere compreso o interpretato, e non è fatto nemmeno per suggerirci pensieri reconditi positivi”. Così Vladimir Jankélévitch (La morte, Einaudi 2009).

Alfredo, pensionato flâneur, percorre ogni giorno la città con un’attenzione e una curiosità che gli permettono di trovarvi occasioni di incontro, momenti di scambio, ma anche di confrontarsi con atteggiamenti e mentalità che lo inducono a rifl essioni disincantate, non di rado perplesse o apertamente critiche e tuttavia mai inclini alla recriminazione o al risentimento.
Nelle sue passeggiate è a volte accompagnato dal nipotino, e la diff erenza d’età non sembra compromettere la sintonia del loro sguardo. Uno sguardo che potrebbe a volte richiamare quello di Marcovaldo, il cui creatore è non a caso esplicitamente richiamato in uno dei racconti. Anche Alfredo appare infatti sempre aperto al nuovo, al diverso, nella città di oggi emblematicamente rappresentato dallo straniero immigrato. Senonché, il protagonista di questi racconti non si guarda attorno cercando occasioni di evasione o insperate risorse che possano portare conforto alla
misera vita familiare. A richiamare l’attenzione di Alfredo sono piuttosto episodi e situazioni da cui ricavare cauti ma fondati giudizi su come va oggi il mondo.
Mai rinunciando, comunque, alla disposizione a credere che anche “una città infelice può contenere, magari solo per un istante, una città felice”, per quanto invisibile ai più.
—
Quelli che seguono sono brani tratti da alcuni dei racconti:
da Cerchio blu:
Se ci entri, alle 8, quando hanno appena aperto, cammini in strade che non sono strade. Perché non ci sono le vetrine. Son tutte chiuse, le serrande tirate giù. Come di notte, in città, che allora incontri solo qualche sbandato ogni tanto, ma soprattutto marocchini e neri. Sembra che ci siano solo loro.
Invece qui no. Loro non ci sono. Ci sono solo ragazzi se mai, che mangiano gelati e bevono cocacole e birre anche se sono appena passate le otto, di mattina. Fumano, e camminano camminano in queste strade che sono corridoi. Han bruciato. Non sono andati a scuola. Staranno qui tutta la mattina.
Una volta andavano in castello, i ragazzi che bruciavano. A girare per i viali e a giocare a flipper al bar che c’era là. Poi allo zoo, sui terrazzi delle torri a guardar giù… Ma adesso vengono qui. A anche se la mattina presto non ci sono ancora le vetrine illuminate, i tabelloni che dicono le offerte, le televisioni che fanno la pubblicità, e sembra tutto come il giorno dopo l’epifania. Perché qui è così: o è festa o niente. Non ci sono i giorni feriali. Solo domeniche, oppure è un mortorio.
Che se c’era un posto dove non c’era mai la domenica era proprio questo, perché i tubi li facevano sempre, giorno e notte, natale e pasqua. Facevano i turni, ma tu non vedevi niente perché non si poteva entrare e c’erano muri tutto intorno.
Adesso invece ci si passa dentro, anche senza comprare niente.
Cerchio blu, l’han chiamato. Dappertutto cerchi blu, per terra, sulle vetrine, sulle camicette delle commesse. E fuori, sul tetto, cerchi blu di neon, che li vedi a un chilometro.
(…)
Bè insomma, adesso saran tre mesi che passo sempre dentro. Non è che mi è passata del tutto di sentirmi un po’ un pollo d’allevamento a andar dentro, ma è che fuori è più triste. Lì dentro guardi e nessuno ti guarda, ma non ti spiace. Anzi. Anche tu non li guardi, gl’altri. Nessuno guarda nessuno.
Fuori, non hai niente da guardare, ma sei sempre lì che aspetti come di riconoscere qualcuno, o che qualcuno sia lui a salutarti.
Dentro, no. Ho visto uno che conoscevo, ma ho fatto finta di niente e ho guardato dritto avanti. Non è mica un posto da star lì a dirsi come va, quello lì. Massimo, un saluto con la mano, ma da lontano, senza fermarsi.
Il bianco con le bollicine costa quattro euro invece che due. Perché io la sera… mi piace bere un bianco prima di tornare a casa. Te lo fanno pagare il doppio. Però lì non ti resta sullo stomaco perché l’hai bevuto tutto in una volta per uscire subito perché il bar è vuoto e non c’è nessuno che conosci.
Lì dentro no. Te la prendi calma. Perché è normale non conoscere nessuno.
Quando hai bevuto molli il cine a colori e torni in quello in bianco e nero. È questo l’effetto che fa.
’Sera… ma lo dici a voce bassa, tanto lo sai che neanche ti sentono. C’è la musica sempre, lì dentro. Se per caso ti hanno sentito allora dicono buona giornata. Né buongiorno né buonasera: buona giornata. E non sai se l’han detto a te o a un altro.
Buona giornata. Anche se è già sera.
—
da Per leggere il giornale:
Io il giornale, a casa, non sono mica capace di leggerlo. Non so… mi sembra di non aver niente a che fare con quelle cose che leggo. O perché sono lontane – l’Iraq, la Corea… – o perché… magari non sono lontane ma è lo stesso: di quelle robe che si fa fatica a pensare che succedono qui da noi, in Italia. Bè insomma: se le leggo in casa mi sembra di essere scemo a prendermela per quelle cose lì. Se invece sono fuori, dove c’è dell’altra gente, allora mi sembra di fare il mio dovere a leggere il giornale, e ci provo anche gusto se c’è qualcuno da dire due parole. Leggere il giornale fa parlare, delle volte. Perché è raro che qualcuno racconti qualcosa, se no. Una volta succedeva, ma adesso… E è un bel po’ che a me sembra che non succede più. Raccontavano una volta. Mica tutti ma ce n’erano: cose che c’hai a che fare anche tu e se le ascolti magari dici anche tu la tua. Ma siccome oggi non succede bisogna trovare qualcosa per parlare, qualcosa che non è né mio né tuo né suo, ma un po’ è di tutti, e delle volte le notizie sono così. Non importa se sono da ridere o se fanno arrabbiare, che poi la maggior parte fanno arrabbiare. Che conta è che tu magari leggi una notizia a alta voce… non occorre un discorso, basta mezza parola, anche solo la faccia che fai, e un altro butta lì una parola, e tu allora un’altra e via, si parla. Non mi importa che quello la pensi come me. Certo se è uno come te, che vedo che legge anche lui la repubblica, va meglio. Però, delle volte, ascolto quelli che stanno dall’altra parte e mi fanno pensare, perché più andiamo avanti e più mi pare che ci sono cose che pensiamo anche noi come loro, se vuoi che te lo dica. E questa è già una cosa che fa pensare. E non ce ne accorgiamo se continuiamo a parlarci solo fra noi, e anzi: crediamo di essere sempre i più forti, quelli che la vedono giusta. Speciali addirittura, noi. Invece, a ascoltare come la vedono gli altri, anche quando dà fastidio, primo: capisci che sono tantissimi. Di più di noi. E poi senti delle cose che, ecco, ti fanno pensare che non si può continuare a dire le cose come le dicevamo trent’anni fa, mica perché sono sbagliate eh: io non sono mica uno di quelli che dicono che ci vuole il nuovo e i giovani e insomma bisogna buttar via tutto, figuriamoci. Però… va a finire che a parlare solo fra noi convinci solo quelli che sono già convinti.
—
da Sentieri in città:
(…) la caccia ai sentieri. Era una gara: chi li vedeva per primo, e lui teneva il conto. Bastava andare in qualche giardino pubblico e c’era da divertirsi. Dove c’era un vialetto che faceva una curva potevi giurarci che trovavi il sentierino che tagliava dritto. Al campo militare, che adesso non è più per i soldati, ci vanno a correre tutti, lo sapevo che c’era un sentiero che lo tagliava esattamente a metà. Il più lungo che avessi mai visto: l’ho lasciato scoprire al Luigino…
Dopo è venuto che, non che il gioco ci avesse stufato, ma lui ha cominciato con le domande: quanto saranno vecchi? c’erano già prima che mettessero l’asfalto sulle strade?
A me è sembrato di rispondergli che sì, mi sembravano vecchissimi, di più delle strade asfaltate. Non so perché ho detto così: mi faceva piacere pensare che nella città di oggi ci fossero i segni di dove camminavamo in quell’altra che non c’è più. La città dove si andava solo a piedi, niente macchine, solo cavalli se mai. La città dove i passi lasciavano il segno, non come sull’asfalto. O sul cemento. Anche se il Luigino, una volta che parlavamo di questa cosa, mi ha portato a vedere un marciapiede vicino a casa sua dove si vedono le orme di un cane: passato quando il cemento era ancora fresco, mi ha spiegato.
(…)
Lui, questa cosa delle impronte gli interessava molto, ci ragionava su. Un giorno che eravamo alla fontana dei giardini e c’era un piccolino col padre che gli faceva andare la barca telecomandata – e intanto il figlio guardava Luigino che tirava sassolini nella vasca e si era dimenticato della barca e non ascoltava più il padre che gli diceva come si faceva a guidarla – il Luigino ha detto che la barca lascia come una specie di orma, ma lunga.
Una scia, gli ho detto io.
Sì, proprio, come quella che lasciano gli sci.
Ero lì che pensavo alla scia e agli sci, e lui ha fatto: anche in piscina, quando vado a nuotare, ci faccio la scia. Però non dura.
E qui lui è saltato fuori con una di quelle che bisognerebbe scrivere: i sentieri sono le scie dei passi, ha detto, serio come è lui quando proprio in quel momento sta capendo qualcosa. Ma non era finita: sono le scie che fanno i passi per far sapere agli altri che siamo passati di lì e dunque anche loro possono passarci.
![]() Se vuoi leggere il libro nella sua interezza lo puoi acquistare alla nuova libreria Rinascita di Brescia (12 euro).
Se vuoi leggere il libro nella sua interezza lo puoi acquistare alla nuova libreria Rinascita di Brescia (12 euro).
Via della Posta, 7 – 25121, Brescia
Tel. 0303755394
libri@nlr.plus
Se vuoi riceverlo a casa puoi inoltrare il tuo ordine indirizzandolo a: ordini@secondorizzonte.it
e segnalando l’avvenuto versamento dell’importo indicato tramite bonifico sul conto corrente della libreria (IBAN: Unipol Banca – Agenzia di Brescia: IT 10 B 031 2711 20000000000 1851).
La spedizione non comporta aggravi di spesa.
Dal Giornale di Brescia del 16 novembre 2017.
Clicca sull’immagine per visualizzare l’articolo.
Dal Corriere della Sera Brescia del 23 novembre 2017.
Clicca sull’immagine per visualizzare l’articolo.
Da Bresciaoggi del 28 dicembre 2017.
Clicca sull’immagine per visualizzare l’articolo.
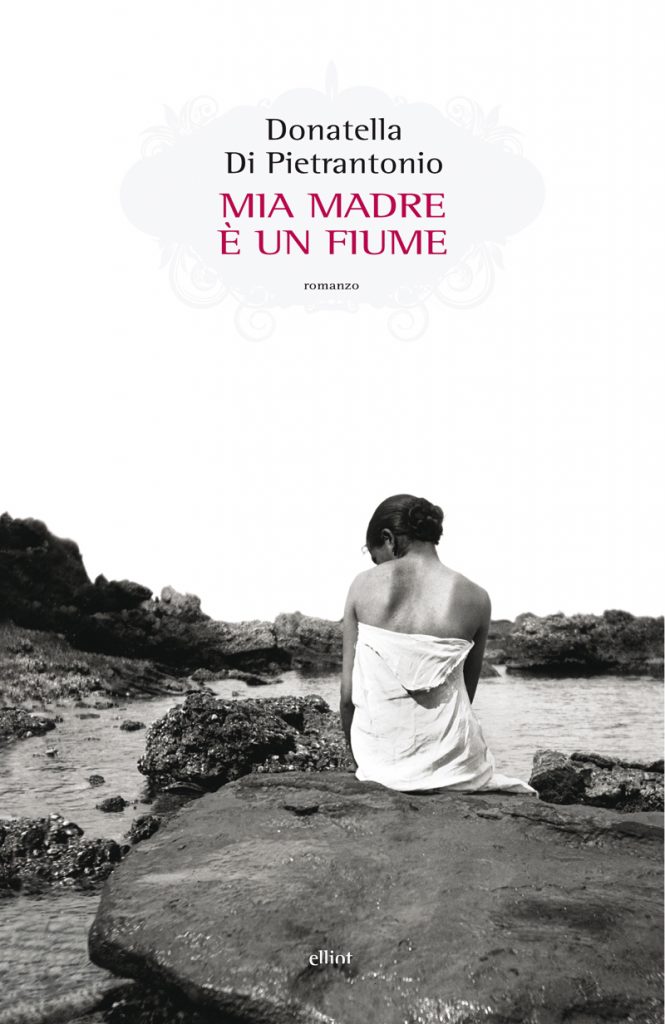
Donatella Di Pietrantonio, Mia madre è un fiume, elliot 2011
La assiste, la porta alle visite di controllo – anche se lo sa: servono soprattutto a lei, perché la rassicurano – e nel complesso può ritenersi “una figlia sufficientemente buona”.
La celebre definizione di Winnicott riguardava la madre che possiede la capacità di accudire il suo bambino e – al di là delle sue intenzioni – non fargli dentro il vuoto che altrimenti quello si porterà dietro tutta la vita. Ma i ruoli si invertono: ora è alla figlia che spetta il compito di curare la madre: ci riesce? A suo modo, in qualche modo. Come tutti quelli che hanno vissuto l’esperienza di accompagnare i genitori nell’ultimo tratto della loro vita, e ne sono usciti stremati, ma soprattutto insoddisfatti, frustrati se non addirittura gravati di rimorsi: per non aver fatto tutto quello che andava fatto; per non aver fatto abbastanza avendo già mentre lo facevano questa sensazione di insufficienza, o di inadeguatezza; per non aver donato tutto il tempo possibile a chi forse non chiedeva molto di più, in fondo (“odio il tempo che mi costa”, confessa la figlia, voce narrante di questo romanzo). Tutta la storia di una relazione – una relazione primaria, che non appartiene e non apparterrà mai al passato – precipita in quei mesi, in quelle settimane finali, portandosi dietro tutto. Tutto quello che l’ha definita sin dai primi momenti dopo la nascita, e poi nell’infanzia, nell’adolescenza, nella prima giovinezza. Ed è allora un bilancio inevitabile quello che alla fine si impone, e può essere un bilancio drammaticamente negativo: “Il nostro amore è andato storto, subito.” Perché? Perché la madre non ha potuto essere una madre sufficientemente buona, si potrebbe sintetizzare: “Era troppo educata al sacrificio per permettersi il piacere di stare con la sua creatura. (…) Lei mi amava, ma aveva altro da fare. Lavorava, per sua figlia. Non venivo prima nei suoi pensieri e non l’ho sopportato. Da grande mi sono appellata alla sua storia, ma non ci ho creduto abbastanza. Doveva disubbidire, per me, amarmi contro tutti.”
Con questa “madre inaccessibile, separata, non per disamore, per fretta, quest’altra forma del disamore” la figlia vuole, deve fare i conti che da sempre si proponeva, e sempre ha rimandato, fino al momento in cui lei, la madre, “è sfuggita nella malattia”, in una condizione nella quale “i conti non si chiudono mai”.
È questa consapevolezza a guidare la narrazione, una narrazione che sa dare respiro storico, sfondo collettivo, alla vicenda materna che ha segnato la figlia: tornano alla mente le pagine che un’altra scrittrice, Annie Ernaux, soprattutto quella di Una vita di donna (Guanda, 1987), anche lei alle prese con la demenza della madre (“Non volevo che ritornasse bambina. Non ne aveva il «diritto»”). Non fosse che la confidenza, con il corpo bsognoso di cure della madre, che là si riscontra, resta nelle pagine di questo romanzo una dimensione penosamente irraggiungibile: “mi tocca la gamba all’improvviso e parla di questa mia gonna così morbida. (…) Soffro il contatto, avverto il disturbo. Controllo la reazione. Cerco di sembrarle disponibile ma non mi credo, sono rigida. Dove posa il palmo, la pelle scotta sotto il tessuto.”

Provando a spiegare le ragioni del successo del suo ultimo romanzo, L’arminuta (recente vincitore del Campiello, di cui questi appunti si sono occupati lo scorso 14 maggio), Di Pietrantonio – che sarà con noi in libreria il prossimo 10 novembre – ne rintraccia il motivo nei “temi universali che tratta”. La vicenda è quella di un abbandono drammatico, infatti, ma anche chi non ne ha subito uno tanto grave “può immedesimarsi nell’Arminuta”. E’ forse questo il filo che lega questo romanzo al primo, quello d’esordio: la capacità, guadagnata attraverso la scrittura scarna che li caratterizza, di rendere condivisibili stati d’animo nati da vicende apparentemente lontane dall’esperienza di chi legge. Nell’Arminuta, il senso dell’abbandono; in Mia madre è un fiume, il senso di una problematicità irrisolvibile e bruciante che il rapporto con la propria madre lascia nella figlia.
Una problematicità alla quale anche chi è figlio, leggendo queste pagine, si sente tutt’altro che estraneo.

Mariagrazia Fontana, Il tempo raggiunto, secondorizzonte e Liberedizioni (pp. 280, euro 16)
Misurarsi con il proprio corpo, i segni che ne giungono, le paure e i desideri che indistintamente esprime, nell’esperienza della malattia come nella pratica della corsa.
Soccorrere quello ferito e sofferente – tanto più da interpretare nel suo muto linguaggio se chi ricorre alle cure è straniero – nell’esercizio del proprio lavoro, un lavoro – l’autrice è chirurga, presso l’Ospedale Civile – che non si lascia mai ridurre al protocollo né alla semplice procedura tecnica dell’intervento; confrontarsi con il corpo che attraversa le età della vita, nella relazione, densa di ricordi e significati sedimentati, con la madre che invecchia, così come in quella sempre in via di nuova definizione e anche per questo rigenerante con le figlie che, da bambine che erano, sono già donne.
Sono queste le coordinate principali entro cui si delinea il corso di un’esistenza che per dirsi non ricorre al romanzo autobiografico ma a una sequenza di racconti che rimandano uno all’altro in una medesima trama, entro l’orizzonte aperto di un tempo che solo la scrittura sa raggiungere. Una scrittura che sa aspettare in solitudine le parole che, sfuggendo all’inflazione e al brusio assordante delle molte che si pronunciano, sanno conservare traccia dei giorni, e far uscire dallo spazio del silenzio la voce che può tenere in vita la vita, nella sua unità profonda.
Come la pratica della corsa è seguita alla malattia, nascendo dalla “pressante richiesta del corpo che si era risvegliato, che voleva guarire, riprendere fiato, rimarginare le ferite, semplicemente esserci”, così la scrittura trova radice nel corpo: “Corsa e scrittura emergono dallo stesso magma profondo, alle volte oscuro, torbido, alle volte limpido e lieve. (…) Certi giorni la scrittura viene fluida, la penna corre da sola sulle righe e le parole corrispondono perfettamente a ciò che sento necessario dire. Altri giorni ricado nella scrittura analitica, indagatrice, anatomica. (…) Quando finisco in questo vortice sento la fatica, e ora ho imparato che devo lasciare, deporre la penna e infilare le scarpette. Nei giorni fortunati la corsa fa pulizia, opera una spoliazione, mi libera dalla verbosità. So che, quando spreco troppe parole, non ho chiaro ciò che va detto o obbedisco ad un vizio antico che mi allontana dalla verità.
Quando la corsa fa il suo lavoro, ricevo il grande dono dell’intuizione. Mentre sudo in salita, mi si spalanca davanti quella verità che mi aveva messa davanti al quaderno e dalla quale mi ero lasciata sviare. Limpida, pura, perfettamente ripulita dalle parole in eccesso, dalle parole viziate.”