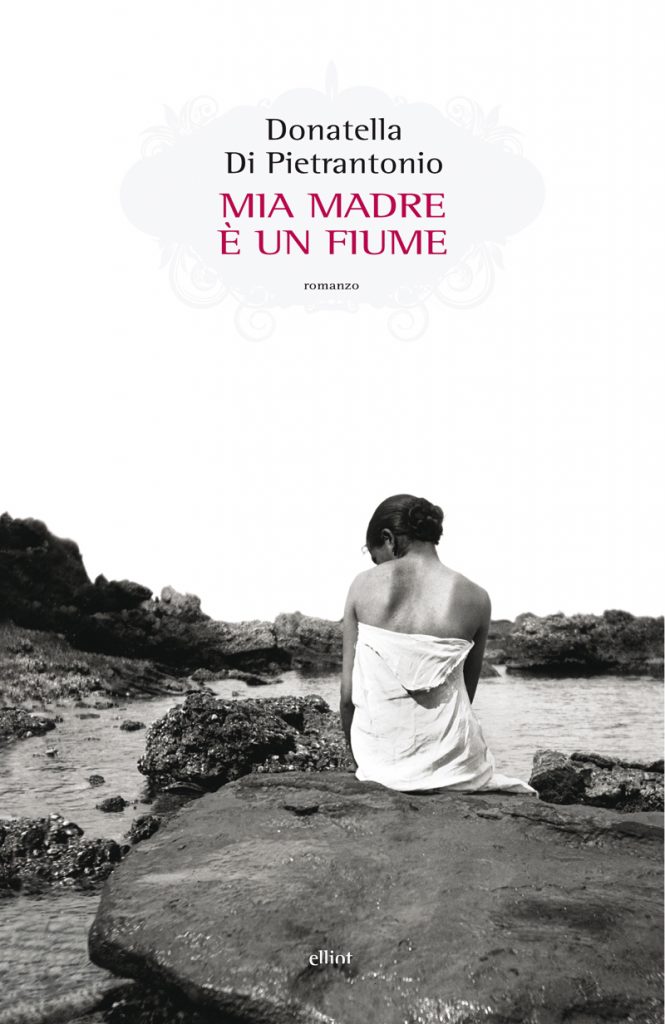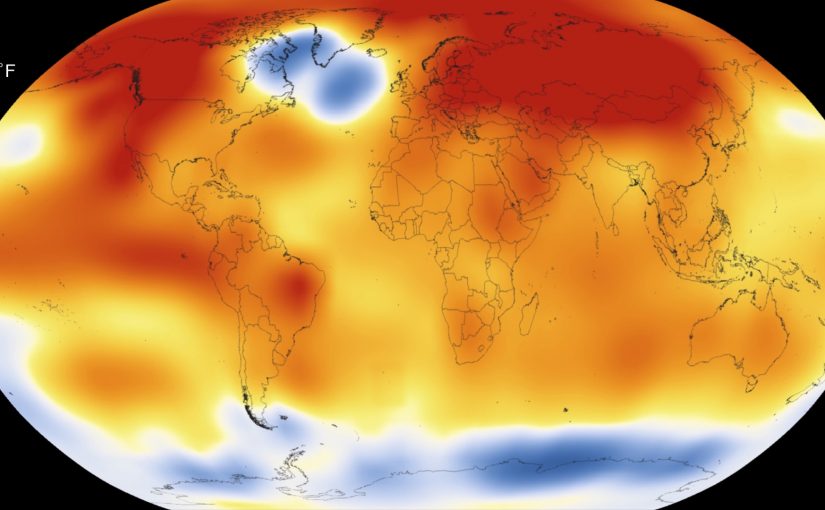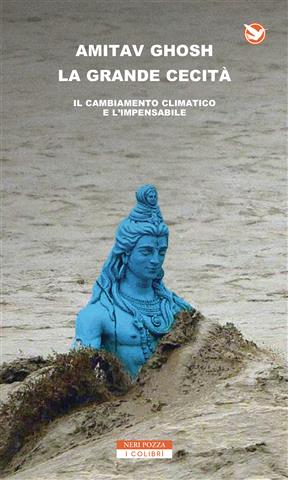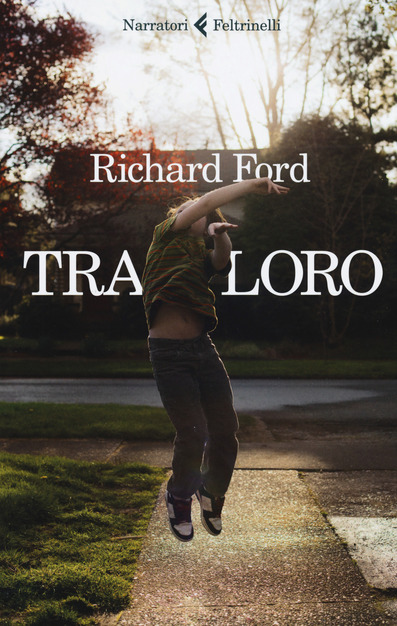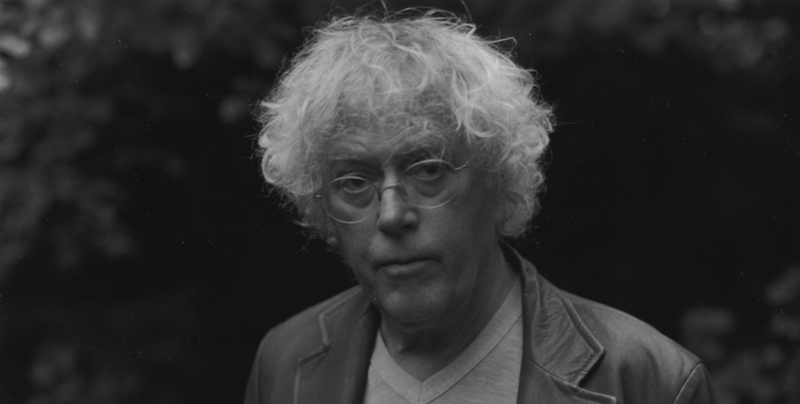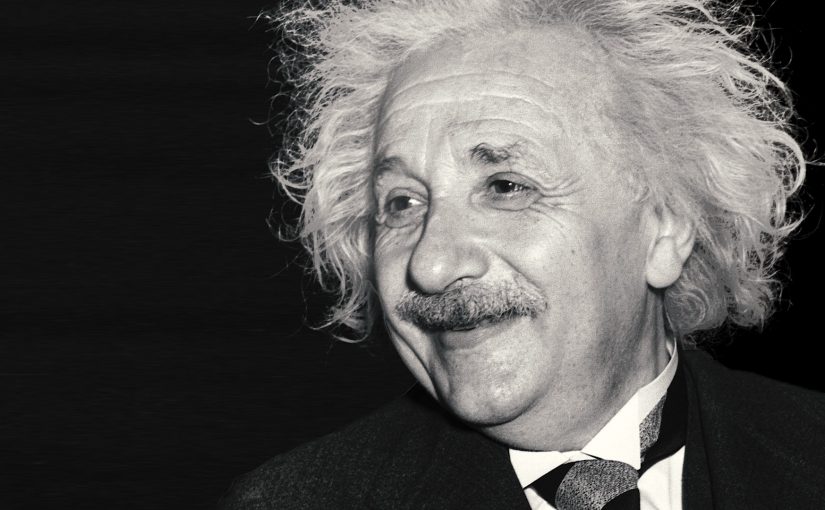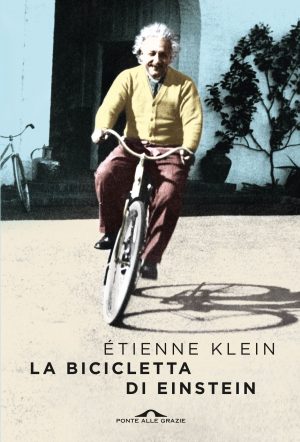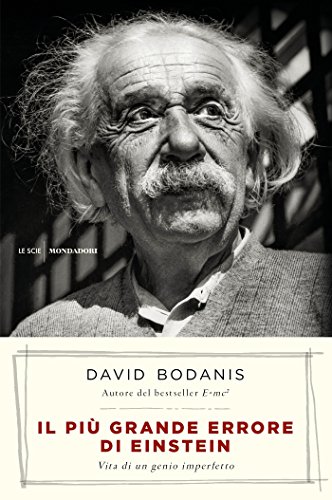Alfredo, pensionato flâneur, percorre ogni giorno la città con un’attenzione e una curiosità che gli permettono di trovarvi occasioni di incontro, momenti di scambio, ma anche di confrontarsi con atteggiamenti e mentalità che lo inducono a rifl essioni disincantate, non di rado perplesse o apertamente critiche e tuttavia mai inclini alla recriminazione o al risentimento.
Nelle sue passeggiate è a volte accompagnato dal nipotino, e la diff erenza d’età non sembra compromettere la sintonia del loro sguardo. Uno sguardo che potrebbe a volte richiamare quello di Marcovaldo, il cui creatore è non a caso esplicitamente richiamato in uno dei racconti. Anche Alfredo appare infatti sempre aperto al nuovo, al diverso, nella città di oggi emblematicamente rappresentato dallo straniero immigrato. Senonché, il protagonista di questi racconti non si guarda attorno cercando occasioni di evasione o insperate risorse che possano portare conforto alla
misera vita familiare. A richiamare l’attenzione di Alfredo sono piuttosto episodi e situazioni da cui ricavare cauti ma fondati giudizi su come va oggi il mondo.
Mai rinunciando, comunque, alla disposizione a credere che anche “una città infelice può contenere, magari solo per un istante, una città felice”, per quanto invisibile ai più.
—
Quelli che seguono sono brani tratti da alcuni dei racconti:
da Cerchio blu:
Se ci entri, alle 8, quando hanno appena aperto, cammini in strade che non sono strade. Perché non ci sono le vetrine. Son tutte chiuse, le serrande tirate giù. Come di notte, in città, che allora incontri solo qualche sbandato ogni tanto, ma soprattutto marocchini e neri. Sembra che ci siano solo loro.
Invece qui no. Loro non ci sono. Ci sono solo ragazzi se mai, che mangiano gelati e bevono cocacole e birre anche se sono appena passate le otto, di mattina. Fumano, e camminano camminano in queste strade che sono corridoi. Han bruciato. Non sono andati a scuola. Staranno qui tutta la mattina.
Una volta andavano in castello, i ragazzi che bruciavano. A girare per i viali e a giocare a flipper al bar che c’era là. Poi allo zoo, sui terrazzi delle torri a guardar giù… Ma adesso vengono qui. A anche se la mattina presto non ci sono ancora le vetrine illuminate, i tabelloni che dicono le offerte, le televisioni che fanno la pubblicità, e sembra tutto come il giorno dopo l’epifania. Perché qui è così: o è festa o niente. Non ci sono i giorni feriali. Solo domeniche, oppure è un mortorio.
Che se c’era un posto dove non c’era mai la domenica era proprio questo, perché i tubi li facevano sempre, giorno e notte, natale e pasqua. Facevano i turni, ma tu non vedevi niente perché non si poteva entrare e c’erano muri tutto intorno.
Adesso invece ci si passa dentro, anche senza comprare niente.
Cerchio blu, l’han chiamato. Dappertutto cerchi blu, per terra, sulle vetrine, sulle camicette delle commesse. E fuori, sul tetto, cerchi blu di neon, che li vedi a un chilometro.
(…)
Bè insomma, adesso saran tre mesi che passo sempre dentro. Non è che mi è passata del tutto di sentirmi un po’ un pollo d’allevamento a andar dentro, ma è che fuori è più triste. Lì dentro guardi e nessuno ti guarda, ma non ti spiace. Anzi. Anche tu non li guardi, gl’altri. Nessuno guarda nessuno.
Fuori, non hai niente da guardare, ma sei sempre lì che aspetti come di riconoscere qualcuno, o che qualcuno sia lui a salutarti.
Dentro, no. Ho visto uno che conoscevo, ma ho fatto finta di niente e ho guardato dritto avanti. Non è mica un posto da star lì a dirsi come va, quello lì. Massimo, un saluto con la mano, ma da lontano, senza fermarsi.
Il bianco con le bollicine costa quattro euro invece che due. Perché io la sera… mi piace bere un bianco prima di tornare a casa. Te lo fanno pagare il doppio. Però lì non ti resta sullo stomaco perché l’hai bevuto tutto in una volta per uscire subito perché il bar è vuoto e non c’è nessuno che conosci.
Lì dentro no. Te la prendi calma. Perché è normale non conoscere nessuno.
Quando hai bevuto molli il cine a colori e torni in quello in bianco e nero. È questo l’effetto che fa.
’Sera… ma lo dici a voce bassa, tanto lo sai che neanche ti sentono. C’è la musica sempre, lì dentro. Se per caso ti hanno sentito allora dicono buona giornata. Né buongiorno né buonasera: buona giornata. E non sai se l’han detto a te o a un altro.
Buona giornata. Anche se è già sera.
—
da Per leggere il giornale:
Io il giornale, a casa, non sono mica capace di leggerlo. Non so… mi sembra di non aver niente a che fare con quelle cose che leggo. O perché sono lontane – l’Iraq, la Corea… – o perché… magari non sono lontane ma è lo stesso: di quelle robe che si fa fatica a pensare che succedono qui da noi, in Italia. Bè insomma: se le leggo in casa mi sembra di essere scemo a prendermela per quelle cose lì. Se invece sono fuori, dove c’è dell’altra gente, allora mi sembra di fare il mio dovere a leggere il giornale, e ci provo anche gusto se c’è qualcuno da dire due parole. Leggere il giornale fa parlare, delle volte. Perché è raro che qualcuno racconti qualcosa, se no. Una volta succedeva, ma adesso… E è un bel po’ che a me sembra che non succede più. Raccontavano una volta. Mica tutti ma ce n’erano: cose che c’hai a che fare anche tu e se le ascolti magari dici anche tu la tua. Ma siccome oggi non succede bisogna trovare qualcosa per parlare, qualcosa che non è né mio né tuo né suo, ma un po’ è di tutti, e delle volte le notizie sono così. Non importa se sono da ridere o se fanno arrabbiare, che poi la maggior parte fanno arrabbiare. Che conta è che tu magari leggi una notizia a alta voce… non occorre un discorso, basta mezza parola, anche solo la faccia che fai, e un altro butta lì una parola, e tu allora un’altra e via, si parla. Non mi importa che quello la pensi come me. Certo se è uno come te, che vedo che legge anche lui la repubblica, va meglio. Però, delle volte, ascolto quelli che stanno dall’altra parte e mi fanno pensare, perché più andiamo avanti e più mi pare che ci sono cose che pensiamo anche noi come loro, se vuoi che te lo dica. E questa è già una cosa che fa pensare. E non ce ne accorgiamo se continuiamo a parlarci solo fra noi, e anzi: crediamo di essere sempre i più forti, quelli che la vedono giusta. Speciali addirittura, noi. Invece, a ascoltare come la vedono gli altri, anche quando dà fastidio, primo: capisci che sono tantissimi. Di più di noi. E poi senti delle cose che, ecco, ti fanno pensare che non si può continuare a dire le cose come le dicevamo trent’anni fa, mica perché sono sbagliate eh: io non sono mica uno di quelli che dicono che ci vuole il nuovo e i giovani e insomma bisogna buttar via tutto, figuriamoci. Però… va a finire che a parlare solo fra noi convinci solo quelli che sono già convinti.
—
da Sentieri in città:
(…) la caccia ai sentieri. Era una gara: chi li vedeva per primo, e lui teneva il conto. Bastava andare in qualche giardino pubblico e c’era da divertirsi. Dove c’era un vialetto che faceva una curva potevi giurarci che trovavi il sentierino che tagliava dritto. Al campo militare, che adesso non è più per i soldati, ci vanno a correre tutti, lo sapevo che c’era un sentiero che lo tagliava esattamente a metà. Il più lungo che avessi mai visto: l’ho lasciato scoprire al Luigino…
Dopo è venuto che, non che il gioco ci avesse stufato, ma lui ha cominciato con le domande: quanto saranno vecchi? c’erano già prima che mettessero l’asfalto sulle strade?
A me è sembrato di rispondergli che sì, mi sembravano vecchissimi, di più delle strade asfaltate. Non so perché ho detto così: mi faceva piacere pensare che nella città di oggi ci fossero i segni di dove camminavamo in quell’altra che non c’è più. La città dove si andava solo a piedi, niente macchine, solo cavalli se mai. La città dove i passi lasciavano il segno, non come sull’asfalto. O sul cemento. Anche se il Luigino, una volta che parlavamo di questa cosa, mi ha portato a vedere un marciapiede vicino a casa sua dove si vedono le orme di un cane: passato quando il cemento era ancora fresco, mi ha spiegato.
(…)
Lui, questa cosa delle impronte gli interessava molto, ci ragionava su. Un giorno che eravamo alla fontana dei giardini e c’era un piccolino col padre che gli faceva andare la barca telecomandata – e intanto il figlio guardava Luigino che tirava sassolini nella vasca e si era dimenticato della barca e non ascoltava più il padre che gli diceva come si faceva a guidarla – il Luigino ha detto che la barca lascia come una specie di orma, ma lunga.
Una scia, gli ho detto io.
Sì, proprio, come quella che lasciano gli sci.
Ero lì che pensavo alla scia e agli sci, e lui ha fatto: anche in piscina, quando vado a nuotare, ci faccio la scia. Però non dura.
E qui lui è saltato fuori con una di quelle che bisognerebbe scrivere: i sentieri sono le scie dei passi, ha detto, serio come è lui quando proprio in quel momento sta capendo qualcosa. Ma non era finita: sono le scie che fanno i passi per far sapere agli altri che siamo passati di lì e dunque anche loro possono passarci.
Ordini
![]() Se vuoi leggere il libro nella sua interezza lo puoi acquistare alla nuova libreria Rinascita di Brescia (12 euro).
Se vuoi leggere il libro nella sua interezza lo puoi acquistare alla nuova libreria Rinascita di Brescia (12 euro).
Via della Posta, 7 – 25121, Brescia
Tel. 0303755394
libri@nlr.plus
Se vuoi riceverlo a casa puoi inoltrare il tuo ordine indirizzandolo a: ordini@secondorizzonte.it
e segnalando l’avvenuto versamento dell’importo indicato tramite bonifico sul conto corrente della libreria (IBAN: Unipol Banca – Agenzia di Brescia: IT 10 B 031 2711 20000000000 1851).
La spedizione non comporta aggravi di spesa.
Recensioni
Dal Giornale di Brescia del 16 novembre 2017.
Clicca sull’immagine per visualizzare l’articolo.
Dal Corriere della Sera Brescia del 23 novembre 2017.
Clicca sull’immagine per visualizzare l’articolo.
Da Bresciaoggi del 28 dicembre 2017.
Clicca sull’immagine per visualizzare l’articolo.