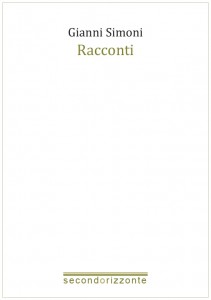Il campanello di casa emise un timidissimo squillo, come se fosse stato sfiorato per errore.
Petri, che si era appena seduto col giornale aperto, alzò un sopracciglio. Forse si era sbagliato, non aspettava nessuno. Continuò a sfogliare il giornale e fece per accendersi una sigaretta. Le aveva dimenticate nella tasca della giacca che aveva appesa nell’armadio in ingresso. Si alzò e andò a prenderle e stava facendo scattare l’accendino quando udì bussare piano alla porta. Se non si fosse trovato lì, certo non avrebbe sentito. Due o tre colpetti lievissimi, come di chi, con grande discrezione, non voglia disturbare o sia convinto che in casa non ci sia nessuno.
Bussarono di nuovo e lui, con la sigaretta che gli penzolava dal labbro, socchiuse la porta, trovandosi di fronte a un viso femminile che gli diceva sicuramente qualcosa, ma che non riusciva a collocare esattamente.
Lei colse immediatamente la sua perplessità.
“Non mi riconosce dottor Petri? Sono Carla Gualazzini, la proprietaria di Minou… è vero che sono passati parecchi mesi ma…”.
“Cara signora” esclamò Petri “certo che la riconosco, è il suo splendido aspetto che per un momento mi aveva ingannato, mi scusi, volevo dire che lei mi pare la sorella minore della signora che ho conosciuto qualche mese fa, non che allora mi fosse sembrata più anziana, ma…” e, come qualche volta gli accadeva, si infilò in una complicatissima spiegazione, fatta di distinguo e di precisazioni, dalla quale non sarebbe più riuscito a districarsi se la vedova, che lo ascoltava sorridendo, non fosse venuta in suo soccorso.
“Lei è troppo gentile dottore: mi pare di capire che mi trova ringiovanita (e Petri assentì convinto) e la cosa non può che farmi piacere. In fin dei conti sono una donna e tutte le donne sono sensibili ai complimenti… Ma potrei ricambiarglieli, anche lei ha un ottimo aspetto. Evidentemente il tempo che passa fa bene ad entrambi…”.
Petri si era ammutolito e continuava a non credere ai suoi occhi, perché quella che aveva di fronte era davvero un’altra persona, che pareva più giovane di dieci o quindici anni rispetto a quella che lui ricordava, che lo aveva fatto ammattire per la scomparsa di Minou, la sua gatta, e che non aveva più avuto occasione di incontrare.
Si riscosse rendendosi conto che la stava tenendo sulla porta e la invitò ad entrare.
“Grazie dottore, non vorrei disturbarla…” disse la signora e lui pensò che in questo caso avrebbe anche potuto risparmiarsi dal suonare il campanello e dal bussare alla porta.
“Ma cosa dice? Disturbarmi? Stavo giusto per prepararmi un caffè e se posso…”.
“Grazie, lo accetto volentieri” rispose lei che evidentemente non aspettava altro e si lasciò guidare in soggiorno, sedendosi compostamente sulla poltrona che lui le indicava.
“Mi scusi un momento, vado a preparare la caffettiera”. Lo fece con la massima attenzione, a scanso di brutte figure e ricordò che le tazzine buone stavano di là, ma si sentiva imbarazzato a tornarci per prenderle. Decise che le tazze che usava con Anna potevano andar bene e, dopo aver acceso il fornello, tornò in soggiorno, sedendosi a sua volta.
“Un paio di minuti ed è pronto”.
La signora assentì sorridendo, mentre lui ora la considerava con maggior attenzione. A parte l’abbigliamento, decisamente elegante e quasi giovanile, era il viso, l’acconciatura dei capelli, il loro colore (li ricordava argentei, raccolti a crocchia) a sconcertarlo. Perché adesso i capelli erano biondo cenere, anche se la crocchia era rimasta ma sottolineata da un paio di spilloni, e gli occhi azzurri spiccavano in un volto quasi privo di rughe, con la pelle di una sfumatura che gli parve dorata. Un vero miracolo, pensò, mentre il suo sguardo, senza volerlo, si abbassava sulle gambe della sua ospite, che erano raccolte di sghembo, in una postura che gli parve particolarmente aggraziata.
Cinquant’anni, non di più, dimostra cinquant’anni questo diavolo di donna, stava pensando lui che ancora non si capacitava di quella trasformazione.
“Il caffè” disse lei.
“Come dice?” chiese Petri.
“Il caffè” ripeté la vedova Gualazzini, “temo che stia debordando…”
Petri ritornò tra i vivi: la moka, la si poteva sentire attraverso la porta, brontolava incollerita e un puzzo di bruciato aveva invaso il soggiorno.
“Accidenti a me” gridò Petri balzando dalla poltrona “credo di aver combinato un guaio.”
Non si sbagliava. Il caffè era uscito quasi del tutto dalla moka, colando sul piano di cottura e spegnendo la fiamma.
“Addio caffè…” mormorò sconsolato davanti a quel mezzo disastro e si guardò in giro: un’altra caffettiera c’era sicuramente e la trovò subito, nel credenzino di sinistra. Solo che la cucina a gas avrebbe dovuto essere ripulita, così come i beccucci del fornello e stava pensando a come organizzarsi, non trovando di meglio, per il momento, che spalancare la finestra, quando, dietro di sé sentì la voce della signora Carla.
“Uomini…” disse con voce soave, ”se ogni tanto non combinaste qualche guaio non sareste così simpatici… Permette che faccia io?”.
“Gliene sarei gratissimo signora” rispose lui e le porse la nuova caffettiera. Il barattolo del caffè era rimasto sul tavolo.
“Lei adesso se ne va di là e si mette comodo in poltrona. Penso a tutto io… tranquillo, trovo anche le tazze, so dove le tiene sua moglie”.
Se ne tornò in soggiorno un po’ mortificato. Lo imbarazzava anche quello strano tono confidenziale della vedova che, come il suo aspetto, gli era del tutto sconosciuto. Poi capì di essere stato trattato con la benevolenza che si usa con un bambino maldestro e pensò di avere destato il senso materno della signora Carla. L’una ipotesi valeva l’altra e nessuna delle due aumentò la sua autostima.
La vedova entrò in punta di piedi: aveva scovato anche un vassoio che posò su un tavolino.
Petri aveva precipitosamente schiacciato il mozzicone nel posacenere.
“Ma che fa dottore…” disse lei, “non avrà per caso spento la sigaretta per me? E’ in casa sua e… no, no” proseguì zittendo Petri che stava per interromperla “non intendevo dire che può fumare per questa ragione, mi farebbe un torto a pensarlo, è che il fumo non mi dà più il minimo fastidio… sono le stranezze della vita. Tollero benissimo il fumo e, non lo indovinerebbe mai, sono diventata allergica ai gatti: inizio a starnutire e non c’è verso di porvi rimedio…”.
“E Minou?” chiese Petri.
“Ho dovuto disfarmene purtroppo, non le dico la sofferenza, ma a un certo punto o io o lei, non ho avuto scelta… l’ho affidata alla signora del secondo piano…”
“Capisco…” mormorò Petri, chiedendosi le ragioni per cui quell’allergia non le fosse sorta qualche mese prima, con buona pace sua, della vedova, di Minou e magari di qualcun altro, col pensiero che gli tornava a due bambini col grembiulino azzurro nel cui abbaino Minou, vagando sui tetti si era rifugiata. Trovandovi vitto e alloggio.
“Purtroppo questa volta mi è accaduto qualcosa di molto più grave…” disse dopo un momento di silenzio la donna, che aveva aspettato inutilmente un suo incoraggiamento.
Petri, infatti, bevuto il caffè e forte del lasciapassare appena ricevuto, si era acceso una sigaretta e se la stava fumando piano, in attesa della nuova tegola che gli sarebbe caduta in testa, certo com’era che l’inaspettata visita della sua vicina non preludesse a nulla di buono.
Fu la vedova a riprendere il discorso.
“Questa volta dottore non si tratta di una banalità come la volta scorsa…”e Petri si rabbuiò, perché la scomparsa della gatta, per come gliel’aveva presentata la Gualazzini, tutto gli era parso fuor che una banalità. L’avrebbe volentieri strozzata.
“Questa volta si tratta del mio Fattori, lo ricorda dottor Petri?”.
“Il lanciere a cavallo” disse lui che ricordava benissimo quella delizia. “Non mi dica che è scomparso anche lui…”.
“Purtroppo sì dottore, mi è stato rubato”.
“E quando ha subito il furto? Immagino che i ladri non si siano limitati al Fattori…”.
“E invece è andata proprio così. E’ sparito il Fattori e nient’altro”.
Petri rimase un momento perplesso.
“Allora si tratta di un furto su commissione, di un furto estremamente mirato, non v’è dubbio,perché anche ammettendo che si trattasse di ladri qualificati non ci si frega un Fattori lasciando intatto un Signorini appeso all’altra parete, perché il Signorini almeno lo hanno lasciato mi pare…”.
“Certamente e la cosa aveva dato da pensare anche a me, ma forse una spiegazione l’ho trovata”.
“Vale a dire?”.
“Il Fattori era una tavoletta quindici per venti, qualcosa che si può nascondere anche sotto una giacca, mentre il Signorini no, è una tela di tutt’altre dimensioni….non pare anche a lei?”.
“Non so che dire: può essere, ma la cosa non mi convince. Se una tela è troppo ingombrante, adesso le misure non me le ricordo, i ladri la sfilano o addirittura la tagliano e l’arrotolano, non c’è bisogno di portarsi via il quadro incorniciato…E inoltre dovremmo pensare a un collezionista di Fattori, un collezionista particolarmente esclusivo… tutto può essere,ma mi sembra improbabile…Piuttosto, mi dica come sono entrati: hanno scassinato la porta o sono passati dal balcone? E il furto è avvenuto di giorno o di notte? A proposito, non mi ha ancora detto quando è avvenuto il furto, spero che lo abbia immediatamente denunciato..”.
“Il furto risale a una decina di giorni fa, ma la denunzia non l’ho ancora fatta…”.
“Ma cosa aspetta, benedetta donna?”esclamò Petri. “Che speranze può avere di ritrovarlo se non presenta la denuncia? Era almeno assicurato?”.
“Si, inizialmente per una bazzecola: trenta milioni, che credo non siano neanche un decimo del suo valore. Si trattava di un’assicurazione che avevo fatto più di vent’anni fa, quando venne a mancare mio marito. Posso solo dire che nella disgrazia ho avuto un pizzico di fortuna, un presentimento forse, perché qualche mese fa, sobbarcandomi un premio non indifferente, ho aggiornato l’assicurazione, portandola a centomila euro per il Fattori e a centocinquantamila per il Signorini….anche se credo che si tratti di valori ancora inferiori a quelli reali…”.
“Si, ho capito, ho capito” la interruppe Petri che faticava a nascondere il suo disappunto “certo che adesso potrebbe valere anche il doppio, ma se lei non denunzia il furto non recupererà neanche quello. Mi vuole spiegare perché non l’ha ancora fatto? Abbia pazienza signora Guazzalini (Gualazzini, precisò lei senza che Petri se ne desse per inteso), abbia pazienza, capisco che per la gatta avesse ritegno a rivolgersi alla Polizia e abbia preferito parlare con me, ma in questo caso che cosa posso fare io? Mettermi a rincorrere tutti i ladri o i ricettatori della città o della regione? Siamo seri, queste sono cose che fa la Polizia, che magari per la scomparsa di un gatto le fa, mi scusi, una pernacchia, ma per il furto di un’opera d’arte ci si mette d’impegno. Lei invece fa passare dieci giorni e non trova niente di meglio da fare che venire da me. Non capisco, non capisco proprio…”.
“Ha ragione dottore, ha mille ragioni, ma non si inquieti, la prego: io da lei non sono venuta per chiederle di mettersi a fare delle indagini, non sono così sciocca. Da lei voglio solo un consiglio”.
“Un consiglio?” chiese Petri a bocca aperta. “Ma il consiglio gliel’ho già dato. Denunzi il furto, lo faccia subito, magari giustificando il ritardo col fatto che…veda un po’ lei come giustificarlo, questi sono affari suoi e non mi parrebbe corretto intromettermi, ma sulla denunzia immediata non ho dubbi. Se lei non denuncia il furto perde quadro e risarcimento assicurativo, questo mi pare chiaro. Se invece sporge la denunzia ne porta una copia alla sua assicurazione e, da una parte o dall’altra, qualcosa ottiene”.
La vedova Gualazzini rimase in silenzio un momento e poi fece un lungo sospiro.
Continua la lettura nel pdf: