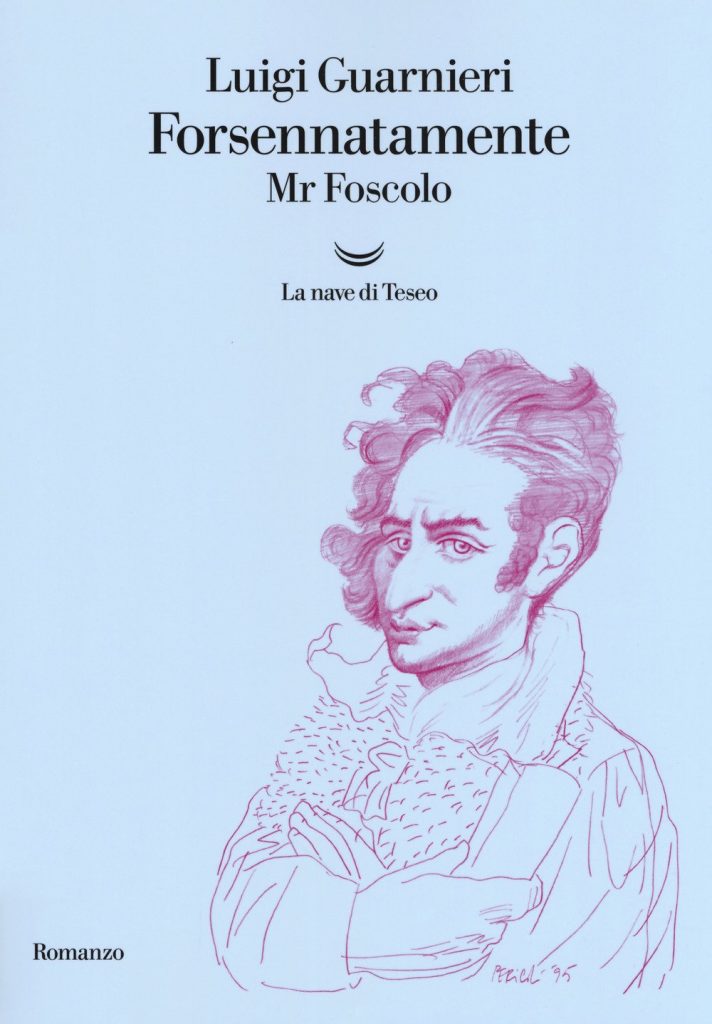
Luigi Guarnieri, Forsennatamente. Mr Foscolo, La nave di Teseo 2018 (pp. 205, euro 17)
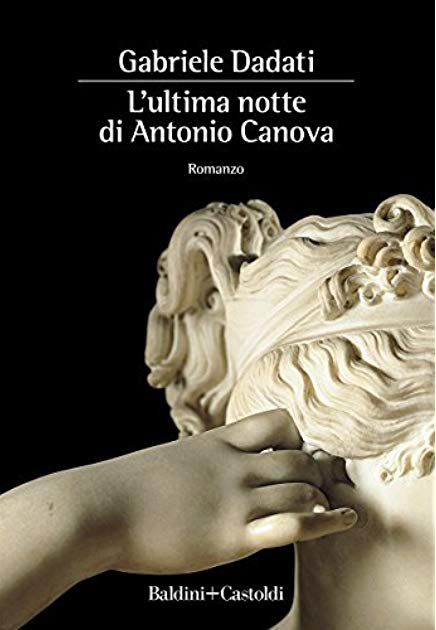
Gabriele Dadati, L’ultima notte di Canova, Baldini+Castoldi 2018 (pp. 343, euro 18)

Simona Baldelli, L’ultimo spartito di Rossini, Piemme 2018 (pp. 381, euro 18,50)
Che fosse antipatico di suo, pare accertato, e il giudizio era assodato anche prima che Gadda facesse del “vispo Nicoletto” il bersaglio del suo sarcasmo in Il Guerriero, l’Amazzone, lo Spirito della poesia nel verso immortale del Foscolo (Adelphi 2015), attribuendo al poeta “una prosopopea insopportabile e una cialtroneria da intrigante mandrillo”.
Non pare discostarsi da questo atteggiamento Luigi Guarnieri, che del trentottenne Niccolò Foscolo, detto Ugo, racconta gli anni dell’esilio a Londra: “attore istrionico e grande oratore”, “incanta e stupisce con la sua forsennata vivacità”; “agghindato alla moda del periodo come un dandy”, “ai ricevimenti e ai balli è un figura che s’impone: circondato dall’aureola della celebrità letteraria, scandaloso come lo saranno solo le rockstar negli anni Settanta del Ventesimo secolo, autore di un patetico romanzo di successo su un amore infelice [Le ultime lettere di Jacopo Ortis], è carismatico nel suo soprabito di panno azzurro coi bottoni dorati, il cappello di pelo di castoro…”.
Ma è, e sempre più si rivelerà, solo apparenza: l’uomo è malandato fisicamente, spendaccione e assediato dai debiti (fino a conoscere la prigione per insolvenza), impacciato dal suo poco e cattivo inglese, e dunque non può stupire che il suo ingegno sia “arrugginito dalle infermità e dai guai”. Nonostante la sua sgradevolezza è comunque per la sua sorte che il grand’uomo sollecita una solidale compassione nel lettore, dunque? No, al contrario: più la storia delle sue disgrazie e dei suoi mali procede, più si ha la sensazione che il racconto sottintenda un implicito ben gli sta. E non attenuano certo il giudizio i frequenti flash back che completano la biografia risalendo agli anni precedenti: Foscolo è da sempre sopra le righe, pieno di se stesso, autore di innumerevoli quanto “esaltate” lettere d’amore, profittatore e ambiguo nei rapporti sentimentali come in quelli con la figlia naturale e con i familiari lontani e sempre vanamente in attesa di un suo aiuto.
Com’è possibile che un uomo simile scriva quelli che Guarnieri stesso definisce “assoluti capolavori”, come Alla sera e A Zacinto? La domanda non si pone, la questione del rapporto fra l’uomo e la sua opera non pare proprio tra quelle che interessino Luigi Guarnieri: quello che si potrebbe ritenere un nodo ineludibile per chi scrive della vita di un artista pare ignorato. La biografia conferma lo stereotipo, e questo pare bastare. All’autore, quantomeno.
Diverso il risultato cui giunge un altro romanzo pure dedicato alla fine di un grande creatore. L’Antonio Canova che emerge dalle pagine di Dadati non è quello che avevamo già in mente. È un uomo che, giunto alle sue ultime ore, risponde al desiderio estremo di evocare il proprio passato e giudicare il proprio operato, senza paura del dolore che gliene verrà. I flash back, qui, sono conseguenza di questa volontà, e dunque risultano narrativamente necessari: ne escono scene vive dell’età napoleonica, personaggi non schiacciati sull’immagine codificata. A cominciare da Napoleone, protagonista della storia – insieme alla sua seconda consorte, Maria Luisa – al pari di Canova. L’uno e l’altro, l’imperatore e l’artista, accomunati dal destino di figli orfani del padre e di uomini che non avranno figli: “alberi senza radici, alberi senza fronde. In questo, dunque, da considerare fratelli”.
Uno sguardo disincantato e risolto sulla vita e sugli uomini attraversa l’intera narrazione, giungendo alla conclusione che “occorre imparare questo: ad aprire le mani, e lasciar andare i propri morti. Non bisogna trattenerli, dopo che hanno smesso di far parte di questo mondo, perché se no si vive in perenne tristezza.”
Romanzi biografici come questo sembrano smentire la convinzione di Borges secondo la quale “che un individuo voglia risvegliare in un altro individuo ricordi che non appartennero che ad un terzo, è un paradosso evidente.” Per cui, “realizzare in tutta tranquillità questo paradosso, (sarebbe) l’innocente volontà di ogni biografia.”

Lo stesso si potrebbe dire di un terzo romanzo nel quale è un musicista a vivere l’ultima stagione della propria vita, Gioacchino Rossini, evocato sulla base di una documentazione rigorosa e felicemente tradotta in racconto, secondo un metodo che l’autrice stessa richiama nella nota finale: “scrivere un romanzo, benché storico, non è solo inanellare aneddoti. Occorre trovare una crepa in cui infilarsi e, pur nel rispetto del personaggio, introdurre la propria voce”. La voce del narratore che cerca di stabilire un nesso credibile fra la vicenda umana e la produzione artistica dell’uomo: detto in altre parole, da dove viene la vocazione a divertire di Rossini, e da dove la sua perenne fragilità, la sua paura di veder crollare da un momento all’altro la sua straordinaria popolarità, le sue cadute frequenti nella depressione, in certi periodi non attenuata neanche dal gusto smodato della tavola? È già alla sua prima esibizione al fianco della mamma, cantante per necessità, che il settenne Gioacchino capisce che il pubblico vuole vedere gente allegra sul palcoscenico: lui “li avrebbe accontentati. Mai avrebbero saputo della carestia in casa, la tristezza della tavola vuota, del padre in galera e le mani della madre bucate dall’ago. (…) Avrebbe sorriso, sempre. A costo di fare la scimmia ammaestrata”. Ma lui è ben altro. Il Mozart e il Beethoven che escono dai quadri appesi alle pareti della sua camera di malato terminale dialogano con Rossini, il musicista che richiesto di dire chi fosse il più grande musicista di tutti i tempi rispose senza esitare: Beethoven, e alla sorpresa di chi gli aveva posto la domanda, al corrente come tutti della sua predilezione per Mozart aveva risposto, serafico: Mozart non è un musicista, Mozart è la musica.
