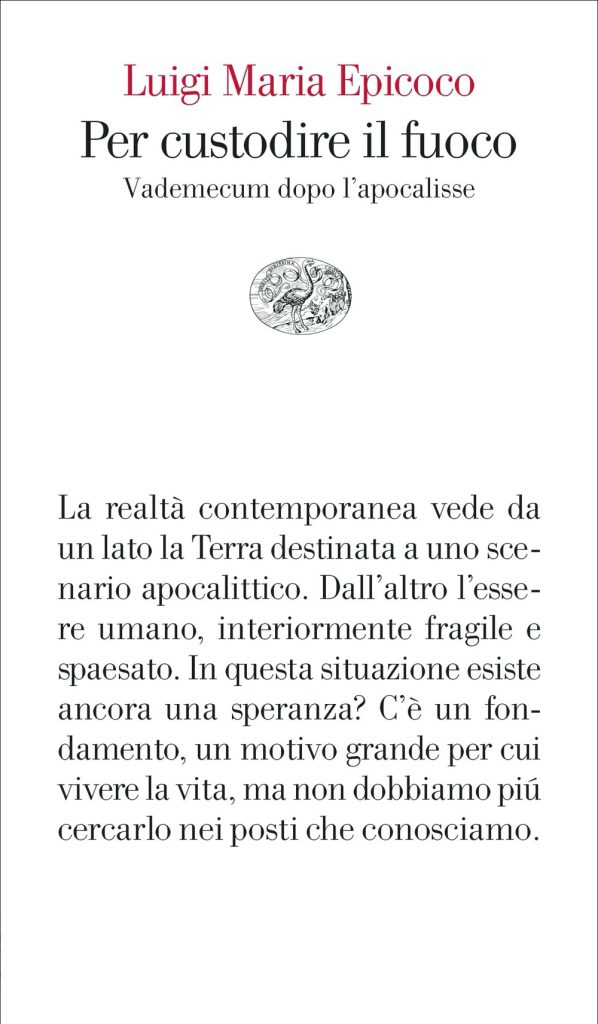
Luigi Maria Epicoco, Per custodire il fuoco. Vademecum dopo l’apocalisse, Einaudi 2023 (pp. 112, euro 12)
“La vita umana, quando perde il suo fuoco, è destinata a diventare fredda come la morte. Questa nostra epoca sembra aver smarrito il fuoco” ed essere quindi investita dal “freddo di una solitudine che, a macchia d’olio, sembra colpire molti uomini e donne dell’Occidente”, vittime della “religione dell’individualismo”. “Seppelliti dal consumismo”, siamo capaci solo di “trovare qualcosa che ci distragga da questa assenza di significato. Viviamo vite imprigionati in un eterno intrattenimento”, “appiattiti solo sulle questioni materiali”, cercando così di addomesticare la disperazione”.
Sicché si può dire che “il vero dramma contemporaneo è un dramma di alienazione: facciamo fatica a stare nel presente, ad abitare in maniera grata il qui e ora. Troppo spesso siamo imprigionati nella rete del nostro passato a lottare con cose non risolte che continuano a condizionarci la vita. Per tutta risposta ci proiettiamo nel futuro immaginando e sperando un mondo e una vita libera da ciò che ora ci ostacola. Ma la luce di questo futuro ci strappa dal presente, ci impedisce di esserci in questo istante”.
Fin qui siamo a constatazioni desolate quanto diffuse – basti pensare, fra le voci più ascoltate negli ultimi tempi, ai pamphlet di Byung-chul Han, come La società senza dolore, in queste note all’inizio del luglio 2023 –, ma la domanda che a questo punto l’autore pone obbliga a considerazioni ulteriori: “se tutto il mondo che conosciamo”, questo mondo insensato dominato dalla logica del consumo, “crollasse lasciando solo macerie e rovine? Che ne sarebbe di noi?”.
La risposta – come spesso capita quando ci si pone domande di questa portata – non va cercata in saggi argomentativi, ma nella letteratura, non certo in quella fatta solo per intrattenere, bensì in romanzi come La strada di Cormac McCarty. Pagine in cui “l’estetica e il senso si annodano” nello stimolare “una riflessione sulla nostra contemporaneità”. Nonostante la storia sia calata nel tempo “indecifrabile” di un mondo postapocalittico, “McCarty sta parlando della condizione umana, non del futuro del mondo” ma del nostro “mondo interiore”. “McCarty ci inchioda su una domanda decisiva: dentro di noi chi sta vincendo? Sta vincendo la morte o sta vincendo la vita?”, e il suo romanzo non si propone che di rintracciare il “fuoco” che balena nel buio fitto in cui i due sopravvissuti, padre e figlio, si trascinano.
Il fatto che l’autore sia un sacerdote, teologo e filosofo, non circoscrive il suo orizzonte, ed è lui stesso a chiarirlo fin dall’inizio: Dio “è propriamente un nome del Senso”. Il senso che cerca anche chi non è credente, così come la via sulla quale conviene cercarlo è quella dell’interiorità: “non una via confessionale”, perché “la via dell’interiorità (…) è la cifra del nostro essere umani e non del nostro essere credenti”. E, si avverte – a fugare qualsiasi sentore di soluzioni ireniche –, “l’interiorità non è un giardino ma un deserto pericoloso”: saperlo nonostante tutto abitare vuol dire poter “vivere la propria vita con gioia”. (Saper mantenere aperto un dialogo con il proprio inconscio – tradurrebbe lo psicanalista – è la condizione per evitare di vivere dominati dalle nevrosi, o peggio).

Privilegiare l’interiorità non significa tuttavia abdicare a un pensiero critico, ma anzi cogliere sotto diverse angolature il vicolo cieco che la nostra società sta percorrendo, e qui conviene affidarsi alle parole stesse che l’autore sa scegliere con cura esprimendo in modo determinato e persuasivo il proprio pensiero: “il nostro parlare è uno scambio di informazioni, ma non è più capacità di saper dare significato all’esperienza” e “abbiamo trasformato questa impossibilità in una rabbia che troppo spesso diventa violenza. (…) È la violenza di un popolo contro un altro popolo, ma è anche violenza domestica, che si alimenta per l’assenza di parole e il proliferare del risentimento”. Un risentimento che trae alimento anche dalla non accettazione della nostra finitudine: “Viviamo in una società che ha paura della morte e allo stesso tempo la accarezza”, in una prospettiva radicalmente nichilista in cui la vecchiaia si fa “rassegnazione che spalanca le porte alla morte delle cose”, che le destituisce di senso essendo il nostro destino quello di morire. E contro questo destino non si sa far altro che opporre pratiche illusoriamente capaci di allontanare la vecchiaia e la sua inevitabile conclusione, anziché porsi “la vera domanda [che] riguarda le nostre attese, non il nostro corpo”. Abbiano infatti “spostato sul corpo una questione che riguarda l’anima. (…) Combattiamo la morte cancellando il passaggio del tempo sul nostro corpo, ma non ci domandiamo quasi mai che cosa il tempo ha lasciato dentro di noi”, e così “aver cura di sé è una linea sottile che non di rado può diventare accanimento di sé”: “certe scelte che riguardano il nostro corpo sono il chiaro segno della fatica che facciamo a convivere con l’idea della morte. Invece non esiste nessun altro modo di fronteggiare la morte se non vivere, opporle una vita viva, non un semplice corpo”.
Contrastare questa deriva richiede innanzitutto il riconoscimento che “siamo esseri malati di Senso”, e dunque “la nostra vita non è vita finché non si aggrappa a un significato”, impegnata sempre in “questa ricerca, conscia o inconscia” che sia: “in un primo tempo cerchiamo questo significato fuori di noi. (…) Col passare del tempo però, ci accorgiamo che quel mondo in cui avevamo riposto la maggior parte delle nostre speranze non contiene nessun significato abbastanza affidabile da poterci salvare la vita. (…) quando ci accorgiamo dell’inconsistenza delle cose così come le avevamo immaginate, comincia a farsi spazio in noi una sorda disperazione (…) dapprima come una latente infelicità che comincia a rodere dall’interno i nostri giorni. Abbiamo la sensazione di vivere un presente appiattito, che non ha nessun futuro, nessuna promessa, nessuna speranza. (…) [Ma] Dovremmo smetterla di medicalizzare le nostre crisi e lasciare che esse ci mettano in cammino”. Perché “il problema non è essere infelici, ma capire cosa ci racconta la nostra infelicità. Molto spesso essa ci indica una via di redenzione, che non è mai il contrario di una condizione, bensì la scoperta di un modo di stare al mondo che prima ci era sconosciuto”. Senonché, “per poter entrare veramente dentro la realtà bisogna passare attraverso il lutto della nostra immaginazione. Quando ciò che avevamo disegnato sulla realtà tramonta, solo allora la realtà può emergere. Ma questo passaggio non è mai indolore. I detriti delle nostre speranze frantumate, delle nostre attese disattese, sembrano coprire la bellezza del mondo così com’è. (…) La disperazione altro non è che la morte della nostra immaginazione. (…) Ciò che prende il nome di ‘disillusione’, non è una cattiva notizia, ma è il primo passo per la nascita di un realismo gravido di significato”, perché “la realtà è ciò che è nascosto sotto i pezzi infranti delle nostre illusioni” e “la libertà è ciò che possiamo fare della nostra disperazione”.
Ma il discorso va oltre la sfera puramente individuale, perché “solo quando siamo infelici possiamo essere manovrati dagli altri, dal sistema, dalla cultura dominante, dalle ideologie, dalla dittatura delle cose. (…) Troppe volte siamo disposti a rinunciare ai nostri desideri pur di sentirci accettati da chi abbiamo intorno. Ma è un’illusione pensare che si è felici solo perché si è accettati (…). La felicità è la declinazione della nostra unicità”.
Seguire l’autore nel dialogo che puntualmente stabilisce fra La strada di McCarty e il Vangelo permette, in conclusione, di trarre da queste pagine riflessioni genuine, credibili, sperimentate. E capaci di misurarsi con la crisi che attraversa la nostra società, ridotta troppo spesso alla “semplice somma degli individui”, quando invece è “un luogo umano dove il noi allarga le possibilità di ogni singolo e rende possibile un bene che nessuno, da solo, sarebbe in grado di dare”. A patto che, questo spazio, “si struttur(i) sulla logica della compassione, cioè sulla logica di rimettere al centro la vita dell’altro, il suo volto concreto”. Sta a noi decidere se la società in cui viviamo debba essere una società egoistica, pura “proiezione delle istanze dell’individuo ripiegato su se stesso” o diventi invece “luogo di umanizzazione”.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.
